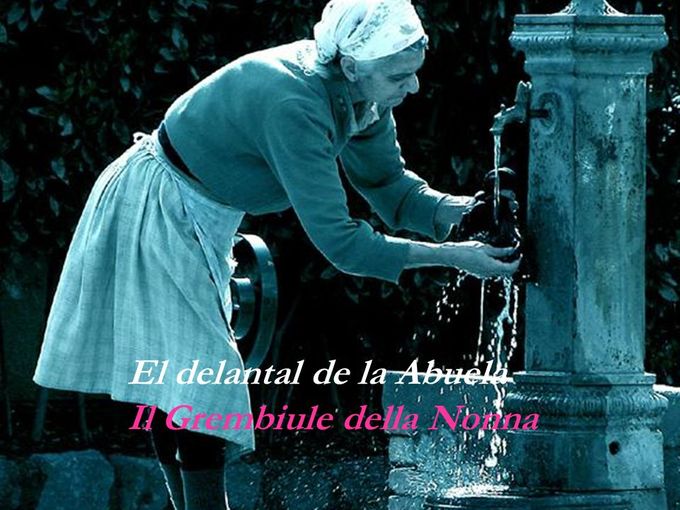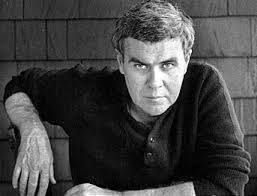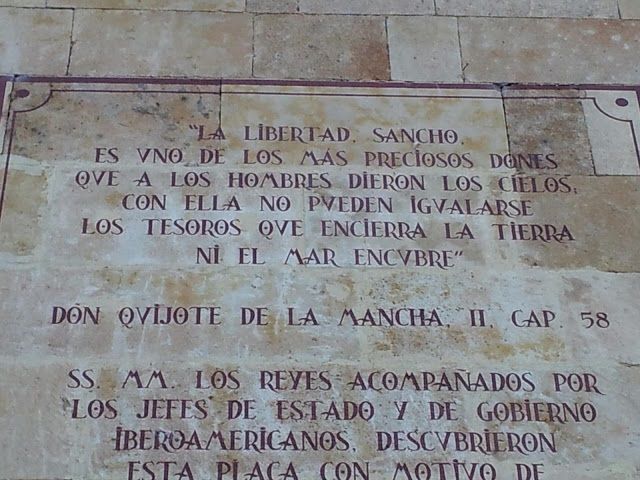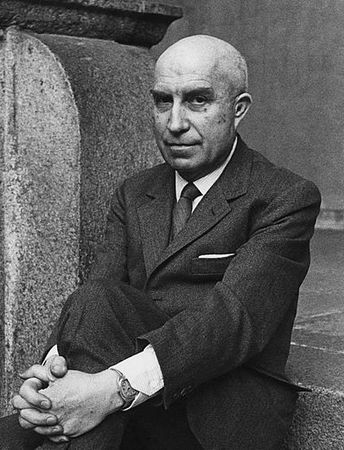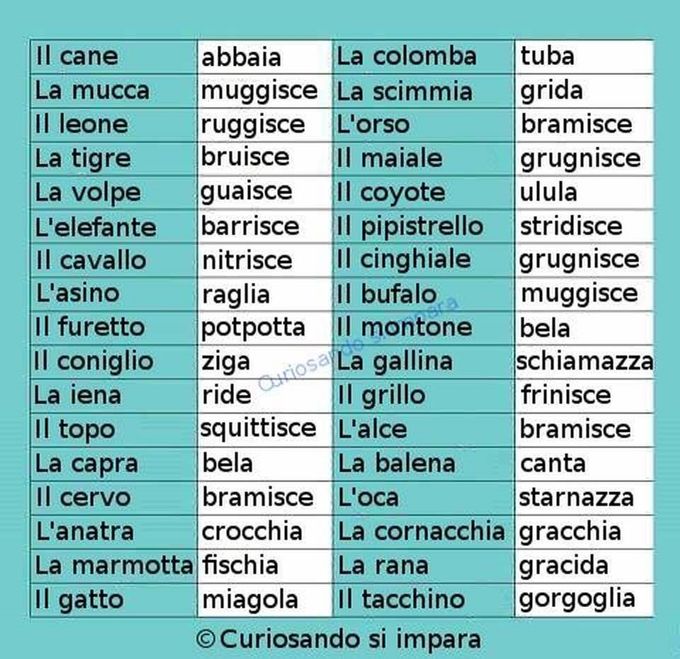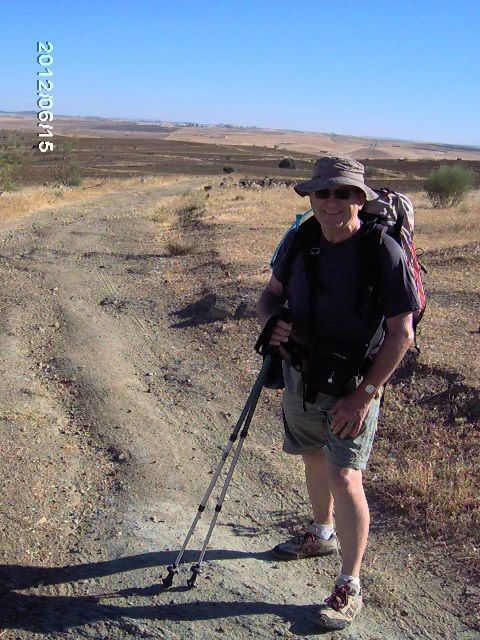L' asa da lavà: la lavatrice "semiautomatica" delle nostre nonne/mamme. Manca il "sebero" di legno o di metallo, ma prima o poi lo trovo.
GIULIANO PENSIERO 2.0
PRONTO SOCCORSO: Vorrei spezzare una lancia a favore del P.S. Tornato dal mare avevo un fastidioso mal di gola che molto presto si trasformò in raffreddore, poi tosse e quindi bronchite. Poi quando, su consiglio di un amico medico, provai a fare una lastra ai polmoni, scoprii di avere 38,9 di febbre. Tamponato negativo, mi sono presentato al P.S. con un legittimo turbamento, visto i tempi che corriamo e soprattutto una esperienza familiare negativa di un anno fa. Appena arrivato, l’infermiere dell’accettazione dopo avermi misurato la febbre, mi prese “in carico” e mi fece accomodare in un locale attiguo su di una sedia a rotelle. Questo locale dava proprio sull’ingresso dei ricoveri con le ambulanze. Era un continuo andirivieni di barelle, di lettighe con i ragazzi delle ambulanze che scaricavano pazienti, a volte meno pazienti, che venivano presi in considerazione dai vari infermieri che li smistavano a questo o quel posto di osservazione. Ero giunto li alle ore 11,30 circa, dopo una ora circa venne nuovamente una infermiera, questa volta, a misurarmi la febbre, mentre io rimanevo sempre in questo locale a osservare l’andirivieni delle lettighe delle ambulanze. Passava intanto il tempo, chiesi dove potevo trovare una bottiglia d’acqua, ma mi dissero che non vi erano distributori li, bisognava uscire dal P.S. ed andare nei reparti, ma mi venne sconsigliato. Mi venne in aiuto una ragazza bianco vestita che mi portò una bottiglietta di acqua anche fresca. Attorno alle 14,30 si presentò una giovane blu vestita, che, prima mi mise una “Farfalla” nel braccio destro, poi mi fece un prelievo di sangue, mi misurò la saturazione, la febbre, poi fece alcuni tamponi nasali e faringei, un prelievo arterioso “Le farò un po’ male”, poi mi condusse in un locale attiguo dove mi fecero una ecografia, dopo un mezz’ora mi vennero a riprendere per farmi le lastre RX al torace. Intanto venne sera e una voce mi disse che avrei dovuto trascorrere li la notte. “ Ma lei è digiuno?, vedo di procurare qualche cosa” e tornò con una porzione di pollo lesso delle verdure e uno iogurt agli agrumi di Sicilia. Poi un’altra persona mi comunicò che mi avrebbero trasferito in astanteria. La mia apprensione aumentava. Mi misero in un posto vicino al muro di questo reparto dove una tenda mi permetteva un minimo di privacy. Io ero vestito come ero arrivato: calzoni corti camicia e sneakers e onestamente sentivo freddo mentre fuori la temperatura sfiorava i 42°. In questo settore del’astanteria vi erano sei letti, tutti occupati. Arrivò un medico e mi disse che iniziava la terapia per un principio di polmonite. Mi attaccarono a delle flebo, antibiotici, paracetamolo e poi soluzione di glucosio. Si spensero le luci, rimaneva solo un’isola luminosa dove vegliavano dottori e infermiere, ma il P.S. non dormiva mai, si continuava ad operare, arrivavano pazienti portati dalle ambulanze, alcuni venivano portati ai reparti, i rumori erano ovattati. Qualcuno al buio si lamentava, qualcuno chiamava, qualcuno si avvicinava ai letti. Le mie flebo e i controlli si susseguirono giorno e notte. “Starà qui forse più di un giorno, si faccia portare qualche cosa, un pigiama”. Sono rimasto in quel locale per più di 60 ore, ma sempre accudito con umanità e professionalità. Una volta accertate le mie migliorate condizioni mi hanno dimesso con una terapia da fare a casa. Ora sto bene, tutto è passato, sono stato fortunato? Forse si. Ho trovato gente competente? obbiettivamente si, oggi il mio senso critico nei confronti del P.S. è decisamente migliorato e come sempre questo è il Giuliano pensiero. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
GIULIANO PENSIERO
Mi interesso solo marginalmente di calcio, mio padre era uno Juventino convinto, io di riflesso lo sono diventato. Ma oggi voglio dire la mia su Ronaldo Cristiano. Una volta tempo fa ascoltai un’intervista al grande Pelè, il quale ha giocato per quasi tutta la vita in una sola squadra il Santos, e si rammaricava per quei giocatori che quando cambiano squadra baciano la maglia e assicurano che fin da bambini speravano un giorno di poter far parte di quella compagine, e la storia si ripete ogni volta che cambiano casacca soprattutto di fronte ai tifosi e alla stampa mentre strizzano l’occhio al procuratore il quale sventola il bonifico. Ma purtroppo parecchi tifosi ci cascano tanto quando arrivano come quando partono. Faccio una digressione ma penso sia calzante. Ho vissuto una esperienza personale quando cedemmo il bar di Voghera e lo acquistarono persone dignitose e volonterose. Ma fra i clienti che ci incontravano per strada questi erano i commenti “Ma cosa vi è venuto in mente di cedere a quei sprovveduti, non sono del mestiere, si vede che sono principianti si inventano il lavoro di volta in volta…..ecc.ecc.” ma gli stessi per accattivarsi i nuovi gestori esordivano con “Era ora che si cambiasse un po’, si vedeva che non avevano più voglia, erano svogliati e assenti, stanchi e senza entusiasmo, aria nuova ci vuole”. Ecco mi sembra che la situazione assomigli molto: meno male che se sia andato, ci vogliono nuovi volti ecc. ecc.; ma se i risultati non vengono i medesimi poi si lamentano con chi lo ha lasciato andare. A proposito….i miei dopo quel locale aprirono altri tre esercizi commerciali. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
LA CASA NEL BOSCO: Superato il ruscello, ora c’è un ponticello, allora c’era un guado, bisogna superare una sbarra, ma siccome sono a piedi passo facilmente sotto. Si sale per alcuni tornanti, niente di che, mi ricordo di alcune scorciatoie che dimezzano la salita e finalmente vedo le case del villaggio. L’ultimo tratto è dritto e porta alle prime case, ma qui la memoria mi gioca un brutto scherzo, dov’é la pianta di pere e il portico, eppure da li parte un bivio con il sentiero per il vicino villaggio, per il resto tutto è sepolto dai cespugli, dall’edera, dalla vidalbora (clematis vitalba) che avvolgono tutto, piante arbusti e per superare questo muro verde bisogna inoltrarvisi come tuffandosi nel folto. Al di la però tutto appare più conosciuto, le case, le stalle i porticati. Ecco la nostra casa, la riconosco dalla piccola ringhiera di fronte al piano rialzato, il gelso “al muron” attorno al quale, grazie ad una seduta di sasso, alla sera ci si riuniva a chiacchierare. Ma anche qui il bosco sta fagocitando tutto, arbusti che sono diventate piante, erbacce che crescono dentro e fuori dalla casa, le finestre divelte dai soliti vandali paiono occhi orbi che guardano nel vuoto. Le altre case non sembrano meno fatiscenti della nostra, alcune hanno il tetto crollato, le porte scassinate, le finestre rotte. Sotto il portico marciscono delle balle di paglia e l’odore di marcio e di muffa riempie l’aria. Le stalle sono vuote piene di ragnatele, i topi di campagna fanno le loro tane nelle mangiatoie. Eppure qui c’era vita, ci abitavano sei famiglie più la nostra che però eravamo dei villeggianti, gente da vacanze estive, da fine settimana. Venivamo portati li alla fine delle scuole e a parte qualche rara puntatina al mare di Genova, e li restavamo sino alla vendemmia, un paio di calzoni corti con le bretelle, un paio di sandali o scarpe da tennis (chi l’ha mai visto un campo da tennis?!) e una canottiera e questo era il “dress code” delle nostre estati. Per il resto tutto era lasciato solo alla nostra fantasia, la capanna nel bosco, le scorpacciate di fichi e ciliegie a km. zero, anzi anche meno direttamente dalla pianta, la corsa con le carriole piacentine. Con gli altri due o tre e i miei fratelli forse eravamo in tutto 5 o 6 ma facevamo per trenta. L’attività principale era giocare e basta. Il sabato si metteva un “navasseu” una piccola bigoncia* piena d’acqua a scaldarsi al sole ed era la nostra Jacuzzi, strofinavamo gambe e braccia, ci cambiavano canottiera e mutande anche perché la domenica mattina si andava a Messa nella cappella sullo stradone in fondo valle. Ginocchia eternamente sbucciate, mani eternamente sporche di succo di more o di ciliegie quelle scure e dure, scarpe o sandali che alla fine dell’estate venivano buttate via tanto erano logore e rotte. Ora invece con mio grande disappunto tutto è stato inglobato nel bosco, qualche persiana sbatte cigolando, ma per il resto solo silenzio. Mi sono seduto sugli scalini della mia ex casa e sono rimasto li a guardare e pensare e ricacciare in gola il groppo che saliva. Sempre per bontà vostra GIU.BA. *Provate a chiedere a un giovane adolescente che cos’è una bigoncia, forse vi saprà dire che cos’è un account per vedere DZN, ma non che cos’è una bigoncia. “Che cosa vi siete persi ragazzi!!!!!!”
SEMPRE CONNESSI “Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità: il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti”? Frase attribuita ad Albert Einstein ma che oramai calza perfettamente all’attuale situazione da chiunque l’abbia pronunciata. Son stato qualche giorno al mare, erano anni che non abbiamo potuto andarci, i motivi erano tanti e gravi. Ma, pur avendo due nipoti ultratecnologiche, ho scoperto con raccapriccio che oramai l’uso e l’abuso dei telefonini è talmente diffuso che mi ha lasciato sconcertato. Su di una panchina sul lungomare, stanno sedute quattro ragazzotte, ognuna rapita dal proprio telefono, con gli occhi fissi a quel piccolo schermo azzurro, ognuna presa da quel piccolo mondo rinchiuso nel piccolo apparecchio. Ma cosa avranno sempre da scrivere o da dire. Una volta i ragazzi e le ragazze avevano sempre qualche cosa da dire, al mare poi c’erano i primi filarini, confidenze sussurrate, oggi silenzio completo. Due file dietro di noi vi erano due romani i quali avevano il vezzo di fare telefonate, ovviamente parlando ad alta voce, passeggiando avanti e indrè nel corridoio degli ombrelloni, per delle mezz’ore gridando e sbraitando, spaccando milioni,sparlando di questo o di quello al telefono:” Ma lo sai che quello è un cretino!!!!, mo ci penso io a dirgliene quattro” e l’altro pure, ho avuto persino il dubbio che si parlassero tra di loro pur essendo distanti di due sdraio. Con i piedi nell’acqua e il telefono all’orecchio, quindi non esiste più solo il “Milanese imbruttito”, ma anche il romano, il marchigiano il campano ecc. ecc. , gli ombrelloni mamme nonne figli e figlie, genitori e suoceri, tutti con il telefono in mano. A tavola poi se il o i pupi danno fastidio, basta aprire una app. di giochi e loro sono persi in questi mondi di orribili cartoni e video game, alcuni addirittura coricati sul pavimento del ristorante, mentre i genitori tubano e alla fine della cena non sanno nemmeno se i pargoli hanno ingurgitato qualche cosa, tanto poi ci sono gli snack velenosi a soddisfare la fame dei bimbi. Ma la cosa che mi da più fastidio è quando entrano in casa, fanno un grugnito di saluto e poi ognuno da una sua parte, sul divano o in cameretta a smanettare sul telefono, oppure ha rispondere a mille e mille messaggi. “Come và” risposta “Tutto bene” senza alzare lo sguardo dal telefono. Potresti uscire e tornare dopo due ore che non si accorgerebbero di nulla. Poi ci sono i messaggi vocali che vengono ascoltati tenendo il telefono di piatto vicino all’orecchio,a cui si risponde con un altro messaggio vocale, ma non era più pratico telefonarsi direttamente?? Mha capirlo…..Cari insegnanti/ docenti/professorie perché no, anche cari genitori, forse sarebbe bene chiedere meno tecnologia, meno lavagne multimediali ed inserire un’ora di conversazione tra gli studenti e alunni. Una volta la maestra gridava “SILENZIOOOO” ora dovrebbe gridare “PARLATEEEEE”. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
ODORI SMARRITI. Sono entrato in una stalla, una stalla di montagna, di quelle con cinque o sei bestie, mucche (pardon …..vacche, il prof. Bertoni docet) e buoi, ed improvvisamente mi sono trovato di fronte ad un odore che non sentivo da decenni: il letame e il liquame – la buca del rudo e il “giüsi” e con l’odore mi son tornati alla mente anche mille ricordi. La stalla della mia giovinezza, ad esempio, dove in estate come in inverno ospitava appunto quelle cinque o sei bestie, pazienti e ruminanti. O avuto a che fare, nella mia vita anche con i muli ed i cavalli, ma quelli erano odori diversi, odori penetranti sottili, acidi. Mia mamma quando tornavo in licenza, mi faceva spogliare in ascensore e metteva tutto in lavatrice senza nemmeno far passare tutta la mia roba per il cestone dei panni sporchi. Le mia scarpe, quelle della divisa, si distruggevano a causa delle deiezioni liquide dei cari equini. Ma non sono solo questi odori di stalla che mi mancano, odori smarriti e mai più ritrovati, troppi tanti e a volte mi chiedo se i miei nipoti, ma già i miei figli, avranno l’opportunità di sentire questi odori o se nella loro memoria olfattiva ce ne saranno altri da ricordare con piacere o anche con fastidio. Il cavolo che cuoce, la pelle delle arance o dei mandarini che abbrustoliscono sui cerchi della stufa a legna, il minestrone o le cipolle e l’aglio del soffritto. Salendo le scale di un albergo in un paese dell’est, venivo investito da un forte odore di soffritto di cipolla che usciva dalle camere, venni poi a sapere che alcuni ospiti provenienti da stati dell’ex Unione Sovietica, avevano il vezzo di cucinare in camera appestando tutto l’hotel di questi odori. Io mi ricordo invece con grande nostalgia quel profumo fresco di latte e di panna quando la mitica mantecatrice “Carpigiani” (ma anche la concorrente Cattabriga) mescolava gli ingredienti che sarebbero diventati poi fresca crema gelato e mio padre o mio nonno con il lungo bastone-spatola, lo estraevano e lo sistemavano nelle sorbettiere e, prima di pulirlo, mi permettevano con un dito di provarne il sapore (controllo qualità) di quello che era rimasto attaccato al bastone. Sapori e odori smarriti, e a voi quali sono i vostri odori smarriti, quelli che scatenano ricordi belli o brutti che siano. Vi saluto brava gente, sempre per bontà vostra GIU.BA.
L'UOMO CON I BAFFI
E’ stato un attimo, un passaggio stretto, una cortesia “prego passi lei”, un flash – ma io questo lo conosco – a questo punto nella mente si accende la memoria, come se fosse un computer dove vai a cercare documenti e immagini e cominci a scartabellare tra i file quel volto, quella faccia. Certo di anni ne sono passati – quaranta - ha baffi e capelli radi e bianchi, grosso modo della mia età. Eppure è lui, stessa maniera di camminare ma dove lo ho già incontrato e la tua memoria inizia un viaggio a ritroso, indietro, indietro sino a un punto, ecco la scuola militare di Spoleto, ma certo è lui, ma come si chiamava, non me lo ricordo, dormiva in un letto a castello accanto al mio e il suo compagno di branda invece si chiamava Volpe o Volpi ed era pugliese, ma lui come si chiamava?? “ io quel tizio lo conosco!!” “ma lascia stare, ti sarà sembrato” “mica tanto, ne sono quasi certo, lo conosco”. Era marchigiano o abruzzese, infatti diceva lu dito e io per prenderlo in giro mi infilavo un dito in un orecchio e ripetevo “l’udito” ma lui mi faceva vedere l’indice e diceva “lu dito”. Se era marchigiano o abruzzese è possibile che venga in vacanza qui, vicino a casa, ma ora come faccio a saperlo. Cominciai così a pensare come avvicinarlo e chiedere “scusi se la disturbo ma lei per caso ha fatto la scuola militare a Spoleto??” oppure “ mi pare di conoscerla ma lei è stato militare a Spoleto?” mi imbarazzava un po’ fermare un persona per strada e fare domande, così come un vucumprà. Però era un pensiero fisso, ogni tanto mi tornava in mente. Così ho cominciato a sperare di vederlo ancora, passeggiare con la moglie – presumo – sul lungomare per potere imprimere bene nella mia mente le sue sembianze e confrontarle con quelle della mia memoria. Sono tornato da Santiago con alcune vesciche ai piedi e una fastidiosa tendinite alla gamba destra e mi dava giovamento camminare in riva al mare con i piedi nell’acqua e, proprio in una di queste passeggiate, me lo ritrovai davanti a me nel mentre si dirigeva verso degli ombrelloni e sdraio per riposarsi, lo guardai da lontano per identificare quale fosse il suo posto, ma ancora mi mancava l’ardire di andare da lui e fargli le domande che avrebbero spazzato il campo da dubbi, ma, mi chiedevo, e se non fosse lui e che veramente ho avuto un abbaglio che figura faccio. Tornai dalla mia passeggiata sulla sabbia tra queste domande ed incertezze. La mattina successiva mi preparai mentalmente e psicologicamente, deciso a risolvere la situazione e senza dire niente mi incamminai lungo la spiaggia sino al bagno con gli ombrelloni gialli dove avevo visto quel uomo con i baffi andarsi a sedere, mi feci coraggio e mi inoltrai tra le sdraio, tra signore occupate a rosolarsi al sole e mariti all’ombra a leggere il giornale. Avevo fissato mentalmente la zona, quarta fila di ombrelloni a sinistra salendo dal mare, le prime due sdraio della fila. Arrivai e scoprii che a quel posto c’erano una corpulenta ragazzina che stava divorando un metro quadro di focaccia e l’altrettanto corpulenta madre che mi guardavano perplesse, mi guardai attorno, forse ho sbagliato fila è quella dopo, ma nemmeno li niente. Passava il bagnino “scusi ma qui non c’era un signore con i baffi” “certo ma sino a ieri sera, oggi è tornato a casa”. Delusione, ma anche un certo sollievo, e se mi fossi sbagliato, ma se fosse stato veramente lui quando mai mi capiterà nuovamente l’occasione di incontrarlo. Tornai verso il mare, misi gli occhiali da sole e stetti li a guardare l’orizzonte con l’acqua sino alle ginocchia senza pensare più a niente fischiettando sottovoce “sapore di sale”. Sono cose che capitano d’estate e alla mia età, ricordi lontani che sfumano nel tempo. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
XAVIER CUGAT
XAVIER CUGAT E la sua orchestra di ritmi afro-cubani. Nel 1962 nel programma “il signore delle 21” sul piccolo schermo, di chi allora possedeva la TV, apparve questo signore di origini spagnole ma cubano d’adozione e residente negli States, con una orchestra di una trentina di elementi, una sessione fiati da far paura e una musica che sino ad allora avevamo sentito solo nei film. Presentava Ernesto Calindri, in smoking nero e farfallino. E lo presentava proprio così:” Ed ora Xavier Cugat e la sua orchestra di ritmi afro-cubani”. E vai di sambe, cha cha cha, salsa e merengue, Sway, Tequila, Brasil, Besame mucho, Papa loves mambo, La cumparsita, el Cumbanchero ecc. ecc. Lui impassibile e sorridente con due baffetti da “sparviero” ogni tanto appariva anche con un minuscolo chihuahau bianco in braccio e la bacchetta nell’altra mano. Perez Prado era di la a da venire. E dall’orchestra al momento giusto c’era un grido “HUA” oppure “TEQUILA”. Ma quello che mandava in ebollizione gli ormoni di noi ragazzini era la moglie di Cugat la mitica Abbe Lane, una lunga e sinuosa cubana sempre fasciata in abiti di lamè con frange che si muovevano al ritmo della musica e da uno spacco abissale ogni tanto usciva una castigatissima gamba ma tanto bastava alla fantasia. Penso che si siano ispirati a lei per disegnare Jessica Rabbit la rossa moglie di Roger Rabbit. La tele al Bar Roma di Voghera (anni ’60) era posta sopra il retro banco e il piccolo spazio dedicato, in inverno, alla clientela ribolliva come una pentola a pressione emanando vapori e odori. Ma quando in scena appariva la signora Cugat tutti si zittivano e allungavano il collo. E lei ballava e cantava come i personaggi di Paolo Conte in Boogie :“i fiati si muovevano come palmizi al vento e lei aveva occhi da lupa e i due sapevano a memoria dove volevano arrivare”. Sarà stata anche l’età nostra (mia) ma a pensarci ancora mi viene il magone dalla felicità vissuta. Altro che, bastava Xavier Cugat e la sua orchestra di ritmi afro-cubani e si partiva per nuovi orizzonti e altre atmosfere. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
P.S. Quando sento alcuni dei nuovi cantanti ora di moda dire “noi abbiamo fatto la storia della musica italiana", non so se piangere o mandarli a…….ciapà i rat.
notti magiche
IL TOUR
Mi piace seguire il ciclismo, mi piace vedere i posti dove i corridori si cimentano, in Italia al Giro, in Francia al Tour. Mi piace il volo dei droni e degli elicotteri sui paesi che mano a mano si incontrano,castelli, paesi, case e un mondo verde. Resto stupefatto dai progressi che la tecnologia ha fatto tanto sui corridori stessi come sul ciclismo in generale. Mio padre, juventino DOC, era ben conosciuto da Fausto Coppi. Infatti quando a Voghera si doveva cambiare per chi proveniente da Milano e si doveva andare ad Alessandria, Coppi scendeva alla stazione e veniva al bar di mio padre, proprio li di fronte, ed attendeva che da Novi una vettura venisse a prenderlo. Nel frattempo mio padre e lui si scambiavano sorrisi, battute e complimenti ovviamente circondati dall’affetto dei presenti ben lieti di dividere quei pochi minuti con il Campionissimo. La sua improvvisa morte ci raggelò e ci lascio stupiti ed increduli. Ora quando vedo i nuovi campione del pedale, come si diceva una volta, resto basito tanto dalle bici, oramai dei supermodelli, leggere, aerodinamiche, mentre i corridori, pezzi di marcantoni, forniti di radioline con auricolari sono sempre in contatto con le ammiraglie che li seguono, hanno attorno al torace uno strumento che controlla il battito cardiaco e lo trasmette al medico della squadra se ci mai fosse una discrepanza. Oggi un corridore si è liberato della mantellina antiacqua e l’ha buttato nel fosso, mentre il telecronista era affranto dal gesto facendo notare che era un oggetto di particolare valore, una siffatta mantellina nel fosso?! I droni identificano, nel gruppo, questo e quel corridore ed immediatamente sullo schermo appare un cerchietto che lo evidenza con la sua foto a margine dello schermo. Altro che Bartali nella canzone di Paolo Conte. Mio zio (il fratello di mio nonno) stupito davanti alla televisione, che lui chiamava la “radio clas veada” avrebbe detto:” Indè c’andruma a finì”. Me lo domando oggi anche io.
“Farà piacere un bel mazzo di rose
E anche il rumore che fa il cellophane
Ma una birra fa gola di più In questo giorno appiccicoso di caucciù
Sono seduto in cima a un paracarro
E sto pensando agli affari miei
Tra una moto e l'altra c'è un gran silenzio
Che descriverti non saprei
Oh, quanta strada nei miei sandali
Quanta ne avrà fatta Bartali
Quel naso triste come una salita
Quegli occhi allegri da italiano in gita”
Bartali di Paolo Conte
PASSI LUNGHI E BEN DISTESI. Era il 4 giugno del 2006, il mio cammino mi stava portando a Pamplona, ma già da Burlando, una frazione della capitale della Navarra, malgrado fosse la mattina presto della domenica, il bellissimo parco fluvial era animato da tantissime persone che correvano o semplicemente camminavano. In tuta e scarpette da ginnastica percorrevano queste stradine del parco che costeggia il fiume Arga. Non ero ancora abituato a questo tipo di attività ludica, anzi mi sembrava tutto molto strano, da noi in Italia allora solo pochissimi e rarissimi personaggi facevano jogging. “Il jogging, detto anche footing, è un passeggio in forma di corsa a passo lento. Lo scopo principale dell'attività è aumentare il benessere fisico di chi la intraprende senza però subire lo stress derivato dalla corsa vera e propria, che è più veloce. È un'attività ludico sportiva principalmente amatoriale”. Ma veniamo ai giorni nostri. Da più di un anno siamo costretti a convivere con questa pandemia che oltre a privarci di alcune libertà ci ha anche privato di alcuni amici. Abbiamo attraversato lookdown, zone rosse, arancio, gialle e finalmente bianche. A dire la verità a parte il lookdown, durante le altre colorazioni, la mia vita cambiava di poco, con la necessità di fare passeggiare il cane potevo anche fare puntate nelle immediate vicinanze. Ebbene, soprattutto nelle domeniche pomeriggio, quando mi recavo nella valletta così detta del Fontanone, trovavo gente che correva, che camminava da soli o in piccoli gruppi, tutti mascherarti, tutti a debita distanza, se avevano la mascherina abbassata nel incrociarti la indossavano correttamente salutando da lontano eccetera. Ma ultimamente, da quando siamo passati in zona gialla e poi in bianca, la strada che solitamente percorro da Via Vigorelli sino a via Castel del Lupo è tornata deserta, come se tutti quelli che la popolavano prima avessero trovato meglio da fare. Così mi capita di passare tutto il tempo senza incontrare anima viva, non è che mi dispiaccia, però godo di questa mia solitudine che così mi piaceva e che mi piace ancora sin da quando ero viandante, pellegrino in giro per i sentieri di Spagna. “Noi siamo viandanti, non camminatori. Siamo le creature della via, della strada aperta, degli incroci, delle curve, delle soste. Lo siamo anche quando non camminiamo. Perché dal cammino non si fa ritorno. Non abbiamo più fatto ritorno dal nostro primo cammino. Una parte di noi è rimasta in qualche bosco, presa in qualche corteccia, appesa a qualche ramo. Noi intuiamo, senza riuscire a razionalizzarlo, di essere parte di quella cosa chiamata «viandanza»: una vita nuova, una soglia, un’altra dimensione in cui le nostre fantasticherie di sognatori diurni si realizzano. Noi siamo pochi, siamo una minoranza. Ci riconosciamo subito. Ci passiamo parole sottobanco. Ci pensiamo in silenzio. Non amiamo i decaloghi. Chiamiamo i nostri zaini per nome”. (Luigi Nacci - Il Cammino). Sempre per bontà vostra GIU.BA.
ED E’ SUBITO ESTATE: Mi sono distratto un attimo, colpa del COVID, ed è subito estate. E’ andata così, mi stavo recando in un posto in mezzo alle vigne, un posto ubertoso (altra parola desueta) nel fondo di una valletta, quando tra un pensiero ed un altro e una mini lepre che veniva inseguita dalla cagnetta, mi sono accorto che oltre ai rotoloni d’erba posteggiati in mezzo ai campi, quel verde e giallo che si muoveva non era lisca secca ma grano. “E’ quasi maturo, ma allora è estate!!!”. Mi sono incamminato sul campo appena tagliato di erba circumnavigando quello di grano, fra lo stupore di un agricoltore che stava per far partire l’irrigazione del granoturco sparando in cielo uno spruzzo di acqua che ricadendo in mille piccole gocce creava un arcobaleno artificiale. Lunedì 21 giugno, solstizio d’estate, ore 5,32, da quel momento saranno legittimate le sortite notturne delle zanzare, ma anche il caldo e tutti quei segnali latenti che creano una atmosfera estiva. Chi non ama l’estate? La stagione che preferisco è l’autunno per i suoi colori, i suoi profumi di muschio e di funghi……ma l’estate!!!! Arriva sinuosa, pigra come una bella addormentata nei pomeriggi bollenti d’agosto, languida appena sudata, con le tende che si gonfiano colme di brezza, quando anche la campagna è impigrita e si sentono solo le cicale frinire nella vampa estiva. Voglia di acqua e limone, di fresco, di onda e di risacca che rinfreschi la mente e che ci purifichi dalla nebbia e dal freddo umido degli inverni Padani. Arriva l’estate e le piazze di paese restano vuote, deserte, solo sotto le tende dei caffè all’aperto pochi temerari affrontano la siesta pisolando sulle sedie con la testa che ciondola. La sera nei cortili, sotto i bersò di uva alienga o americana, che mano a mano prende colore per esplodere poi verso fine agosto nelle sfumature profumate di blu e di viola, le chiacchiere al buio davanti all’uscio di casa, sventolando ventagli e picchiando manate sul collo e sulle braccia, facili prede delle zanzare, unica croce delle notti estive. Poi finalmente a letto nella speranza che verso mattina un refolo di vento faccia rabbrividire la pelle e che ci obblighi a coprirci con un lenzuolo unica fresca cortina leggera ma mai sufficientemente. Mi sono distratto un attimo ed è subito estate. Spegni il computer, tira le tende, crea penombra e poi lascia che i tuoi pensieri vadano oltre il campo di grano e di meliga sino al limitar della ferrovia a riscattare una intelligenza schiava. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
IL PADRE DELLA SPOSA
IL PADRE DELLA SPOSA
Questo pezzo lo scrissi per la prima volta il 23 ottobre 1991, quindi quasi trent’anni fa, oggi lo voglio riscrivere con lo spirito attuale e lo voglio dedicare agli amici Domenica e Gianni e Patrizia e Franco che stanno per vivere questa esperienza. Questa volta tocca a me! Dopo aver sorriso per le peripezie di Walter Matthau in “Appuntamento al Plaza” e Spencer Tracy(nel 1950) e Steve Martin (nel 1991) nei film appunto “Il padre della sposa”, il fatidico giorno del “papà mi sposo” è arrivato anche per me. Se la cosa era nell’aria da tempo, d’altra parte , come tutti i genitori, suppongo, speravo che questo momento di distacco arrivasse il più tardi possibile. Mi immaginavo anche una formale richiesta della mano di mia figlia, ma c’è una tale confidenza con il mio futuro genero, che la cosa è stata superata senza queste formalità, probabilmente imbarazzanti per entrambi. Il guaio è che dal momento della fatidica frase in casa è scoppiata l’”emergenza sposi”. Le donne di casa cuciono e ricamano; si sfilano le lenzuola per prepararle per il punto a giorno,quadro, erba, paglia e fieno, ecc. “C’è da fare tutto”, per fortuna che ci ha dato un anno di tempo ma la frase che più mi sconvolge è “la gà gnent”. Ma come “gnent”! Un’ampia fetta dell’armadio quattro stagioni è occupata da pile di scatole Bassetti, Zucchi, Gabel, Perofilo e la pila l’ho vista crescere paurosamente da almeno vent’anni a questa parte, tant’è che ogni volta che erroneamente apro le ante dell’armadio temo mi rovini addosso la dote travolgendomi: “PADRE DELLA SPOSA TRAVOLTO DALLA DOTE, SI DISPERA DI TROVARE IL CORPO, I FAMIGLIARI SONO STATI AVVERTITI”. C’è anche da risolvere il mistero della coperta di Piquet. Non lasciatevi ingannare: il noto pilota di Formula1, non è diventato commerciante di tessuti e telerie da casa(a Buffon non è andata meravigliosamente) ma la coperta di piquet è quell’accessorio indispensabile ad un matrimonio. Ma che camera da letto in ottone e mobili laccati veneziani, ma che cucina “Spadolini” la più amata dagli italiani, importante è la coperta di piquet. La si userà una sola volta nella vita, quando è da stabilire, ma la si userà, punto e basta! Inutile replicare e bho! Mi sovvengono allora le decine di lenzuola con bordure in chiacchierino, (o come dice oggi mia nipote Cecilia chiacchiericcio), che ammiccano dai cassetti del comò desiderose di essere adoperate, ma impietosamente ed immancabilmente sostituite dal solito telo Bassetti verde a pois bianchi e viceversa. La dote e la sua preparazione sono un rito antico e crudele che getta scompiglio e nello sgomento in più di una famiglia. Ma ciò che fa tremare maggiormente è il pranzo di nozze. Si dice che oramai la gente non ami più andare a tali pranzi da durate bibliche che sono più stressanti di una giornata lavorativa, che oramai si mangia in maniera festaiola tutti i giorni e la domenica è occasione di fare dieta, si imbastisce uno spuntino, due cosine, un grissino e via. Gli agnolotti si mangiano anche durante la settimana e non si rincorrono più le occasioni nuziali per fare pantagrueliche mangiate e bevute. Parrebbe (dico parrebbe) che oggi per festeggiare gli sposi basti un rinfresco, uno spuntino in piedi, tartinaggio, due canapès al salmone , risottino finale allo champagne, vino anche in bicchieri di plastica con retrogusto macero poliestere, torta, confetti, saluti agli sposi e via. NIENTE DI PIU’ FALSO, QUESTO E’ QUELLO CHE SPERANO I CONSUOCERI. Ma ecco la descrizione di un pranzo nuziale, diciamo, normale. I parenti prossimi d’accordo. Il gruppo più vorace ed assetato è quello degli amici, 50/100 circa i quali dopo aver spolverato tutto ciò che c’era di commestibile nel menù, ma anche negli immediati paraggi, si aggiravano famelici attorno al buffet. Due camerieri risultavano dispersi, mentre un altro da quel giorno viene soprannominato “brass mucc” ovvero il monco. Solitamente verso la fine del pasto i due consuoceri avvicinandosi alla cassa, fingono cordialità e signorile indifferenza, ma hanno poi avuto un attimo di sbandamento dinnanzi alla scrivania del direttore. Il capo cameriere terrorizzato gridava:”Chiedono due spaghi aglio e olio, tonno con cipolle e ovviamente champagne” “ma hanno già mangiato la torta ed il gelato???” dicevano sgomenti i due consuoceri sconvolti da tutto ciò ma anche dal conto. Resto con l’amletico dubbio, fare o non fare il pranzo. Che decidano gli sposi e buonanotte! Nel frattempo ho ripreso a fumare la pipa – che mi da tono autorevole – leggo il giornale guardando di sottecchi il laborioso affaccendamento delle donne. L’unica a non soffrire del trambusto pare proprio la sposa che, oggi come ieri, riempie la casa con le sue risate e la sua energia e vitalità. Chissà quanto mi mancherà. GIU.BA.
Il tempo dei pomodori (ma anche degli spaghetti): Dopo il “tempo delle mele” ecco appropinquarsi (parola desueta) il tempo dei pomodori, ma anche dell’insalata, carote ravanelli ecc. ecc. Chi ha un fazzoletto di terra, ma anche chi pur non avendolo di proprietà ha in uso un piccolo appezzamento di terreno, ma anche un terrazzo piccolo o grande che sia, ecco giunta l’ora della semina. Vango ergo sum. Tutti a vangare a zappettare diserbare, potare, innaffiare ecc. ecc.. Tutti davanti agli espositori delle sementi a cercare quale sarà la semente giusta, il pisello nano o rampicante, meglio nano non bisogna imbacchettarlo e il ravanello, un po’ indigesto ma fa tanto colore nell’ insalata. Il pomodoro, c’è gente che ne pianta talmente tanti che a un certo punto non riesce più a disfarsene, i parenti e i vicini non aprono neanche più la porta se vedono dallo spioncino la faccia sorridente ma che nasconde tra le mani l’ennesima borsa di pomodori. Poi c’è il rito della salsa. Conosco una famiglia di amici che sul finire dell’estate approntano nel cortile di casa una specie di sabba dove in un pentolone mettono a cuocere,a scottare e poi a bollire, un bancale di pomodori e per tutto il giorno con un lavorio degno degli elfi di Babbo Natale, preparano, fanno passare il pomodoro in una macchina semi industriale che separa la polpa dalla pelle. Solitamente sono coinvolte una dozzina di persone che alla fine della giornata hanno preparato un quintalata di salsa di pomodoro. Una sera, passando da quelle parti mi sono permesso di far notare che con una spesa decisamente inferiore –materia prima, gas, luce, barattoli con coperchio ecc. senza contare le ore degli intervenuti – si sarebbero potuti comprare almeno il doppio di scatole di pelati passati o cubettati. Blasfemia!!!!! C’è stata una sommossa popolare e qualcuno stava già proponendo di mettermi all’interno del calderone dove bollivano i vasi di conserva, sono stato salvato all’ultimo dall’intervento di una persona autorevole che, con davanti un grembiule imbrattato di rosso come un macellaio, ha calmato gli animi. “ma vuoi mettere la salsa fatta da noi, il gusto primordiale del pomodoro fresco, il profumo del basilico, ecc.ecc.”.Per carità non voglio togliere anche questo ultimo piacere, semplicemente volevo far notare che le scatole di pelati sarebbero costate molto meno. Fui emarginato in un angolo del cortile, solitario e appartato, mentre aspettavo di ricondurre la mia augusta genitrice a casa. “E no!.... adesso si cena!” ovviamente spaghetti al pomodoro per tutti, zuppierone piene di rossi spaghetti, tutti attorno a tavole improvvisate i convenuti, con i piatti in mano e a me tornava in mente la scena di Totò in Miseria e Nobiltà in piedi sulla tavola e con gli spaghetti in tasca. Detto questo facciamoci “du spaghi”. Mi ricordo una volta sul Cammino Aragonese, assieme ad alcuni pellegrini spagnoli arrivammo in un meriggio “muy calientado” ad un rifugio, impossibile continuare con quel sole. L’ospitalera era una giovane ragazza e dopo un poco di insistenza acconsentì di prepararci della pasta. Recuperai del pomodoro (tomate frito, qui dovremmo aprire un dibattito*), tonno, delle olive, olio e aglio e cipolla. Mentre stavo preparando questo sugo improvvisato, mi scappò l’occhio sulla ragazza: aveva messo sul fuoco una pentola d’acqua e ancora fredda stava infilando nella pentola una manciata di spaghetti e una manciata di sale. Scattai in avanti e la bloccai: “Tieni dei bambini, chicos?” “Dos, due” “Brava , muy bien adesso vai a casa a guardare i tuoi bambini che alla pasta ci penso io”. Checco Zalone docet. Feci una pasta al tonno, olive e pomodoro che a qualcuno vengono ancora le lacrime agli occhi, compreso una spruzzata di parmigiano dimenticata da un connazionale in un angolo della cucina. Non fu ne la prima ne l’ultima volta che mi esibii in cucina. Una precauzione a chi capitasse: il tomate frito va comunque cucinato, olio aglio e cipolla da imbiondire, gli spagnoli lo mettono freddo sulla pasta stracotta (terrificante), per la pasta preferite la pasta Gallo che viene fatta a Barcellona ma con metodi italiani come dice il cognome dei titolari. Due spaghi a tutti e buon appetito. GIU.BA.
LA GOMMA DA CANCELLARE
Della mia infanzia ho pochi ricordi, il tempo li ha cancellati quasi tutti, mi ricordo vagamente che fui morso da un cane perché avevo infilato in un suo orecchio in ciuffetto di saggina quella per le scope. Finii all’ospedale per l’antirabbica. Ma un episodio mi è rimasto impresso nella mente, un ricordo indelebile, incancellabile, io sono andato a scuola un anno prima quindi a cinque anni appena compiuti e per far ciò mi iscrissero alla scuola delle Suore Benedettine. Primo giorno di scuola, mi accompagnò mio papà, salii titubante le scale e poi finalmente in classe con una suorina di cui non mi ricordo più il nome ma ricordo benissimo le sue mani secche e legnose come gli schiaffi che distribuiva a destra e a manca. Oggi chiamerebbero la Procura della Repubblica o quanto meno il Telefono Azzurro. La suorina una volta che fummo tutti entrati, chiuse la porta ed iniziò con l’appello e poi con la preghiera, ma mentre iniziava ad insegnarci la preghiera del mattino con cipiglio severo, si senti bussare alla porta dell’aula:” Avanti” gridò la suora e apparve la faccia di mio papà che chiedendo scusa mi portava una gomma da cancellare di quelle bicolore: “Scusi maestra, ma mi sono ricordato che nell’astuccio di mio figlio avevamo dimenticato di mettere la gomma da cancellare”. La suora parve essere percorsa da un brivido di terrore: ” Qui non si cancella nulla, la gomma non serve, se la riporti pure via” Mio padre arretrò, una mano sulla maniglia e l’altra che timidamente teneva fra le dita la famosa gomma. Allora a scuola si cominciava con i puntini, poi le lineette e poi dopo un mese circa cominciavamo a scrivere “uva”. Una fatica incredibile, volavano sberle e non mancavano le lacrime che cadevano sul foglio del quaderno. Eravamo praticamente sdraiati sul banco, gomito, mano, testa un solo corpo e guai ad essere mancini, la maestra dava il meglio di se nel cercare di correggere con urla e sberle quel che allora era considerato un difetto. Ma di tutto questo il mio ricordo ritorno al viso di mio padre, allora aveva 28 anni ed era un reduce dalla Russia ma sembrava più anziano della sua vera età, con la gomma in mano ed un sorriso timido nel cercare di vedermi ancora per un attimo, con la scusa della gomma, quale era il mio stato d’animo nel il mio primo passo verso la vita fuori di casa. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. IL PAPA’
E’ pronta la cena, corri!
Ti ho messo il caffè in frigo così quando torni, lo trovi freddo.
Non sarai un po’ leggera vestita così?
La prossima volta andrà meglio, vedrai.
Vai piano! Lo so che adesso ti manca e ti senti morire, ma passerà.
E’ un dolore infinito, ma sei più forte tu.
Mi vesto e arrivo.
Scegli una stella che te la vado a prendere.
Non chiamare il tecnico, vengo io.
Sei bella quando sorridi.
Questi occhi te li ho fatti proprio bene!
Tieni, mangialo tu. Io non ho più fame.
Sei sicura che va tutto bene?
Fatti una bella doccia, così ti riscaldi.
Dammi il trolley, lo porto io.
Parto un po’ prima, così quando arrivi mi trovi in stazione.
Questo vestito ti sta benissimo!
Non sono stanco, andiamo!
Vieni a pranzo, ti aspettiamo?
Fammi solo uno squillo quando arrivi così posso mettermi a dormire.
Vorrei vederti sempre felice, come adesso.
Ho sbagliato tante di quelle volte ma l’ho fatto soltanto per proteggerti.
Buonanotte.
A domani.
Quante volte i nostri papà ci hanno detto "Ti amo" senza che noi ce ne rendessimo conto.
GIU.BA.
Bianchin sprusà
L’EVOLUZIONE DEL BIANCHINO:
C’era una volta il bianchino, ovvero il calice di vino bianco, un modo di bere che ha accompagnato, ma accompagna ancora oggi gli italiani nell’evoluzione della moda del bere. Parlo per cognizione di causa, almeno per ciò che riguarda gli anni che dalla fine della II^ guerra mondiale arrivano ai giorni nostri, sono stato e me ne vanto, testimone diretto di questa evoluzione che ho seguito passo passo. Che cosa è cambiato appunto nella maniera di bere: siamo passati dalla quantità alla qualità, pur restando fondamentalmente fedeli al vino per ciò che riguarda le bevande edonistiche ovvero quelle che servono ad appagare il piacere del bere, ma non solo quello come vedremo in seguito. Appena finita la guerra l’ordinazione al bar, al di la del caffè, era principalmente per il calice di vino, bianco e rosso; allora c’erano persone che già di primo mattino bevevano il “pekar” definizione mutuata dall’austriaco, infatti i soldati di Cecco Beppe di stanza nel Lombardo Veneto all’osteria chiedevano un pekar, ovvero un quinto di litro, il bicchiere grosso. La colazione consisteva a volte anche in un caffè ed una grappa bianca, grigioverde o mandorlata-, oppure in un vermuttino o un marsalino. Ma la situazione di quegli anni purtroppo giustificava certe scelte diciamo alimentari, buona parte di coloro che lavoravano in ferrovia o nell’indotto ferroviario, stradini, scariolanti e fornaciai, quelli delle grandi acciaierie milanesi ma non solo quelli, dovevano combattere per tutto il giorno con il freddo e la nebbia (almeno d’inverno) lavorando all’aria aperta di giorno e di notte ma soprattutto sopportando una fatica fisica inimmaginabile ai nostri giorni, le massicciate di ghiaia grossa delle linee ferroviarie venivano fatte a mano con un forcone e una catena che aiutava a smuovere questa massa di sassi, e poi le traversine, e poi i binari, cose che viste con gli occhi di poi non possono che giustificare quei padri di famiglia che già all’alba si mettevano in corpo e spesso a stomaco vuoto, un quinto di vino bianco o rosso, grappa o marsala. Una leggenda metropolitana racconta che i bar delle stazioni di Lambrate e di Rogoredo preparassero sul bancone, di primo mattino, una lunga fila di cicchetti ”chupitos” di grappa bianca, mandorlata o grigio verde e gli operai bergamaschi e bresciani che scendevano dai treni si precipitavano a bere quell’ultimo bicchierino prima di fiondarsi nelle grandi fonderie milanesi. Il venerdì sera si pagava il conto. Ma poi le Falk hanno chiuso e anche le Redaelli e anche queste abitudini mattutine. Ma tornando alle mode ed al modo di bere il bianchino fu da sempre e resta tuttora in vetta all’indice di gradimento delle bevande da bar. Ma con gli anni e di fatto con una congiuntura favorevole, anche il vino cominciò ad ingentilirsi, dall’anonimo vino in bottiglione si passava a bere il “frizzantino” un po’ meno rude, più amabile, antesignano del prosecchino che veniva distribuito in mini bottigliette simili alle champagnotte. All’inizio degli anni 60’si incominciò ad aggiungere il bitter al bianchino, il mitico “biankin sprusà” lo spruzzato, a cui la gente dava nomi di fantasia come: la bicicletta, la minigonna, o il “mes e mes” da bersi in due ovvero mezzo bianco e mezzo campari soda. Leggendario è lo “spritz” bevuto nel Nord Est, ma ora diffuso in tutto il mondo, ovvero spumante, aperol, spruzzo di selz e fetta di arancio, un rito preserale oramai consolidato. A quel punto incominciò anche l’era dell’aperitivo, sino allora non ce ne era stato bisogno, la fame veniva comunque da sé, anzi era in abbondanza. Divennero di moda anche vini non più solo locali, come i bianchi dei Colli Romani, i vari spumanti, i vini veneti del Collio. Gli anni passano e anche l’evoluzione dei gusti della gente: corsi di degustazione, programmi televisivi, personaggi televisivi (Cracco, Canavacciuolo, Barbieri, Bastianich ecc.) i servizi di Bonsignore,ma anche di altri hanno di fatto insegnato alla gente a bere e magiare meglio, sostenuti ovviamente da un benessere diffuso, lontano cinquanta anni dall’inizio del nostro ragionamento Oggi vanno di moda i wine bar, le enoteche, la scelta di vino oramai è vastissima, il vino è uscito dalle osterie, dai bar di periferia e dalle bottiglierie, dai Trani milanesi per consolidarsi al top delle preferenze degli italiani. La dimostrazione sta anche nel fatto che appena usciti dalla zona rossa/arancio ci siamo fiondati nei bar per l’aperitivo. E se oggi al bar, durante l’happy hour chiediamo un bianco fermo e ci vediamo offrire quanto c’è di meglio fra i vini italiani da nord a sud, bianco o rosso, ricordiamoci di tutti quelli a cui il vino serviva per affrontare una giornata di lavoro, di fatica, di sacrificio, di fatto loro hanno contribuito al nostro benessere pagando anche con la salute e come non pensare a questo punto anche al vino come il secondo elemento, assieme al pane, della componente Eucaristica: il Corpo ed il Sangue di Gesù. E pensare che eravamo partiti con un bianchino………….vi saluto brava gente e prosit. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
La candida spia: Nonna siamo andati in un bello bar, io ho bevuto il Crodino ma il nonno ha bevuto un bianchetto. (Raffaella a quattro anni)
COME ALLEVARE LUMACHE E VIVERE FELICI: Dalla mattina avevo un forte dolore alla base dello sterno, vi parlo di parecchi anni fa, subito non feci caso, ma verso sera, dopo cena, in bicicletta decisi di fare una visita alla Croce Rossa di Casteggio approfittando del fatto che mia moglie era di turno li. Faceva caldo, non caldissimo eravamo all’inizio dell’estate, quindi in pantaloni corti, polo e infradito mi presentai alla sede della CRI. Per parecchie volte ero stato la voce narrante delle loro manifestazioni e mi conoscevano bene. Mi rivolsi al medico di turno e gli sottoposi questo mio sintomo. “Ti faccio un buscopan e poi vediamo, nel frattempo non muoverti di qui”. Passata una mezz’ora il dolore non mi era passato e il giovane medico decise su due piedi di mandarmi con un’auto all’ospedale per un elettrocardiogramma. A quel punto cominciai a essere un poco preoccupato e nervoso, avevo vissuto anni prima una situazione simile con mio padre. Arrivati in Pronto soccorso mi fecero subito l’elettrocardiogramma ma poi il medico di turno non volle refertare il risultato e mi ricoverò seduta stante in attesa, la mattina successiva, dello specialista. Io ero sempre in calzoni corti, polo e infradito. Riuscii a chiamare mia moglie e con la scusa dell’auto della CRI riuscì ad entrare, malgrado l’oramai ora tarda, e rifornirmi di pigiama. Io non ero felicissimo di passare la notte in ospedale e mostrai tutta la mia insofferenza agli infermieri e quasi al limite della scontrosità non volli indossare il pigiama ne tanto meno mettermi a letto. Mi sedetti in un salottino destinato alla visita parenti, ma poi il sonno e lo stress ebbero la meglio e acconsentii di sdraiarmi in un letto in una camera con altri tre pazienti. Una badante notturna andava e veniva tenendo d’occhio un paziente alla mia destra mentre gli altri due russavano sonoramente. Venne il mattino e nella attesa del medico feci conoscenza degli altri tre, ma quello che destò maggiore attenzione era quello alla mia destra, quello curato dalla badante, che poi scoprii curava più di un malato motivo del suo andare e venire, era un etilista oramai preda del delirium tremens, infatti aveva le allucinazioni come il bicchiere che lo mordeva e altre cose. Venne una signora con il cambio della biancheria, poi seppi che era la moglie, molto sbrigativa, dette la roba alla badante e se ne andò insalutata visitatrice. La badante lo lavò e lo cambiò, io avevo recuperato un giornale e a cavalcioni sul letto lo stavo leggendo, la badante mi chiese se potevo tenere d’occhio il suo assistito mentre lei si allontanava per un quarto d’ora. “Come si chiama?” chiesi,”Franco” il quale emetteva un flebile lamento, quasi un rantolo. Aveva gli occhi chiusi e stava disteso nel letto con le mani lungo i fianchi. Io leggevo e ogni tanto, per fare capire la mia presenza lo chiamavo “Franco, Franco”, lui mugolava. Ad un tratto, al mio richiamo, mi accorsi che non dava più risposta, mi avvicinai al suo viso e capii che se ne era andato. In quel mentre entrò la badante e io l’allarmai subito “Non risponde più”. Ci fu un po’ di trambusto, corsero infermieri e medici ma Franco se ne era andato. Gli altri due pazienti se ne stavano con gli occhi sbarrati in silenzio, ma molto turbati. La badante mi chiese di telefonare ad un numero scritto su di un foglietto. Rispose una voce femminile, la moglie “Signora Franco è mancato”, la risposta mi raggelò: “Appena ho tempo vengo”. La badante mi spiegò la freddezza della risposta, a causa del suo stato di etilista aveva distrutto i suoi rapporti con la famiglia sino alla separazione. Difficile a dirsi, ma Franco quella mattina aveva liberato se stesso e la moglie. A proposito, la mia era una forte gastrite da curare con il Malox. Cosa centrano le lumache? In quel periodo in uno spazio verde attorno a casa mi era venuto lo schiribizzo di allevare lumache e nel tempo libero lasciavo che queste bestiole si arrampicassero sulle mie braccia mentre io le osservavo e le ammiravo per la loro pazienza e la lentezza delle loro vite. Ecco la lentezza della vita, vivere la lentezza lasciare ogni tanto che la vita ci scorra addosso come il tempo. Della mia avventura con le lumache ve ne parlo in un prossimo futuro,spero, ma con calma. Vi saluto brava gente. GIU.BA.
IL DROMEDARIO: Ho fatto la prima dose del vaccino. Questo interessa a pochi. Ho fatto l’Astrazenica, questo comincia a suscitare un altro interesse positivo o negativo. Non mi ricordo se quando mi sono alzato per andarmene ho ringraziato il medico e l’infermiera che mi aveva inoculato la dose e se non lo avessi fatto mi ricrescerebbe moltissimo. Sono stati molto professionali, efficienti ed efficaci senza cadere da parte mia nella piaggeria. A parte l’antinfluenzale non ho ricordo di un altro vaccino se non quello esavalente fatto a militare. Tutti in fila, a torso nudo, una veloce pennellata di tintura di iodio in attesa della puntura nella mammella.Chi cadeva svenuto, chi poi aveva la febbre e chi aveva una “tetta” degna di Serena Grandi. A me non successe nulla e per questo motivo dovetti fare tutti i servizi di piantone, di mensa ecc. ecc. mentre gli altri erano di riposo in branda. Cosa c’era la dentro non è mai stato dato di sapere, nessuno se lo chiese né tanto meno si dichiarò no-vax, certamente per dieci anni buoni non ebbi più nulla ne influenza né raffreddori. Ma passiamo oltre, fatto il vaccino e restato in attesa per quindici minuti in una zona dedicata, sono risalito in macchina per tornare a casa percorrendo la strada per Torrazza. Telefonata alla gentil consorte e poi alla figlia: ” Tutto bene?” “tutto bene, per il momento nessun effetto secondario” ma mentre dicevo questo alla mia destra, in un campo limitrofo alla strada, si materializzarono due dromedari. Stupito le feci notare a mia figlia: “Non capisco, due dromedari che brucano l’erba sono un effetto secondario al vaccino oppure esistono veramente??”. Dubbio legittimo. Per mia fortuna non era un’allucinazione, i due dromedari esistevano effettivamente e se ne stavano in un prato beatamente a pascolare assieme a due lama (quelli che sputano). A parte questo, per ora tutto bene, nessun altro effetto secondario anche se il “bugiardino” del vaccino non l’ho mai letto e a dire la verità non vorrei neanche leggerlo. Anche perché una volta che lessi il bugiardino di un antidolorifico, restai talmente sbigottito che per un giorno stavo all’erta per capire se i sintomi letti mi stavano manifestando come: gastrite, insonnia, ansietà, ingiallimento della pelle e degli occhi, nausea, vomito, flatulenza, diarrea secchezza delle fauci ecc. ecc. e tutto questo per una semplice capsula per il mal di testa. Sono ottimista e spero di rimanerlo, e con questo vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
LE SCARPE DELLA MAMMA: Ero stato convocato quaranta giorni prima e mi avevano detto che avrei affiancato il responsabile del cerimoniale per la visita di Giovanni Paolo II°. Fu una avventura incredibile durante la quale avremmo dovuto preparare l’ambone e il parterre dell’Aula Magna. Attorno all’ambone, dove il Papa avrebbe letto il suo discorso, avrebbero dovuto sedersi tutti le autorità accademiche, le autorità ecclesiastiche della città di Milano e le autorità civili e politiche. Affiancavo il Dott. Ranelli, mentre negli uffici veniva preparato il “famigerato” ordine delle precedenze, un manuale severissimo su chi dovesse sedere e dove. Una volta stilato quest’ ordine e verificato che coloro che dovevano prendere posto confermavano la loro presenza (un lavoro incredibilmente farraginoso) anche perché le massime autorità davano subito la loro partecipazione, mentre le “mezze figure” creavano problemi sul “chi c’è e chi non c’è e dove mi mette, mi raccomando non vicino al tale a al talaltro”. Si arrivò finalmente al giorno prima della visita fissata per il 22 maggio 1983, ricevemmo il sopralluogo del responsabile della Gendarmeria Vaticana, un signore magro, non particolarmente aitante, sempre incazzato e con i capelli e i baffi rossi. Considerato che da lui dipendeva la sicurezza del Santo Padre, incazzati e pedanti lo saremmo stati anche noi. Lo accompagnai in Aula Magna, volle vedere lo schema della assegnazione dei posti, l’ambone, le poltrone e le sedie, la galleria ecc. ecc. Scendendo dal palco delle autorità notò due piante verdi messe a lato del palco, si voltò verso di me e mi puntò un dito in faccia: “Chi ha messo qui queste” ed io “Il giardiniere” e lui “Il giardiniere?!?!, voglio sapere nome cognome del giardiniere, tutto su di lui persino il numero di scarpe che porta sua madre” “Il giardiniere è un dipendente della Università” rispondo “ed è quel signore che in questo momento sta innaffiando i fiori”. Infatti dalla vetrata del corridoio attiguo si vedeva questo buon uomo che con la canna dell’acqua stava bagnando dei vasi di oleandri nel giardino Santa Caterina, quello che gli studenti chiamavano “il giardino delle vergini” poiché era riservato in maniera esclusiva alle studentesse e vigilato dal personale di sorveglianza. Il Rosso capelluto, ma anche paonazzo in viso in quel momento, chiamò con un urlo un suo giannizzero che lo seguiva come un ombra ed entrambi con un gesto repentino sollevarono le piante prendendole per la chioma. Il vaso, pesante, restò a terra, mentre le povere piante mostrarono tutte le loro radici spargendo terra tutt’intorno. Guardarono attentamente rigirandole le radici e poi rimisero le piante al loro posto, le quali ora però mostravano scarmigliate la violenza del gesto come il pavimento tutt’intorno. Se ne andò bofonchiando. Venne il fatidico giorno, 22 maggio 1983, quella notte dormii in foresteria professori, poi alle 5 ancora buio, tutti per un incontro organizzativo finale e poi ognuno al suo posto. Cominciarono ad arrivare gli ospiti, ognuno al suo posto, i professori con la toga e qualcuno con l’ermellino. Intanto dall’ingresso giungeva il clamore degli studenti che cantavano e gridavano. Giovanni Paolo II° è oramai all’interno dell’Università, manca poco al suo ingresso in Aula Magna. Si fa avanti l’On.xxxxxx che non faceva parte dell’elenco degli invitati e con aria tronfia annuncia “Dove devo mettermi, rappresento il Governo”.Scorro l’elenco per cercare il suo nome ma non esiste, quello con aria impaziente quasi a sollecitarmi. Alzo lo sguardo e incrocio quello del mio superiore il quale scuote la testa. Mi riprendo anche dall’imbarazzo sicuro di essere nel giusto. “Credo” rispondo ”che a rappresentare il Governo ci sia già il Ministro dell’Interno il Sen. Virginio Rognoni che si è già accomodato e il vostro nome non è presente nelle liste degli invitati, ma se attende un attimo vediamo di farla accomodare fra i docenti, c’è sempre qualcuno che manca” Il mio superiore rimasto in silenzio alle nostre spalle mi fa segno con il pollice alzato e mi strizza l’occhio. L’On. “non sono nessuno ma metto in imbarazzo la gente” si guarda attorno e poi accetta, come se stesse facendo un favore a noi, di attendere un posto fra i docenti. A parte un piccolo incidente al microfono del Papa, tutto poi fila liscio. Il Rosso esce un attimo dall’aula e mentre mi passa vicino con una mano mi stringe il braccio. Tutto OK, ma il numero delle scarpe della mamma del giardiniere non lo saprà mai anzi, al giardiniere non lo ho mai chiesto. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. n.b. Il Rosso è il primo a sinistra mentre il suo “collaboratore” è l’ultimo a destra
LA LEPRE FELICE: Il lato positivo della pandemia sta nel fatto che riesco, pur restando nell’ambito comunale, fare anche lunghe passeggiate solitarie fra le vigne assieme alla fedele Peggy. E proprio in una di queste occasioni ho assistito ad un fenomeno a cui non avevo memoria di aver mai visto. Al limite di una vigna, una carrareccia polverosa, all’improvviso ho visto due lepri, una ferma seduta e l’altra che invece si rotolava nella polvere, si rialzava tornava a rotolare e sembrava cercare il consenso di quella seduta. Non avevo mai assistito ad una cosa del genere e in cuor mio speravo che la cagnetta non si accorgesse di quanto stava accadendo ad una decina di metri da noi. Mi sono fermato silenzioso a guardare sempre sperando che nulla potesse accadere a turbare quel momento. Il cane stava cercando qualche nuovo odore ed era impegnato altrove, io quasi non respiravo nel timore che i due “innamorati” si accorgessero di me. Ma il momento magico stava per finire, infine il cane si era accorto dei due selvatici e prima li ha puntati in ferma ma poi è partito a razzo mentre le due bestiole scomparivano nel folto del boschetto vicino. Il cane, oramai anche lui da “divano”, dopo lo scatto iniziale tornava caracollando e scodinzolando come dire “hai visto che li ho fatti scappare” ed io ad alta voce “ho visto che ti hanno dato la polvere!!!”. Tornato a casa mi sono informato presso esperti di selvatici i quale mi hanno erudito sul fatto che le lepri in questo periodo sono in amore e quello a cui ho assistito non era altro che un rituale di corteggiamento fra il maschio, che faceva le capriole nella polvere, e la femmina che assisteva interessata. Ecco perché ho scritto che erano due innamorati. Due lepri felici, impegnati fra i profumi della primavera, a pensare di trovare un compagno o una compagna. Nella stessa area da qualche tempo fanno la loro comparsa anche una famiglia di daini i quali a volte si spingono fino in città per la felicità di tutti quelli che li fotografano e poi li postano su F.B. Forse questo è il lato positivo di questa situazione, la natura e i suoi abitanti selvatici si riprendo quegli spazi che sono tornati liberi o almeno poco frequentati dagli umani. Ho incontrato anche una volpe e un tasso, mi hanno avvertito anche della presenza di lupi ma non ne ho mai visti nemmeno da lontano. A proposito mi astengo di fare battute sui tassi e le tasse, sarà per un’altra volta. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
TANTO PER DIRE
Dimostrazione d’affetto: La mia diletta non va più dietro la bocchia del rute, gli ho fatto un cesso di melgazzi con la tenda davanti.
Al mercato: Come mai ves qui? Ma io cero giamò! No io sono arrivato almà almà adesso.
Dichiarazione d’amore: Quando la mania del mio marsinino sarà ataca alla tua socca, allora si che saruma arenta.
Due agricoltori a Retorbido, uno va verso la campagna e uno torna a casa:
Vat Vat?….. Von Von!
GIU.BA.
In questi giorni si è celebrato il Dantedì, come qualcuno saprà negli anni passati tenevo delle conversazioni proprio sulla Divina Commedia. La serata più famosa fu quella che tenni al Castello Beccaria di Montebello. Oggi mi permetto di proporvi un mezzo canto, per non tediarvi troppo, il III° Canto dell'Inferno e specificatamente la parte che riguarda Caronte. Spero di farvi piacere. CARONTE: Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: «Guai a voi, anime prave! Non isperate mai veder lo cielo: i' vegno per menarvi a l'altra riva ne le tenebre eterne, in caldo e 'n gelo. E tu che stai' costì, anima viva, pàrtiti da cotesti che son morti». Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: «Per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui, per passare: più lieve legno convien che ti porti». E 'l duca lui: «Caron, non ti crucciare: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare». Quinci fuor quiete le lanose gote al nocchier de la livida palude, che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anime, ch'eran lasse e nude, cangiar colore e dibattero i denti, ratto che 'nteser le parole crude. Bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana spezie e 'l loco e 'l tempo e 'l seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, a la riva malvagia ch'attende ciascun uom che Dio non teme. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando, tutte le raccoglie; batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie l'una appresso de l'altra, fin che 'l ramo vede a la terra tutte le sue spoglie, similemente il mal seme d'Adamo gittansi di quel lito ad una ad una, per cenni come augel per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna, e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera s'auna. «Figliuol mio», disse 'l maestro cortese, «quelli che muoion ne l'ira di Dio tutti convegnon qui d'ogne paese: e pronti sono a trapassar lo rio, ché la divina giustizia li sprona, sì che la tema si volve in disio. Quinci non passa mai anima buona; e però, se Caron di te si lagna, ben puoi sapere omai che 'l suo dir suona». Finito questo, la buia campagna tremò sì forte, che de lo spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento; e caddi come l'uom cui sonno piglia. Ma chi era Caronte. Figlio di Erebo e della Notte, come Minosse., Cerbero, Gerione, Pluto e Flegias sono. mutuati nella D.C dalla mitologia pagana e Dante li pone qua e la nell’inferno come guardiani o addirittura come giudici (Minosse canto quinto) dove questo demone è di fatto un funzionario della burocrazia satanica e destina i dannati nei vari gironi indicando il luogo della condanna attorcigliando la coda. Di Caronte invece ne da ampia descrizione Virgilio nell’Eneide, ma io preferisco la descrizione meno trucida che ne da Dante rispetto a quella di Virgilio. Dice di lui Virgilio: “Caron demonio spaventoso e sozzo a cui lunga dal mento incolta e irta pende canuta barba, ha gli occhi accesi come di bragia”……“vecchio d’aspetto e d’anni; ma di forze come dio, vigoroso e verde è sempre”. Preferisco pensarlo a un buon diavolo che “il massimo Fattor” ha messo a traghettare le anime dei dannati da mille e mille anni, “Devi stare qua!!!!” e lui è li da mille e mille anni, un buon diavolo dovizioso nel suo incarico ma che però non vede l’ora di andarsene in pensione a riposarsi su qualche bella spiaggia con gli occhiali da sole che gli riparino gli occhi, irritati da questa cronica congiuntivite, e con dei vicini di sdraia possibilmente meno incazzati di quelli che frequenta ogni giorno sulle rive dell’Acheronte. Avanti e indrè a trasportare gentaglia, la feccia della feccia dell’umanità, la schiuma dell’umanità, pessimi compagni di viaggio, bestemmianti e ululanti che maledicono la loro semenza e il loro nascimento poiché sanno che questo traghetto è il punto del non ritorno e con i quali non si può nemmeno intraprendere un minimo di colloquio, mentre lui in cuor suo desidererebbe un po’ di pace e tranquillità uno spritz o un mojito con tanto ghiaccio e soprattutto un buon collirio. Un ultima considerazione: anche in questa occasione Dante sviene o si addormenta, è la prima volta ma non sarà l’ultima, non può passare sull’altra sponda da anima viva e quindi trova questa soluzione svenire. Anche alla fine del V° canto quello famosissimo di Paolo e Francesca alla fine del canto scrive “Mentre che l’uno spirto questo disse, l’altro piangëa; sì che di pietade io venni men così com’io morisse. E caddi come corpo morto cade.” qui è per l’emozione, la reazione al tuffo al cuore che il racconto ha provocato in lui. GIU.BA.
MILANO SANREMO: Una volta la Milano-Sanremo si svolgeva il 19 di marzo, era di fatto l’inizio della primavera ed era festa a scuola. Poi venne Craxi il quale disse che in Italia si facevano troppe feste infrasettimanali ed il comparto produttivo ne soffriva, e furono abolite. Infatti le feste politiche e religiose erano parecchie e chi poteva le attaccava ai week-end e la vacanza totale si ingigantiva. Ma non è di questo che volevo parlare. Il 19 di marzo è anche San Giuseppe e il mio nonno materno si chiamava proprio Giuseppe. Il nonno aveva un ristorantino in fondo a Corso Genova (Corso Fratelli Rosselli in realtà) a Voghera proprio dove il viale si congiunge con la statale dei Giovi. Il ristorante si chiamava pomposamente TOURING ed era frequentato soprattutto dai camionisti e rimaneva aperto h24 per via del bar e dei tabacchi. Di fronte c’era un grande parcheggio per i camions ed era frequentato giorno e notte. Ma il 19 di marzo, giorno in cui si correva la corsa di primavera era appunto l’onomastico del nonno. Ci vestivamo di tutto punto io, mio fratello Angelo (detto Maurizio) e mia sorella Carla. Così agghindati raggiungevamo il nonno presso il suo locale dove ci aveva già preceduto nostra cugina Elisabetta detta Betta, dopo di che ci appostavamo sul terrazzo che dava direttamente su corso Rosselli ed attendavamo con grande allegria la colorata carovana della corsa. “da qui si può seguire la corsa sino al pont a dla valassa” che segna il confine tra la Lombardia ed il Piemonte ed il nonno era fiero nel poter disporre, a beneficio dei nipoti, una simile prospettiva. Passata la corsa tutti a tavola a gustare i famosi “anolini di stracotto, gli anvèi” gli agnolotti piacentini di cui il nonno era un cultore provenendo proprio da quelle parti, lui era il gran visir degli anvèi e nel ripieno ci metteva anche un pizzico di cannella che dava un sapore speciale e particolare all’agnolotto. Una volta terminato il pranzo il nonno tirava fuori dei biglietti da mille lire nuovi di zecca che andava a prendere apposta per noi in banca e ne dava uno ad ognuno di noi. Quel mille lire nuovo lo facevamo durare per parecchio e lo tenevamo religiosamente nel portafoglio da mostrare anche ai compagni di scuola nella certezza di essere invidiati. Il nonno ovviamente è mancato da anni, ma il ristorante esiste ancora anche se ora si chiama “Da Sofia” e quando passo di li lancio sempre una occhiata soprattutto al terrazzo da dove ogni anno andavamo a vedere passare la Milano-Sanremo. Sempre per Bontà vostra. GIU.BA.
STATE ZITTI.....DORMONO
C’è silenzio sui gradoni di granito del sacrario di Redipuglia. Un silenzio solenne a custodire ciò che resta di centomila soldati italiani che qui riposano in pace, su questi colli aspri del Carso che chiesero un incredibile tributo di sangue da entrambi le parti.
Generale dietro la collina ci sta la notte Krukka ed assassina……..
Chi arriva sin quassù ha lasciato spiagge assolate, ombrelloni e sdraie, ha le ciabatte di gomma e i pantaloni corti di tela sgargianti di colori ma gli occhi stupiti e poi mano a mano affranti. Centomila nomi su per i gradoni di sasso, centomila ragazzi, una generazione intera e lo stupore si trasforma in sgomento. Nomi e cognomi, ma a volte solo cognomi o neanche, solo il nome: Armando…… e niente altro ne un cognome ne un battaglione. Trentamila addirittura senza nemmeno quello: ignoto.
E sopra al prato c’è una contadina curva sul tramonto sembra una bambina……….
Hanno belle facce, grandi baffi e aspetto marziale nelle foto conservate nel museo, sembrano più vecchi dei loro vent’anni, facce di contadini specchio di una Italia che non c’è più, la meglio gioventù di quegli anni scomparsa, cancellata dalla mitraglia, dagli assalti alla baionetta e dalla mazza ferrata o dalla ottusità di chi aveva il potere di comandare. Ora i bambini, che sono arrivati qui come se fossero al parco divertimenti, si acquietano, si attaccano alla mano dei papà e leggono ad alta voce i nomi. Presente, risponde la pietra e lo ripete infinite volte.
di cinquant’anni e di cinque figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati………
Parecchi di loro non si erano mai allontanati da casa, non avevano mai lasciato la loro terra, terra fatta di sudore e di fatica, di campi da arare e grano da mietere per venire a morire qui fra i bianchi sassi del Carso. Il sole ora picchia più forte e dal punto più alto della collina si vede il mare di Trieste, più giù in mezzo alla campagna si sente il rombo lontano dell’autostrada con i vacanzieri che alzando gli occhi vedono, anche se solo per un attimo, la grande scalinata del Sacrario.
Generale dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male…………
Un signore anziano si è seduto sugli scalini e piange, si asciuga la testa e gli occhi con un fazzoletto, gli altri lo superano e lo guardano con rispetto e con il groppo alla gola. Lassù, in cima alla scalinata, ci sono le Tre Croci, il Golgota non è mai stato così concreto, sublime simbolo del sacrificio. Di fronte il colle di S.Elia con i cipressi e i viali ordinati, qui vennero in un primo tempo sepolti i caduti di tutte le battaglie del Carso. In un foto d’epoca, qualcuno ha immortalato una scritta in friulano: “Fate silenzio stanno dormendo”. Si, facciamo silenzio, le parole qui sono solo un suono sgradevole, inutili banali, solo balle per dare aria ai denti.
*Generale la guerra è finita il nemico è scappato è vinto è battuto dietro la collina non c’è più nessuno solo aghi di pino e silenzio e funghi………….
*Generale: testo di Francesco De Gregori
Sempre per bontà vostra GIU.BA.
SUGO!!!!!! Si chiamava Emanuele ma per tutti era “Manu”. Fu assunto da mio nonno ai tempi del Caffè Cevenini, quando aveva 14 anni e faceva il garzone in pasticceria. Ha poi seguito le vicende della mia famiglia per moltissimi anni. A parte qualche breve esperienza fuori casa, un anno lo andai a trovare ad Alassio, dove faceva il cameriere in un noto locale sul lungomare, restò sempre con noi. Non era un dipendente, mi sovviene la scena del Commissario Ricciardi quando reagisce al Questore “Rosa non è la mia serva”, ecco Manu non era il cameriere ma uno zio, un cugino, uno di famiglia. Veniva dalle prime colline dell’Oltrepo’ ed era venuto in città per imparare un mestiere ma era rimasto legato al suo paesello dove ogni tanto tornava. Al Bar Roma, quello di fronte alla stazione di Voghera, era il deus ex machina del dehors, 90 tavoli che lui gestiva con professionalità, sempre elegante in giacca bianca e farfallino nero (riusciva a farsi il nodo al farfallino, mentre noi avevamo ancora quelli con l’elastico), gran affabulatore, vulnerabile al fascino femminile e gran giocatore di biliardo dove, haimè, perdeva i suoi soldi sul tavolo verde. Era appassionato di apicoltura e leggeva tutti quei manuali di come si allevano le api. Si era anche fatto un rampino per poter cogliere i fiori della pianta della magnolia che si ergeva nel bel mezzo del dehor che poi offriva a questa o quella signora o signorina che entrava nelle sue grazie. Appoggiava il piede sul bordo del vaso di oleandri e si atteggiava a bon vivant fumando con gran enfasi una sigaretta lanciando occhiate furbette alla favorita dalla sorte delle sue attenzioni. Durante la bassa stagione, l’inverno, andava a servire alla mensa della cooperativa ferrovieri in Via Scovenna dove, oltre ai ferrovieri, andavano a mangiare gli studenti della vicina Scuola Professionale Monumento ai Caduti. Accadeva che alcuni si portavano il secondo da casa, mentre il primo piatto caldo veniva servito in una sorta di self service. La cuoca serviva il piatto di pasta, già condita e poi il buon Manu girava fra i commensali con una zuppiera con una ulteriore possibilità di aggiungere condimento. “Chi vuole altro sugo??” ma dal popolo degli affamati come nel coro dell’Adelchi di manzoniana memoria si elevava un grido che univa tutto i presenti: “SUGOOOOOO!!!” e lui sollecito con il suo mescolo, tuffandolo nella zuppiera colma, distribuiva a destra e a manca il rosso condimento. Non si sposò mai, non ebbe una sua famiglia, ma era molto attento alle sorti dei suoi parenti. Una volta finita l’esperienza della mia famiglia con gli esercizi commerciali, mio zio lo prese con se presso le sue lavanderie dove faceva il factotum comprese le “scrupolose consegne a domicilio”. Gli fu assegnato un piccolo appartamento soprastante la lavanderia dove rimase sino alla fine dei suoi giorni accudito amorevolmente dai miei zii. Sempre un caro ricordo di questo quasi familiare, un ricordo affettuoso di chi ha attraversato la mia vita. Sempre per bontà vostra GIU.BA. N.B. Purtroppo l’unica foto che ho di lui è questa, il suo viso appare dietro l’auto nera.
L’uomo che fischiava in silenzio. Era fermo sui due piedi all’incrocio e guardava il traffico, braccia incrociate sul petto, ben coperto nel giaccone imbottito e con in testa un cappellino a quadri o il bordino, il basko insomma, mio contemporaneo o appena più anziano, seguiva con lo sguardo tutte le vetture che gli transitavano davanti. Fin qui nulla di particolare se non per il fatto che aveva le labbra atteggiate a fischiare ma non pareva uscisse alcun suono. Mi sarebbe venuta voglia di avvicinarmi, avvicinare l’orecchio e sentire se dalla sua bocca uscisse un qualsivoglia rumore, ma niente a parte il rumore del traffico nessun suono. Dopo qualche giorno in un supermercato, in fila alla cassa, alle mie spalle, eccone un altro, anche lui labbra atteggiate al fischio ma niente, nessun rumore. Da quel momento ho iniziato ad osservare questa nuova, per me, tribù di indiani metropolitani fischiatori del silenzio, li trovo un po’ dovunque, osservano con occhio vispo tutto ciò che accade intorno, sembra stiano fischiando, ma nulla, non fanno rumore, elfi di città a volte anche in bicicletta. Ho persino l’impressione che quel loro fischio represso sia un segnale, come dire “occhio!!! qui sta accadendo qualcosa, ma vi tengo d’occhio”, ma non vogliono disturbare, restano chiusi nel loro silenzio fischiando senza il sonoro, ma osservano tutto. Sono i famosi “umarel” che guardano i lavori stradali scrollando la testa bofonchiano fra sé e sé:“ma l’è la manera da tegn in man la pala, ma mi so nò” e via criticando. Qualcuno voleva anche stabilire un prezzario:5€. per mezza giornata da posizione favorevole, 10€ per giornata intera, 20€ per un colloquio con il capo cantiere, gilet ad alta visibilità giallo con scritto sulla schiena UMAREL compreso. Si prega di arrivare sul sito già mangiati, non è prevista la pausa pranzo assieme agli operai. Ancora grazie per la pazienza che avete nel leggermi. Sempre per bontà vostra e mi raccomando tenete botta. GIU.BA.
Cinefili e cinofili 2.0.... Questa volta cinefili. Anni fa comprai “IL MEREGHETTI” Dizionario dei film, anche perché ogni tanto dovevo fare il commento su dei film che venivano proiettati a Casteggio ad uso della popolazione, vedi le serate del Cine Club, oppure i molto divertenti e molto graditi “Cinema sotto le stelle” organizzati dalla Pro Loco con l’indimenticabile Pietro Peveri allora presidente. Ed una volta nella ricerca del titolo di un film ed il relativo commento, mi sono imbattuto in un titolo molto eloquente:” W la foca”. Oggi si chiamerebbe un B movie. In teoria un “filmaccio” da cinemino di terza categoria, di basso casermaggio, ma leggendo tra le righe si scopre che con il passare degli anni questo genere di pellicola viene riabilitata tant’è che parecchie TV commerciali locali li trasmettono ancora e hanno una schiera anche numerosa di estimatori. Uscito il 4 marzo 1982 col divieto ai minori di 18 anni, il film fu sottoposto a sequestro dopo due settimane di circolazione. La censura avrebbe stigmatizzato il riferimento sessuale suggerito dal titolo. Il film rimase praticamente invisibile per due decenni, per essere poi presentato al Festival di Venezia 2004, (non riesco a identificare in quale sezione), pubblicato quindi in DVD, è stato poi trasmesso anche sulle reti TV nazionali. Tra gli interpreti figurano nomi allora semisconosciuti come Bombolo (Franco Lechner), Lori del Santo, Riccardo Billi (Billi e Riva per coloro che hanno buona memoria), Michela Miti, Franco Bracardi, Maurizio Mattioli, un cameo di Moana Pozzi e la presenza di una foca vera. Il regista si chiamava Nando Cicero che nella sua carriera da registra annotiamo le varie dottoresse al distretto militare e le insegnanti varie. Ecco alcuni titoli della sua fimografia:Il gatto mammone (1975) con un giovane Lando Buzzanca, La dottoressa del distretto militare (1976),La soldatessa alla visita militare (1977), La soldatessa alle grandi manovre (1978),La liceale, il diavolo e l'acquasanta (1979),L'assistente sociale tutto pepe (1981),W la foca(1982) appunto,Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento. Insomma, Alvaro Vitali era il suo attore di riferimento e ovviamente le belle cavallone sempre seminude e sempre sotto la doccia in quegli anni. Ma ora voglio segnalare quello che proprio il Mereghetti scrive a proposito di questo film: “Commediaccia barzellettistica che si eleva dalla media per i tocchi surreali ed il gusto del nonsense. La presenza della foca accostata a Lori del Santo innesca un cortocircuito retorico che si spalanca su di una vertigine sensoria”. La “vertigine sensoria” mi ha commosso. Ritengo che il commendo di Mereghetti sia semplicemente “GENIALE”, avrebbe potuto anche non recensire questo film, invece lo ha quasi elevato dandogli una dignità, quasi un valore culturale che certamente il film non può avere e non merita. Applausi!!!!! Goliardicamente:” Viva la foca e che dio la benedoca……” e mi fermo qui. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
Tanto per dire
Il figlio scemo! In una grande famiglia, il bisnonno, il nonno e il padre, avevano creato un piccolo impero quindi più che benestanti. Ma l'ultimo della casata era il figlio “scemo” che nell'arco di trent'anni era riuscito a dilapidare l'intero patrimonio così duramente accumulato in anni di lavoro e sacrificio del suoi avi. Ma non solo, si era pure riempito di debiti. Oramai con l'acqua alla gola si era rivolto al suo genitore affinché trovasse una soluzione e il genitore, oramai stanco dei comportamenti del figlio, pensò bene di coinvolgere un famoso commercialista. Questi dopo aver visto i registri cominciò a vendere e a disdire, quindi via Ferrari e Maserati, via l’attico a Montecarlo, la tessera al tennis club e così via. Ma i familiari del figlio insorsero ed andarono prima dal commercialista e poi dal padre a reclamare anche perché il loro tenore di vita era precipitato e se prima vivevano al di sopra delle loro possibilità (a loro insaputa), ora si vedevano decurtare il proprio status quo. Ma il commercialista fece vedere i conti e così fece il padre. Obtorto collo ora dovevano fare sacrifici se volevano salvare almeno il salvabile. Morale: è inutile prendersela con il commercialista, avrebbero dovuto prendersela a suo tempo con il congiunto “scemo”. Nella mia vita ho visto di questi esempi e purtroppo ho anche visto come è andata a finire. In camera caritatis posso fare degli esempi. Non prendetevela con il Governo Tecnico, prendetevela con quelli che per trenta e più anni hanno dilapidato quello che era stato il sacrificio ed il lavoro dei nostri padri e nonni. Io mi auguro che il Prof. Draghi sciolga la riserva, ma non mi stupirei se invece rinunciasse giusto per fare felici ciò che hanno già scritto i leoni da tastiera nei suoi confronti. «Governare gli italiani non è difficile, è inutile» è una massima di Mussolini, di Giolitti o di Churchill? Non lo sapremo mai. Però é' una cruda realtà. A proposito: per il congiunto “scemo” mi riferisco a tutta la classe politica “buoni a nulla ma capaci di tutto”, vincitori del famoso premio Giachetti. Se andate in rete capirete a cosa mi riferisco. E' un mio pensiero personale. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
CINEFILI O CINOFILI “Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell’inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell’obbedienza”. Questo da un vecchio manuale militare. La necessità della disciplina e il rispetto dei ruoli gerarchici sono fondamentali per il vivere sociale, assieme all’assunzione delle reciproche responsabilità morali e materiali. La parola obbedienza e quasi sparita dai vocabolari, si polemizza prima ancora di obbedire e questo è purtroppo la causa di decadimento sociale. Altre generazioni, altro concetto di responsabilità, di rispetto e di obbedienza. Ma veniamo al dunque. L’altra sera ho visto la prima puntata del programma “la caserma” un docu-reality dove quindici ragazzi nati quasi tutti in questo millennio, alle prese con una situazione di vita pseudo militare. Noi, intendo la mia generazione ma anche quelle dopo, sino al 2005, che abbiamo pagato il tributo alla Patria con la chiamata alle armi, quello che stanno facendo questo gruppetto di giovani, lo abbiamo vissuto ma non certamente così edulcorato. Quando arrivavano i nuovi allievi alla scuola A.C.S. di Spoleto gli cantavamo una canzone che, se da un lato serviva a tenere il passo, dall’altra era un monito: “ Ti fanno un c..o così, ti fanno un c..o così, a noi ce l’han già fatto a voi ve lo faranno…..”, un monito ma forse anche una minaccia. La piazza d’armi era il desueto aeroporto militare di Spoleto e il sergente maggiore che ci addestrava ci disse “Prima di andare via da qui farete quattro volte questa pista a sbalzi e non avrete nemmeno il fiatone”. Era lo stesso che quando arrivammo ci disse semplicemente “Voi non siete…” e null’altro. Sembrava essere uno stronzo megalattico, ma quando finì il corso e venne a salutarci era commosso. Ora questo programma che vorrebbe essere una via di mezzo fra “Gunny” e “Ufficiale gentiluomo” in realtà non mi ha convinto, anche se lo ho seguito con discreto interesse, le uniche persone vere forse sono gli istruttori (professionisti??) e il loro capo (Ex Col Moschin ?), quasi tutti certamente provenienti da esperienze militari. La signora Debora Colucci, mi ha ricordato un sottufficiale che incontrai al Genio Pontieri di Piacenza e che aveva la responsabilità del gruppo di soldatesse ed era un vero e proprio mastino tanto con le ragazze come con gli altri militari, vietato avvicinarsi alle camerate femminili. Comunque le ragazze erano delle gigantesse, al Genio Pontieri ne piccole ne gracili. Qual è il problema? Ai giorni nostri i giovani, non tutti s’intende, ma buona parte, hanno cancellato alcune regole fondamentali come il rispetto, l’obbedienza, il sacrificio e sopra tutto il non essere più capaci a rinunciare a qualche cosa per il bene comune, l’ego viene sopra ad ogni cosa. Ma il titolo del pezzo? Non c’entra nulla ma non sapevo come intitolarlo. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
TANTO PER DIRE
O LA BORSA O LA VITA (ma volendo anche entrambi)! Breve premessa: la salute innanzi tutto!! Detto questo inizio il mio personalissimo ragionamento. Il Governo per decreto chiude quasi tutte le attività e per decreto dovrebbe rimborsare le perdite che queste attività subiscono. Non ha soldi a sufficienza? allora, per decreto, detti tutte quelle regole che possano lasciare che le attività continuino a operare legittimamente e in sicurezza. Ma non chiudere tutto completamente se poi non hai la possibilità di rimborsare o dare solo delle mance. L’accanimento nei confronti delle attività dell’HO.RE.CA. ovvero hotel, ristoranti e caffetteria, mi sembra una acrimonia eccessiva, un livore incomprensibile. Hanno paura degli assembramenti? OK, ma trattano Casatisma o Calvignano ma anche Casteggio come Corso Como o i Navigli, per fare un esempio della Lombardia. I bar devono stare chiusi, solo l’asporto e solo sino alle 18. E quando si lasciavano aperti anche in quel caso sempre solo sino alle 18 (sarebbe bastato almeno sino alle 20). Lo sapete che gli Autogrill in autostrada sono sempre aperti? A mezzogiorno la sala ristorante dell’Autogril di Stradella ospita mediamente 150 persone. Quindi con 2,50€ di pedaggio posso tranquillamente andare da Casteggio a Castel S. Giovanni e fermarmi a mangiare a Stradella in autostrada. E tutto questo mentre i nostri ristoratori e baristi devono stare chiusi e in grave sofferenza economica. Per non parlare delle seconde case che si possono raggiungere anche in altre regioni. Devo avere un contratto di affitto o di acquisto antecedente il 14 gennaio, firmato di lunedì e con la luna piena?!?! Per non parlare di tutto il resto: palestre, teatri, piscine, negozi no food ecc.. La confusione oramai regna sovrana, ogni giorni un Grande Puffo a caso detta nuove regole. Quelli che fanno le regole probabilmente non sanno neanche come si tira su una clère; chiudiamo tutto…..apriamo tutto, ma uno con un po’ di cervello che sappia scrivere delle regole di comportamento utili, necessaria e perché no, severe ma che diano la possibilità di clienti, esercenti ed operatori di lavorare, esiste?. Possibilmente facendo distinzione fra aree metropolitane e piccole realtà di provincia, non si può trattare la grande città come si tratterebbe Santa Margherita Staffora. Chiedere ai Sindaci che conoscono bene il territorio, quale è la situazione e poi agire di conseguenza. Chiedo molto? Scusate lo sfogo, sarà perché vengo da una lunga tradizione familiare di esercenti e pure io ho sempre fatto un lavoro di ospitalità e di convivialità. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
LA 500: Nel corso della mia vita ho avuto almeno 4 Fiat 500, alcune hanno segnato anche momenti importanti, altre momenti ludico/avventurosi e l’ultima ricordi nostalgici. Ma quella che più mi è rimasta nella mente ed anche nel cuore è quella che mi ha accompagnato nel viaggio di nozze. Era cream, nocciola, la possedevo già da tempo, da quando tornato da militare non utilizzavo più la macchina di famiglia,una Simca Aronde bicolore bianca e rossa, l’ammiraglia di mio padre, che aveva sostituito una 1100 Fiat codino sempre bicolore prima e una 1300 Fiat color pavone dopo. Con quest’ultima razzolavo in quel di Salice prima del militare. Ma torniamo alla 500 nocciola, Appena finito il micidiale pranzo di nozze, eravamo partiti, io e la mia novella sposa, verso Alassio, dove mia nonna materna aveva un alberghetto. Allora l’autostrada finiva a Savona, da li in poi solo l’Aurelia, una sequenza di curve infinita tra un su e giù, con da un lato la montagna e dall’altro il mare. Alla fine il pranzo di nozze si ribellò e decise di fermarsi in una piazzola di sosta. Ma non solo, la mattina dopo si decise di andare a Montecarlo, sempre in 500 e ripetemmo la scena. Oggi quando vedo una 500 ho si un senso di nostalgia, ma d’altro canto mi do del disgraziato per aver costretto la mia giovane sposa a un viaggio massacrante in una scatoletta di latta. Poi ne ebbi una bianca, con la quale andavo a prendere il treno a Lungavilla alla mattina, e tutte le mattine era una P.S. una prova speciale da rally da Casteggio alla stazione di Porana. Finche una mattina, mentre attraversavo Calcababbio, mi si parò davanti un uomo che con le braccia aperte, mi bloccò e mi coprì di insulti “Tutte le mattine attraversate il paese come dei pazzi, o la smettete o chiamo i carabinieri” ovviamente aveva fermato me ma si rivolgeva anche agli altri colleghi/amici pendolari. Per un po’ abbiamo rallentato ma poi, noi che calcolavamo anche i secondi che ci separavano dal letto al treno, riprendemmo come prima. La terza era una 500 nera che avevo comprato usata da un amico. Questa aveva la pretesa di essere “truccata”, in realtà faceva solo rumore. Con questa, nei mitici inverni a Pian del Poggio, facevamo una gara di velocità dal Poggio al Giovà sulla strada innevata che di fatto era una pista da bob. Il mio competitor era una ragazzo genovese che aveva anche lui una 500 “trücà da cursa”. Ma una sera, dopo aver girato nel piazzale dell’albergo Giovà mi stavo precipitando verso il Poggio, in una curva, invece di sbattere semplicemente contro la parete di neve, la macchina prese il volo e si capottò per poi immediatamente raddrizzarsi. Quando arrivai al traguardo mi resi conto che avevo storto l’abitacolo, sembrava che una mano gigante mi avesse dato uno schiaffone. Auto da buttare, comunque…andava ancora! L’ultima era di mio nonno, color corallo. Tenuta come un bon bon, l’aveva poi ereditata mia madre e la teneva in garage sotto delle coperte. Il mio compito era quello di andare a metterla in moto di tanto in tanto e di tenerla sollevata per evitare di “ovalizzare” le ruote. Dopo alcuni anni però mia mamma, constatato che la macchina si stava deteriorando, mi dette incarico di venderla. Avrei voluto tenerla io, ma poi che ne facevo, dove la tenevo? Mi informai per passarla nel registro delle auto storiche, ma mi fecero desistere per le mille pratiche da fare. Alla fine la vendetti ad un amico collezionista, con il patto che se volevo fare un giro me l’avrebbe prestata. Mia figlia non mi parlò per alcune settimane.Io non la usai mai più anche se quando andavo nella officina del mio amico le facevo visita e mi tornava alla mente la frase di mio nonno quando andavo a prenderlo: “Anduma con la tua o cun la me vetüra”. Lui la sua 500 la chiamava la “vettura”. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
TRA LE PIEGHE DELLA RETE ----Ve la propongo in lingua originale e di seguito tradotta in italiano. LA MEJOR GENERACIÓN SE ESTÁ MURIENDO. La generación que sin estudios educó a sus hijos. La que, a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa . La que enseñó valores; empezando por Amor y Respeto. Se esta muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres, el respeto por los hombres. Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos, sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no el precio. Mueren los que pasaron por mil dificultades y sin rendirse nos enseñaron cómo vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificio y penurias, se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que enseñó a vivir sin miedo. ¡Se está muriendo!. la generacion que nos dio la vida.------- LA MIGLIORE GENERAZIONE STA MORENDO. La generazione che senza studi ha educato i propri figli. Quella che, nonostante la mancanza di tutto, non ha mai permesso che mancasse l'indispensabile in casa. Quella che ha insegnato i valori; a partire da Amore e Rispetto. Sta morendo la gente che insegnava agli uomini il valore di una donna e alle donne, il rispetto per gli uomini. Stanno morendo quelli che potevano vivere con pochi lussi, senza sentirsi frustrati. Coloro che hanno lavorato fin dall'età giovanile e hanno insegnato il valore delle cose, non il prezzo. Muoiono quelli che hanno attraversato mille difficoltà e senza arrendersi ci hanno insegnato come vivere con dignità. Quelli che dopo una vita di sacrificio e stenti, se ne vanno con le mani rugose e fronte alta. Sta morendo la generazione che ha insegnato a vivere senza paura. Sta morendo!.la generazione che ci ha dato la vita.
VACCINI! Dedicato a tutti coloro che come me hanno fatto il militare. Noi che abbiamo fatto la naja, siamo oramai una razza in via di estinzione. Oggi sono solo professionisti o volontari. Ma a parte questo vorrei rivolgermi a tutti coloro che hanno delle remore nel riguardo dei vaccini. Dopo qualche settimana che mi trovavo alla Scuola Militare di Spoleto, fui sottoposto alla vaccinazione. Tutti in fila, a torso nudo, uno pseudo infermiere che ti spennellava(era proprio un pennello) il petto sinistro con la tintura d’ iodio e un giovane medico che armato di una siringa, per fortuna la cambiava ogni volta, quasi divertito ti iniettava questa sostanza nel petto. Nessuno si è mai chiesto cosa conteneva la siringa, l’unica cosa che sapevamo che era un vaccino esavalente, praticamente era contro tutto, dalla pecolla all’unghia incarnita. Qualcuno crollava a terra svenuto, a qualcun altro veniva un febbrone da cavallo, altri ancora avevano un seno da 6^ misura push-up. A me non capitò nulla, anzi considerato che stavo bene dovetti supplire nei servizi di tutti coloro che non erano abili. In compenso per 10 anni non ebbi più nulla. Ma che influenza o intossicazione gastroenterica. Una volta ad una esercitazione a fuoco, andai in pausa pranzo verso la cucina mobile per ritirare il mio plinto di pasta al forno, ma nell’aprire la gavetta scoprii che non l’avevo più lavata dall’ultima volta, da almeno 15 giorni, ed era tutta ammuffita. Mi guardai attorno e vidi un fontanile con una bocca d’acqua notevole. Trovai anche una manciata di sabbia e molto velocemente strofinai vigorosamente la gavetta, la risciacquai e mi presentai alla fila del rancio con la mia gavetta lucida e bagnata, oggi sarebbe una forma di suicidio mangiare in quelle condizioni. Ma quali NO VAX, la vaccinazione era obbligatoria e per la quale non c’erano voci dissenzienti, non ti chiedevano se la volevi fare, la dovevi fare e basta. Cosi come l’anti vaiolosa, mi è piaciuto quel fumetto dove una bambina chiede alla nonna “Cosa sono quei segni che hai sulla braccia” intendendendo quei due cerchiolini sul braccio sinistro. “E’ la vaccinazione per il vaiolo” “E perché io non le ho???” “Perché ha funzionato!!”. Il Professor Albert Bruce Sabin* colui il quale elaborò il vaccino per la poliomelite, non brevettò la sua invenzione, rinunciando allo sfruttamento commerciale da parte delle industrie farmaceutiche, affinché il suo prezzo contenuto garantisse una più vasta diffusione della cura:”E’ il mio regalo a tutti i bambini del mondo” e lo fece anche in ricordo di sue due nipotine morte a causa della persecuzione nazista. Oggi noi e tutti i nostri discendenti siamo vaccinati; il famoso zuccherino, tutti ricordano la zolletta di zucchero sulla quale era depositato il vaccino. Ma voglio lasciare per il momento i vaccini per spezzare una lancia a favore dei ristoratori e baristi, degli esercenti in generale, io vengo da una famiglia di esercenti: è una mia impressione oppure esiste un accanimento verso queste categorie? Avete visto i bus e le metropolitane milanesi all’ora di punta?, avete visto le code all’IKEA? Avete visto gli assembramenti attorno ai politici o all’attore bello da morire? Ma di cosa stiamo parlando??? Sono certo che coloro che suggeriscono queste imposizioni non si sono mai alzati dalla scrivania e soprattutto non hanno mai lavorato, non si sono mai alzati alle 4,30 del mattino per essere pronti per chi prendeva il treno delle 5,10 per Milano Lambrate? Ed insistono pure………..Sempre per bontà vostra. GIU.BA. * Albert Bruce Sabin era un medico ebreo/polacco che fuggì in America inseguito dai nazisti. Da ricercatore su microbi e batteri elaborò questo vaccino chiamato proprio Sabin.(per farla breve). Dalla realizzazione del suo diffusissimo vaccino anti-polio Sabin non guadagnò quindi un solo dollaro, continuando a vivere con il suo stipendio di professore universitario. Inoltre, durante gli anni della Guerra fredda, Sabin donò gratuitamente i suoi ceppi virali allo scienziato sovietico Mikhail Chumakov, in modo da permettere lo sviluppo del suo vaccino anche in Unione Sovietica e paesi satelliti. Anche in questo caso Sabin andò oltre le questioni politiche per un bene superiore. Avete presente la canzone di Mary Poppins “Basta un poco di zucchero la pillola va giù….” fa riferimento proprio alla somministrazione del vaccino in modo che i bambini lo prendessero anche per gioco. Non ricevette mai il Premio Nobel ma milioni di bambini gli sono grati egualmente.
IL LODEN: Verso la fine degli anni 70’ inizio anni 80’, venne di moda il Loden, un cappotto in tessuto di lana caldo e morbido tipico del Sud Tirolo e Alto Adige. Il colore classico era il verde bosco con bottoni rivestiti di pelle. Molti erano imitazioni, ma alcuni potevano anche permettersi di indossare un loden originale vantando l’acquisto in Alto Adige presso un negozio di fiducia di Bolzano. I veri cultori andavano addirittura a Vandoies, in Val Pusteria, un paesino dell’Alto Adige più vicino a Innsbruck che a Bolzano. A Milano, grazie a delle reminiscenze austro ungariche e a tutto quello che l’Imperatrice austriaca Maria Teresa Asburgo Lorena, donna illuminata, aveva lasciato nella cultura e nella società del Lombardo-Veneto, il loden ebbe un gran successo divenendo un indumento popolare. Fin qui tutto bene, ma questa eccessiva popolarità creava anche situazioni al limite del grottesco ad esempio, alla pausa pranzo, durante le fredde giornate invernali in quel di Milano, gli attaccapanni delle mense aziendali, nel mio caso alla mensa del personale dell’Università, vi era uno stuolo di loden appesi. All’arrivo ognuno cercava di memorizzare la gruccia dove aveva appeso il suo loden, ma all’uscita quasi sempre, l’ordine dei cappotti veniva sconvolta e succedeva il caos. C’erano alcuni che si trovavano nelle tasche mazzi di chiavi misteriose, altri, indossandolo, avevano le maniche o troppo lunghe o troppo corte, biglietti del metrò, pipe e tabacco. Seguivano telefonate di ricerca, scambi di ostaggi, alcuni addirittura nei giorni successivi, anche perché qualcuno più distratto di altri se ne accorgeva a casa o addirittura se ne accorgevano le rispettive consorti forse più attente a ciò che indossava il marito “E questo dove lo hai preso???”. Mi sovviene la famosa storiella del guardaroba di un teatro: due amici all’uscita da teatro, si presentarono al guardaroba per ritirare i rispettivi cappotti, uno dei due diede una buona mancia alla guardarobiera. L’altro stupito chiese “Ma non ti pare di aver esagerato con la mancia, 20€uro non sono un po’ troppi” “Zitto, guarda che bel loden che mi ha dato”. A sdoganare questo tipo di cappotto ci pensò anche il Prof. Monti che da Presidente del Consiglio indossava sempre un loden blu, infatti si definì proprio per questo un governo in loden, intendendo con ciò il basso profilo della compagine. Anch’io avevo il mio bel loden, ma era marron e corto, il così detto tre quarti, e allora nelle mie tasche al massimo c’erano solo delle monetine e il famoso “rud ad sacocia". Sempre per bontà vostra GIU.BA.
TANTO PER DIRE
NOTTE DI CAPODANNO: Sono le 18,48 del 31 dicembre 2020, anno orribilis, sono già in tuta pigiamata, ma mi sovviene, am ricord, che dal 1974 al 1994 circa, anno più anno meno, a quest’ora eravamo appena usciti dalla tavernetta dove avevamo controllato che tutto fosse a posto. Quindi andavamo a cena, una cena quasi normale e poi ognuno di noi a riposare sino alle 22. Poi si scendeva in discoteca, accendevamo le luci, facevamo ancora un controllo affinché tutto fosse a posto, poi ognuno di noi prendeva il suo posto e si apriva. Sino a mezzanotte andava tutto liscio, ma appena cominciavano a uscire dai cenoni, cominciava la bagarre. Musica a palla, ressa al bancone del bar, ma anche tanta allegria. Qualche volta poteva capitare una situazione di trambusto, a volte rientrava subito a volte ci voleva l’intervento di colui che era addetto alla sicurezza, ma mai nulla di particolarmente pericoloso. Si andava avanti sino alle quattro del mattino, se c’era la neve sciabile, il pubblico mano a mano usciva per andare a riposare, se invece era un inverno secco si trattenevano anche un poco più a lungo. Finalmente si chiudeva. Facevamo un breefing finale e finalmente brindavamo anche noi. Io, Claudio, Paolo, il D.J. quello che controllava le uscite di sicurezza e non solo quelle (le ragazze della cassa erano già andate a dormire). Chiacchiere sino al mattino, forse il momento più bello della nottata. Poi finalmente a nanna, stanchissimi. E questo per circa venti anni. Capito ora perche alle 19,01 sono già in tuta pigiamata. Si chiama sindrome da saturazione. Buon Anno. GIU.BA.
Tanto per dire
POCHE IDEE MA BEN CONFUSE: Il primo punto della Legge degli Scout (ASCI) dice testualmente: “Lo scout considera suo onore meritare fiducia”. Non mi interesso più da tempo di politica, il partito nel quale credevo e sono cresciuto non esiste più e quelli cosi detti nuovi non rispecchiano le mie aspettative. Degli attuali rappresentanti del popolo so per certo che parecchi di loro hanno avuto una educazione scoutistica come me, nel senso che hanno aderito e alcuni ancora aderiscono al movimento nel quale io ho creduto e nel quale io sono cresciuto e maturato. Vorrei perciò ricordare ad alcuni di loro che il primo punto della nostra legge dice appunto che noi consideriamo nostro onore meritare fiducia. Lo vorrei ricordare proprio a quelli o quello che in questi giorni stanno trastullandosi solo per avere un minimo di visibilità che hanno oramai perso da tempo, uno ad esempio da quando promise di ritirarsi, da quando assicurò serenità ad un amico e sodale di compagine,(secondo punto della legge “lo scout è leale). Da quando si atteggia a statista, a lui fiorentino vorrei ricordargli che uno statista vero e puro fu La Pira mica pizza e fichi. In un momento dove regna sovrana la regola regina di “poche idee ma ben confuse” ma anche “C.A.S. complicazione affari semplici” dove si dice e si fa di tutto e poco dopo il contrario di tutto alla faccia della coerenza, cercare di aumentare la confusione e poi per fare cosa? Nulla. Non per niente il personaggio in questione quando era negli scout veniva chiamato “il bomba” per le cazzate che ogni tanto sparava. E’ comunque in buona compagnia, gente buoni a nulla e capaci di tutto. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
MILLE LIRE Dopo aver scritto “Gli indomabili” su questo blog, ho cominciato ad interessarmi alla epopea dei nativi americani, i pellerossa, gli indiani insomma. Nella mia personale biblioteca fortunatamente esistono alcuni libri che trattano questo argomento, alcuni letti, altri non ancora letti. L’altra sera alla ricerca di un buon volume da leggere mi sono imbattuto nel libro di Dee Brown “Seppellite il mio cuore a Wounded Knee” che non avevo mai letto e che probabilmente, anzi certamente, lo aveva acquistato mia figlia da leggere in treno quando faceva la pendolare su Milano. Mentre lo sfogliavo dalle pagine sono scivolati fuori due reperti: un biglietto del metrò datato 12 febbraio 1997 e un biglietto da mille lire. Immediatamente quando capita di leggere una data su di un documento alla mente viene subito da pensare :” dove ero in quel giorno?” Io ero a Piacenza dove facevo di tutto per garantire il vitto e l’alloggio (e varie altre cose) agli studenti della Cattolica di quella sede. Ma la banconota mi ha fatto tornare anche in mente quando, indegnamente capo scout, organizzavo i campi per quei simpatici pargoletti, più che altro ragazzotti, in estate o a settembre poco prima dell'inizio dell'anno scolastico. I genitori che mi affidavano questa ciurma di scalmanati, mi avevano affibbiato il soprannome di “Mille lire lungo” perché riuscivo a far quadrare i conti con mille lire al giorno. Io di mestiere, quello vero, ho sempre fatto l’economo, parola desueta oggi indicante chi in un ufficio, in un ente, in una comunità, ha l'incarico di amministrare determinate spese, di provvedere al necessario, oggi si potrebbe identificare come “responsabile degli affari generali” appunto di un ente/comunità. Un Dirigente un giorno mi fece un complimento che io apprezzai anche se era detto in tono tra il serio ed il faceto chiamandomi “Prefetto all’annona” [Il praefectus annonae (prefetto al vettovagliamento) era un funzionario equestre dell'antica Roma preposto alla supervisione dei rifornimenti di grano, istituito intorno al 7 a.C. da Augusto il quale aveva assunto il ruolo di curator annonae dopo la crisi annonaria del 22 a.C. 21 a.C.].Riuscivo con quella cifra a dar da mangiare e da bere tre volte al giorno a tutta la truppa compreso il viaggio in bus da Voghera alla vicina Alta Valle Staffora. Certo non era caviale e champagne, ma un primo abbondante, un secondo con contorno e frutta fresca, non mancavano i biscotti a colazione, latte e caffè e anche della marmellata. Mi rifornivo da grossisti conosciuti e in qualche caso anche generosi, ma anche i piccoli negozi della valle erano generosi nei confronti dei ragazzi, anche se qualcuno non propriamente padrone della lingua ci chiamava “teddy boy” anziché boy scout. Si faceva buon viso correggendo il personaggio per poi fare anche qualche risata. Mille lire scivolate dalle pagine di un libro, un caso fortuito, riportate alla luce come un reperto storico, archeologico, ma che hanno dato la stura a mille ricordi assolutamente piacevoli. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. Nota a margine: Meno piacevole il ricordo del 29 dicembre 1890 giorno in cui avvenne l’eccidio di Wounded Knee, luogo dove il 7° Cavalleggeri sterminò una comunità di indiani Miniconjou appartenenti alla tribù dei Lakota Sioux. Dei pellerossa presenti ne morirono quasi 300 di 350 tra cui donne vecchi e bambini. Morirono anche 25 giacche blu, probabilmente colpite da fuoco amico. Sopravvissero in 51, 4 uomini e 47 fra donne e bambini. In occasione della campagna militare del 1890 in cui avvenne il massacro, vennero insigniti venti soldati, che vi avevano partecipato, della medaglia d'onore, la massima onorificenza conferita dall'esercito degli Stati Uniti. Nel 2001 il Congresso Nazionale degli Indiani d'America emanò due risoluzioni che condannavano la consegna di queste medaglie, soprannominate da alcuni attivisti le "medaglie del disonore".Nel giugno del 2019 una rappresentanza di nove nativi Lakota tra cui alcuni discendenti dei sopravvissuti al massacro, si è recata al Campidoglio a Washington per chiedere nuovamente la revoca delle venti medaglie d'onore.
HOMBRE CON LOS COJONES
Da oltre 100 giorni 18 marinai italiani, più precisamente di Mazzara del Vallo, sono tenuti prigionieri in un carcere libico per una presunta violazione di acque territoriali. Sulla questione è intervenuto il Vescovo di Mazara, Mons. Domenico Mogavero con parole a dir poco durissime ed indignate anche e sopratutto per il silenzio che avvolge la vicenda. Colpisce soprattutto la richiesta da parte di un uomo di chiesa di inviare i nostri corpi speciali nella nostra ex colonia. “E’ ora di mostrare i muscoli, visto che con certa gente è l’unico mezzo per farsi capire”, facendo riferimento ad una medesima situazione occorsa a un naviglio turco, ma da parte di Ankara giunse immediatamente un avvertimento “Non provateci nemmeno!!!!!” e il naviglio è stato immediatamente rilasciato. Ma per prendere certe decisioni di vogliono “Hombre con los cojones**” e non tentennatori come Carlo Alberto di Savoia detto anche Re tentenna. Si ha l’impressione che nel nostro Governo ci sia qualcuno che ambisce a questo titolo, ma haimè sulla pelle di 18 pescatori colpevoli solo di essersi trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Resta comunque il mistero della nostra nave militare che, quasi giunta sul posto in aiuto dei pescherecci italiani, ricevette l’ordine di fare dietro front. Riusciranno i nostri concittadini a fare Natale in famiglia? Stando così la situazione temo di no proprio perche mancano “hombre con los …ecc. ecc.” Chi si ricorda di Sigonella la notte in cui il nostro Governo non si piegò all’arroganza USA. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
**Ma a proposito di “Hombre con los cojones” questa frase fu attribuita ad una ammiratrice del Colonello Tejero, quello che occupò con la forza il Parlamento Spagnolo il 23 febbraio 1981, si arrese solo il giorno dopo quando si rese conto di essere di fatto rimasto solo con 14 armati all’interno del Parlamento Spagnolo. Sparò in aria alcuni colpi di pistola e cerco di atterrare il più anziano dei deputati senza riuscirci, il quale restò in piedi per tutto il tempo che Tejero lo tenne in ostaggio. La colonna di carri armati che doveva arrivare in rinforzo ai golpisti non arrivò mai perché i capi carro nell’attraversare i grandi viali si fermavano ai semafori rossi. Non si seppe mai se lo fecero apposta.
Tanto per dire
"Brisa par criticher" non è nel mio stile, cerco sempre di trovare una giustificazione anche per altri ma..........l'ufficio postale di Casteggio sta dando un disservizio notevole sopratutto per tutti coloro che non possono farne a meno. Orari ridotti, sportelli ridotti, file fuori al freddo e ora sotto acqua e neve, per non parlare dello sportello automatico fuori servizio da parecchio tempo. Io personalmente non ne ho bisogno ma altri ne necessitano. Se devono fare un prelievo devono andare almeno a Lungavilla (fuori comune!!!!!). Possibile che queste lamentele siano solo di poche persone, oppure anche di altri? Si può chiedere a qualcuno che ha più voce in capitolo di chiedere delucidazioni e spiegazioni? Un mio antico capo redattore una volta mi disse "dobbiamo essere voce di chi non ha voce". Sempre per bontà vostra GIU.BA.
GINO
Anche questo racconto faceva parte di quella serie di racconti che scrissi molti anni fa e che ho ritrovato mettendo a posto la mia biblioteca. Come capita, quando si rilegge un vecchio scritto, l’ho rimaneggiato e ve lo propongo. E’ una situazione strana fra il grottesco e il patetico e forse anche un poco a luci rosse.
Gino era calvo pur essendo relativamente giovane; non faceva nulla o comunque poco per aiutare la sua famiglia nei campi lamentandosi continuamente per la sua poca salute che non gli permetteva di lavorare sodo come suo fratello Carlo. Ciò malgrado era riuscito a convincere i suoi a regalargli una Vespa e con questa se ne andava ogni tanto a Voghera a far cosa non si sapeva bene ma molti lo immaginavano: frequentava via Mazza Dorino, nota strada del peccato, per incontri mercenari con qualche vecchia baldracca. Un venerdì mattina, con la scusa di scendere in città per fare il mercato, come se avesse chissà quali affari da fare, si vestì di tutto punto con la “müda” della festa, camicia e cravatta, si pettinò i baffetti che parevano una riga nera pesante sopra il labbro, indossò il finto Borsalino con sussiego piegandolo un poco sulle 23 come si usava allora e mise in moto la Vespa. Gregorio, il suo vicino, cha da casa sua aspettava questo momento, saltò fuori dalla porta gridando “Spetta Gino che vengo con te a Voghera, devo prendere delle cose che mi servono dal ferramenta e ordinare altra mina”. Gino si mostrò contrariato, non voleva nessuno tra i piedi, nessun testimone o complice quando andava a Voghera, in questo caso era un libero professionista, lavorava in proprio. Ma Gregorio era già seduto sul sellino posteriore della Vespa. “ma la tua moto?” chiese Gino “Non va, non c’è benzina, e poi vai già tu, perché fare la stessa strada con due mezzi”. Gino non poteva dire di no e fece buon viso a cattivo gioco. Si incamminarono lungo la strada polverosa e ben presto il piccolo villaggio scomparve alle loro spalle. Arrivarono a Voghera a metà mattina e, dopo aver lasciato il mezzo al deposito cicli stracolmo di biciclette e motorini, si avviarono a piedi verso il centro città. “Ci beviamo un cinzanino” propose Gino con fare di uomo di mondo. “No grazie , sono digiuno e poi a me i liquori fanno male”. “Uei ma il cinzanino non è un liquore è un aperitivo, serve a far venire fame” “Ti assicuro che a me fame viene lo stesso anche senza cinzanino”. Gino si fece servire l’aperitivo al bar e poi si affacciò sulla porta del locale guardando la folla degli agricoltori e commercianti di grano e di paglia sorseggiando l’aperitivo e facendo schioccare la lingua rumorosamente. Gregorio impaziente di concludere le sue commissioni cominciava a pentirsi di essersi affiancato a Gino che era li solo per perdere tempo mentre per lui il tempo era prezioso. “Va bene io vado dal ferramenta” “Io sto qui” “Ci vediamo dopo” “Non perderti muntagnè” disse Gino con aria arrogante. “Questo è tutto scemo” pensò Gregorio. Torno poco dopo con un pacco di chiodi, altre cose e anche un poco di mina per far saltare i ceppi. Gino era oramai al terzo cinzanino. “Hai fatto tutto” chiese “ Fatto tutto, per me si può anche tornare” “E no, io devo ancora fare” disse Gino infilando le dita nella cintura dei pantaloni e dondolando sulla punta dei piedi. Lo sguardo era beffardo e saputo. Depose il bicchiere ed entrambi si incamminarono. “Dai accompagnami”. Attraversarono la piazza del mercato, infilarono una strada larga e dritta e raggiunsero in breve Piazza Castello. Gino se la fischiettava mentre Gregorio lo seguiva perplesso. “Dai sbrigati che ti porto in un bel posto”. La perplessità di Gregorio andava aumentando “Temo di sapere dove vuole andare a parare” pensò. Oltremodo il passo di Gino non era tanto sicuro, anzi ogni tanto incespicava nei suoi piedi ma faceva finta di nulla. Non era ancora mezzogiorno e lui aveva già foderato lo stomaco con due o tre cinzanini. A Gregorio la situazione cominciava a vederla male. Aveva uno strano presentimento. Il mercato stava volgendo al termine e la gente cominciava a sfollare tornando a casa verso i propri paesi, le proprie cascine di provenienza. Uomini che legavano i “panton” i classici fazzolettoni a quadri blu in cui avevano messo la spesa. Infilavano il “panton” nel manubrio della bicicletta poi con un balzo salivano e cominciavano a pedalare. Alcuni di loro avrebbero dovuto percorrere anche 10/15 kilometri prima di arrivare a casa e gli ultimi metri a piedi spingendo la bici carica di borse e fagotti. Fra questa umanità Gino si faceva largo quasi con arroganza: “Questi muntagnè” bofonchiava . Gregorio lo seguiva disapprovando il comportamento dell’amico, scrollava la testa assumendo espressioni con il viso che facevano comprendere la sua disapprovazione nel comportamento di Gino. Arrivarono davanti ad una casa di Via del Pozzo, una stradina che si affacciava a piazza Castello. Gino oramai preso da questa frenesia, bussò con vigore alla porta di un basso e quasi immediatamente si affacciò una donna, parlottarono un attimo poi lei rientrò e Gino appoggiandosi al muro con la schiena si accese una sigaretta. Gregorio seguiva la scena dall’altra parte della strada con un’aria fra la commiserazione e la curiosità. Si riaffacciò la donna che disse “Pronti!”, “dai vieni” disse Gino rivolto all’amico; “Non ci penso nemmeno” ma si era già staccato dal muro di fronte e con la testa bassa e le mani in tasca per seguire l’amico. Gregorio per indole ed educazione faceva chiara distinzione fra il bene e il male e ciò che Gino stava per fare era “Male” con la M maiuscola, ma la curiosità dei suoi anni lo portò verso la casa come se qualcuno alle sue spalle lo spingesse come spingere un barile. La donna era nascosta da una tenda che divideva la camera a metà. Al di qua c’era un tavolo, una stufa economica, altri mobili che avrebbero dovuto dare un aspetto di soggiorno, da sala d’attesa. Sul tavolo una bottiglia di vermouth e due bicchieri già usati. Gino si spogliò velocemente sotto lo sguardo allibito dell’amico, restò nudo come un verme con la pelle bianchiccia , i calzini neri uno rotto in punta. Camminando sui talloni per non appoggiare la pianta del piede per terra aggirò la tenda , ma tornò immediatamente sui suoi passi sempre camminando sui talloni, si versò un mezzo bicchiere di vermouth che bevve in un sol sorso appoggiandosi con una mano al piano del tavolo, si pulì la bocca con il torso della mano, ruttò rumorosamente e ripartì, con la sua buffa camminata, alla carica. Per alcuni momenti Gregorio restò solo in piedi nella stanza accanto, poi sentendo che gli ansimi da dietro la tenda aumentavano accompagnati da gridolini e altri rumori corporei come sbattere, scricchiolare ecc. si affacciò dietro la tenda. La donna, grassa straripante e nuda era coricata su di un materasso senza lenzuola e di dubbia pulizia, appoggiata ad una semplice rete. Gino era a cavallo di questa massa di ciccia e si dibatteva come uno che stava per annegare. Lei era decisamente il doppio di lui. “Dai dai” incitava la donna. Gino sudato si dava da fare ma era una lotta impari, lei allungò una mano e fece partire un giradischi che stava a lato del letto mentre con l’altra agguantò una mela posata su di basso comodino e l’addentò. “Come l’acqua del torrente” cantava lei facendo il verso a Claudio Villa e mentre il disco girava dette un altro morso alla mela. Gino di dibatteva invano su quella massa di grasso tremolante come gelatina. Il disco finì e Gino si risollevo sudato e sgomento. “ Mi spiace Milly ma oggi proprio c’è qual che cosa che non va, forse ho bevuto troppo” “Arrangiati” disse il donnone “Fanno sempre cinque carte da mille lo stesso” “Dai fammi lo sconto, sono un cliente affezionato” piagnucolò Gino. “E no, io ci rimetto, che sconto e sconto, pedalare belu, tla do mè al tabac dal Moru*, feura i sod” poi guardando Gregorio “Vieni tu adesso?” “no,no” rispose lui quasi spaventato. Gino ancora nudo continuava a piagnucolare “E dai facciamo la metà” “Ma che metà e metà, ho detto di no, non è la prima volta che ti capita, se non ce la fai stà a cà tua, capì”. Gino tirò fuori il portafoglio, e contò cinque biglietti da mille lire. Era tutto quello che aveva. Gregorio era basito, Gino stava sprecando dei soldi, una cifra che a lui pareva eccessiva, erano soldi sudati dai suoi genitori, da suo fratello, guadagnati con grande fatica, soldi buttati al vento senza che lui facesse gran che per guadagnarli. Gino era silenzioso , Gregorio pure e si sentiva anche in colpa per non essere riuscito a dissuadere l’amico. Tornarono alla Vespa. Arrivarono al villaggio sempre in silenzio, poi prima di lasciarsi Gino prese per un braccio Gregorio “Tu non hai visto niente e non sai niente, intesi” Gregorio con un gesto brusco della mano lo mandò a quel paese.
*) “Al tabac dal Moru” A Voghera, nella zona dove ora c’è il Teatro Sociale moltissimi anni fa esisteva una trattoria con alloggio e spaccio di tabacchi. Il gestore era chiamato “Al Moru” e nel suo esercizio ospitava anche signore o signorine di “piccole virtù” come diceva Enzo Biagi. Che accadeva: c’erano degli uomini che per uscire di casa trovavano la scusa di andare a comprare il tabacco appunto dal Moru. Ma la scusa venne scoperta poiché non era solo il tabacco che questi personaggi andavano a comprare in centro città ma usufruivano anche di altri servizi che li erano proposti. E tornando a casa trovavano le legittime consorti armate di mattarello che randellandoli gridavano appunto “Dla do me al tabac dal Moru”. Sempre per bonta vostra GIU.BA.
LA DENTIERA. Era cosa buona, anzi buonissima, negli anni passati, organizzare in prossimità delle feste natalizie il pranzo degli anziani, a volte anche la cena di Capodanno. La location era sempre la sala ristorante della Rassegna in area Truffi. E proprio in quelle occasioni a cui partecipavo in veste di consorte oppure di voce narrante, che avevo l’occasione di vivere questo momento assieme alla meglio gioventù di un tempo del nostro paese. L’organizzazione logistica era affidata alla Pro Loco mentre la parte conviviale ci pensavano a volte gli alpini dell’ANA cittadina oppure della ditta di catering che andava per la maggiore in città ovvero la ditta Vittoria di Angelo Moroni. Partecipavano oltre che i legittimi fruitori della cena/pranzo anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, maggioranza e minoranza, la autorità religiose, i due Parroci a volte anche il Vescovo, il Comandante della Stazione dei Carabinieri e rappresentanti delle associazioni. Sta di fatto che i convitati erano quasi sempre circa duecento persone. Fatta questa doverosa premessa è bello raccontare aneddoti e situazioni che vale ancora oggi la pena di ricordare. Una volta dopo i soliti e, lasciatemolo dire, abbastanza noiosi e banali discorsi di benvenuto delle autorità, il Sindaco invitò il Parroco a benedire i presenti anche con due parole di circostanza ma, una voce dal sen fuggita gridò “Al ghè no!” non c’è, a quel punto il Sindaco con grande ironia disse “Va bene, vorrà dire che la benedizione ve la darò io” e alzatosi in piedi con la mano destra tracciò in aria una sorta di segno benedicente, ma con grande stupore dei presenti un buon 80% dei presenti si fece il segno della croce. A questo punto un consigliere di minoranza che poteva dare del tu al Sindaco, essendo pur all’opposizione ma amico comunque, esordì “Ti resta solo di camminare sulle acque e moltiplicare i pani e i pesci” Ma l’episodio che io ritengo degno di nota fu quello che successe ad una cena, forse di Capodanno, organizzata come sempre dalla nostra Pro Loco e dalla e per l’Associazione Anziani cittadina. Dunque eravamo li riuniti, quando nel bel mezzo della serata, l’amico Pietro Peveri allora Presidente della Pro Loco mi avvicinò e in orecchio, trattenendo a stento una risata, mi disse:” Uma truà na dintera” abbiamo trovato una dentiera, “Come, una dentiera??” “Si una delle cameriere mi ha segnalato appoggiata su di una sedia una dentiera, a questo punto tu dovresti prendere il microfono e annunciare: è stata ritrovata una dentiera chi l’avesse smarrita la può recuperare presso di noi” “ Ma no” dissi io, “non è mica un bambino in spiaggia da far recuperare dai genitori” Tutto questo avveniva mentre noi due avevamo le lacrime agli occhi e ci sbellicavamo dalle risate che non riuscivamo a trattenere. Ma insomma, ci chiedevamo, come si fa a perdere la dentiera, uno la tiene in bocca, oppure la porta in tasca e la mette in caso di necessità, quale potrebbe essere un altro motivo per cui uno la deposita su di una sedia? Questo non lo avremmo mai saputo anche perché nel frattempo il suo proprietario si era presentato a qualche organizzatore della serata ed era tornato in possesso del prezioso accessorio e ci fu pure riferito che il titolare dell’oggetto senza por tempo frammezzo se la era subito infilata in bocca risciacquandola con un bicchiere di vino rosso, disinfettata e basta così. Bei tempi caro Pietro, fa un buon cammino amico mio. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
BREVE STORIA DA SOLLEVARE LO SPIRITO Figüra da ciculatè La vera storia del detto piemontese ma utilizzato in buona parte del Nord Ovest dell’Italia del nord. In Emilia ad esempio, a Piacenza, si dice “fare la figura da cioccolatino” e probabilmente si tratta di una variazione sul tema di questo modo di dire. Sembra che l’origine di questo detto risalga ad un moto di stizza cui si abbandonò Re Carlo Felice di Savoia, il sovrano, nonostante il suo proverbiale self-control e il suo regale à plomb, quando venne a sapere che un noto mastro cioccolataio torinese, le cui virtù nella lavorazione del cacao gli avevano consentito un rapido arricchimento, da qualche tempo percorreva la città a bordo di una carrozza trainata da quattro cavalli. La vettura, costruita da un abile mastro carradore, era particolarmente sfarzosa, tant’è che il popolo la scambiava con quella del re. Carlo Felice si sentì ferito nel suo orgoglio di Re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme, e contrariato da tanto ardire abbandonando l’etichetta di corte, avrebbe allora esclamato, con un gesto di evidente stizza e intemperanza: «I veuj nen fé na figura da ciculaté!», e avrebbe di conseguenza imposto all’ambizioso cioccolataio, che aveva ostentato così platealmente la propria ricchezza, girando la città a bordo di una carrozza trainata da una quadriglia, di limitarsi ad un più modesto tiro a due. Era infatti esclusivo dei nobili il traino a quattro, mentre per i borghesi si dovevano limitare a un tiro da due soli cavalli. La sua indignazione fu tale nel sentirsi messo in ombra dal cioccolataio di fronte ai suoi sudditi che decise di portare a sei il traino delle carrozze reali al fine di distinguersi da quegli arricchiti così presuntuosi da voler rivaleggiare con lui. La frase pronunciata da Re Carlo Felice divenne così sinonimo di una bella figuraccia (Emilio Fede docet "che figura di m......). Da quel giorno e con quell’avvenimento, il detto divenne di uso comune e si diffuse per il resto del paese assieme alla fama sempre più illustre di Torino e dei suoi cioccolatai, le loro opere di pasticceria e le loro invenzioni. Bicerìn, gianduiotti e cremini dalla qualità e raffinatezza indiscutibili, per chi offrendo un regalo non vuole fare figuracce, o meglio… la figura del ciculaté! Il nome di questo audace, ma anche un po’ superbo, artigiano è andato perso, ma non l’ilare evento. Ci piace tuttavia pensare che Carlo Felice fosse molto ghiotto di cioccolato e che, nella degustazione di una calda tazza di cioccolata, potesse trovare qualche momento di felicità poiché si narra fosse solo Felice di nome ma non di fatto. Chissà: forse, prima di firmare l’editto con cui voleva impedire ai borghesi l’uso di carrozze con tiro a quattro, si era fosse nel laboratorio di quel cioccolataio impertinente, per tastare di persona le sue prelibatezze, tanto decantate dal popolo. E vogliamo immaginare che il re – rapito dal gusto inimitabile del suo cioccolato – avesse deciso di non firmare l’editto, e che si fosse limitato a far praticare al cioccolataio una semplice tiratina d’orecchi. T’è capì Giuan. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
Telefono e bon ton: Sto per affondare, non senza un lampo di beatitudine negli occhi, la forchetta nella cofana di spaghetti che ho davanti, e chi mi conosce sa bene quanto io apprezzi questa pasta (tra gli altri Flavio Oreglio e Stefano Belisari alias Elio delle Storie Tese che mi sono stati compagni in abbuffate notturne) che, come se avesse capito tutto, il telefono comincia a squillare. Brutte parole, titoli nobiliari ed altro a colui il quale ha deciso malauguratamente di chiamare casa mia all’ora di pranzo. Ma l’invadente numero uno il telefono, ha colpito ancora. Più di una volta ho pensato di inserire nella segreteria telefonica un messaggio con l’esortazione a chiamare dopo. “Stiamo mangiando chiamateci più tardi” ma ho scoperto delle resistenze da parte della famiglia “E’ l’unico momento che ci trovano a casa” “ ma tutti oramai hanno i telefonini!” “Si però……ma, se…….. ecc.”. Insomma, puntuale come un cronometro svizzero, appena uno si siede a tavola quello squilla. E io mi domando: ma gli altri non mangiano nelle ore canoniche del pasto. L’Italia tutta dalle 12 alle 14 si ferma. Lungo le strade della penisola le trattorie si riempiono, gli autogrill traboccano, le mense, gli snack-bar, i self sono pieni di un mondo di gente che all’unisono affondano le forchette nelle cofane di pastasciutta, milioni di forchette che battendo sui piatti rompono il silenzio meridiano dei paesi di campagna; ma uno no, uno, solo uno in quel momento sta facendo il mio numero di telefono. “Ti hanno già cercato almeno tre volte” “Ma chi è?” “non vuole dire il nome”; “ma come non vuole dire il nome”, e chi sarà mai, l’agente 007 al servizio di Sua Maestà, e purtroppo questa italica abitudine l’hanno in parecchi: “Ma chi lo cerca?” e qui dall'altro capo del telefono si tergiversa “No, non importa, richiamo io dopo, lasci stare” o peggio ancora “Un amico…….”. Come un amico, se poi è detto con il tono da film “Il padrino” chi di casa ha la ventura di rispondere può pensare di tutto: il mio pusher personale di prosciutto crudo o di parmigiano reggiano, lo spacciatore che mi fornisce le foto di Giancarlo Magalli nudo, di tutto e di più. E questo vezzo di non dire il proprio nome quando si chiama, cose le quali oltre a chiamare nelle ore canoniche di pranzo o cena, è ciò che mi fa irritare maggiormente. Ci vorrebbe un manuale di istruzioni comportamentali rivolto a chi usa il telefono/ino, perciò tutto il mondo, un versione del libro Bon Ton di Lina Sotis dedicato interamente a questo nuovo tormento mediatico e tecnologico a cui oramai più nessuno può fare a meno. E per questa volta mi sono solo limitato a parlare di telefoni cosi detti fissi in generale, senza affrontare il tema più spinoso dei telefonini in particolare di cui, relativamente a un galateo aggiornato alla bisogna, ci sarebbe molto da dire: “Ti disturbo……..???” “Ma per carità……sono in bagno seduto sul water!!!!!”. Complimenti per l’amabilità della risposta, da vero gentleman. E per fortuna non era una videochiamata, altra diavoleria. Ridiamoci su brava gente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
GIUSTO PER CAPIRE
Mia mamma abitava, negli ultimi anni, a Salice Terme in zona Bellevue, quindi in collina, nei pressi di un locale una specie di pub con musica che si chiamava "CieloFan". Ovviamente nelle sere d'estate si riempiva di gioventù che saliva li per passare la serata in compagnia. Il DJ ci dava dentro e anche gli avventori non erano di meno. A qualcuno dava fastidio sia la musica che il vociare dei ragazzi che li passavano la serata. Una sera una signora che si era auto eletta referente del vicinato, suonò alla porta di mia madre con un foglio e spiegò che stava raccogliendo le firme per far chiudere il locale. Una volta che ebbe capito il motivo della visita squadrò la tipa e sbottò con "La gent la ghà da laurà!!!!". E' giusto ricordare che la mia famiglia ha sempre gestito locali pubblici e la mamma era stata insignita con l'Aquila d'oro per il commercio. Doveroso premessa per introdurre il tema: vorrei sapere quale mente contorta ha stabilito che gli ambulanti no food, quelli che non possono partecipare ai mercati, possono però esercitare il loro commercio in maniera itinerante purchè stiano a 250 metri l'uno dall'altro. 250 metri......??? e perchè non 500 oppure 127, con quale criterio si è stabilita questa distanza. Ah saperlo. "La gent la ghà da laurà". Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
Tanto per dire
Il limite psicologico dei 20€ come prezzo dei libri, è stato oramai abbondantemente superato e ci stiamo avvicinando ai 30€. Per coloro che come me fanno ancora i conti con la vecchia lira, significa che un libro può anche costare £. 60mila lire. Infatti il primo in classifica fra la narrativa straniera ovvero Ken Follet con "Fu sera e fu mattina" è in vendita a €.27. Mentre il primo in classifica nella narrativa italiana "il Falco" di Sveva Casati Modignani si vende a 19,90€. forse hanno avuto il pudore di non aggiungere 10 centesimi. Come si fa poi a dire che in Italia si legge poco quando poi le case editrici chiedono certe cifre per un libro.
Tanto per dire. 15km. carico e 20km. scarico ovvero con e senza zaino 10/12 kg. acqua compresa, se qualche "presidente di Regione" vuole sfidarmi per vedere chi arriva ancora in forze sono qui. Classe '44 tanto per dire appunto. E questa è una distanza di tutto riposo.
Premessa: questo racconto, che doveva far parte di una serie di racconti bucolici e giovanili, che io scrissi almeno 35 anni fa ritrovati nel mettere a posto la mia biblioteca personale e questo l’ho rimaneggiato un poco e ora ve lo propongo. Sempre per bontà vostra. FELICIN E L’IMPICCATO La mamma lo chiamò presto quella mattina: “ Alzati Felicin che devi portare la capra da Pidrè”. Felicino, anzi Felicin, 10 anni di pelle e di ossa, saltò in piedi in fretta , quell’incarico che gli aveva dato suo padre era un punto di orgoglio: portare la capra alla monta a Cà du Rì da Pidrè. Cosa significasse poco gli importava, ciò che gli importava era il fatto che il suo papà gli aveva affidato un incarico importante. Fu presto in cucina davanti ad una tazzona di latte appena munto con due belle fettone di pane di micca da intingergli dentro. Mentre era intento alla sua colazione entrò Gregorio suo fratello maggiore, gli passò una mano tra i capelli lisci e castani arruffandoglieli. “Uei Felicin porti la capra alla monta allora?”. Felicin annui con la testa mentre Gregorio, dopo aver tagliato un pezzo di salamino prese un pezzo di pane dal tavolo davanti al fratellino e cominciò a masticare. Mamma Maddalena e Teresa, la sorella mediana, finirono di preparare il “panton” con la colazione del babbo e del nonno, che stavano nei campi oramai dalle 5 del mattino e lavoravano la terra con i buoi. Teresa prese anche una fiasca di granà fresca, appena tolta dalla cantina e si incamminò per portare da mangiare agli uomini. Felicin si mise le scarpe, usci nel cortile sul retro della casa, entrò nello stallino, staccò la capra, lego una corda al collare della bestia e si incamminò verso il bosco. Doveva risalire per una tratto il bosco, girare a sinistra, aggirare il profondo canalone in fondo al quale gorgogliava un ruscello e dirigersi a casa di Pidrè che abitava a Cà du Rì . Il sole cominciava a percorrere il suo tragitto in cielo e lui lo aveva proprio di fronte. Era abbacinato dalla luce e ogni tanto si doveva fare schermo con la mano sulla fronte per orientarsi. Luoghi erano familiari, lontano oltre le colline con i boschi che circondavano la valle. Qualche piccolo paese qua e la, case sparse, il paese dove lui andava a scuola, era l’ultimo anno, a ottobre sarebbe andato in quinta e poi a Voghera per le medie. Si senti un grido “Mina” e poi una esplosione che fece vibrare l’aria . Guardò la montagna di fronte, sull’altro lato della valle. Era suo fratello Gregorio che stava disboscando un pezzo di monte per farci una vigna nuova.. Dopo aver tagliato le piante e strappato le radici di quelle piccole, faceva saltare i ceppi più grossi con la mina. Era in gamba Gregorio, pensò, proprio in gamba. A lui sarebbe piaciuto andare ad aiutarlo in quei giorni, ma Gregorio gli raccontava di orribili mutilazioni che sarebbero state subite da fantomatici ragazzini che avevano maldestramente maneggiato la mina. Felicin sapeva bene che Gregorio esagerava, che gli raccontava favole, ma aveva fatto sempre finta di credergli consapevole che, pur piacendogli, era un lavoro molto rischioso ed era meglio non girare tra i piedi del fratello mentre lo faceva. Gregorio, malgrado l’esperienza e l’attenzione, era nervoso nell’eseguire i preparativi della mina e farlo inciampare o impedirlo nei movimenti poteva fargli scappare qualche scufiotto, meglio girare alla larga. Attese in silenzio seduto su di un sasso, nel sole del mattino. La capra, tenuta al guinzaglio, brucava li attorno. L’aria era immota ed il calore del sole cominciava a farsi sentire. “Mina” senti nuovamente gridare e dopo qualche istante una nuova esplosione. Si portò sorridendo i palmi delle mani sulle orecchie per ripararsi dal rumore che comunque era lontano. Lontano ma quasi amico, sapendo che era causato dal fratellone quasi un non so che di familiare. Si rialzò dal sedile di sasso, si spolverò con una mano il sedere per staccare la terra e la polvere dai calzoncini e si rimise in viaggio. Aggirato il canalone dall’alto cominciò la discesa verso il villaggio dove abitava Pidrè sempre tirando la sua capra. Per fare prima non usò il sentiero ma attraversò un campo di stoppie, si infilò in una forra di bassi castagni e noccioli ed usci in campo di erba medica. Aveva il sole di fronte. Si portò la mano sugli occhi per difendersi dall’abbacinamento e per guardarsi intorno. Quel sole di fronte lo obbligava a tenere lo sguardo basso. Passò sotto una pianta di ciliegie ed ad un tratto davanti al suo viso vide due piedi. Trasalì. Due piedi sospesi nel vuoto che dondolavano come mossi dalla brezza. Alzò piano piano lo sguardo, i pantaloni, la cintura, si fermò un attimo, il terrore gli attanagliava lo stomaco. Il cuore gli batteva forte, lo sentiva in gola, si fermò un attimo e alzò lo sguardo in modo di vedere tutto in una volta. Un uomo pendeva dal ramo del ciliegio con una corda attorno al collo. L’espressione del volto era orribile, la lingua fuori e gli occhi che pareva volessero uscire dalle orbite e poi l’odore……Un odore misto di feci e di orina ma molto più forte di quegli odori familiari di cesso sulla buca del letame, una puzza marcia, profonda, un odore che non avrebbe mai più sentito nella sua vita anche se lo avrebbe ricordato sempre, una sorta di deja-vu che tornava a riivisitarlo con ribrezzo e angoscia. Felicin era pietrificato, il sole negli occhi e la capra che brucava attorno legandolo con la corda. Non riusciva a muoversi, voleva gridare ma la voce non usciva, non riusciva a reagire. L’impiccato lo aveva ipnotizzato. Il vento faceva muovere i rami del ciliegio e l’uomo ondeggiava lentamente nel sole come un orrendo gioco di ombre cinesi. Quanto rimase li Felicin non lo seppe mai: un’ora, un minuto, era paralizzato di fronte alla morte. Ma se di morti qualcuno lo aveva già visto, la nonna ad esempio composta nel letto con gli occhi chiusi e l’espressione come se dormisse o la bambina dei mezzadri veneti, morta di malattia, ma nessuno era orrendo e terrificante come questo. Si sentì toccare una spalla, finalmente dal profondo della gola qualcosa si liberò e usci un grido di terrore. Finalmente a squarciagola un urlo liberatorio ma senza osare muoversi. Chi lo aveva toccato? La Morte? Il lungo scheletro bianco con il mantello nero e la falce così come lo aveva visto nelle illustrazioni che era venuto a prendersi quei poveri resti e fors’anche lui? Si senti stringere le spalle e venne trascinato via mentre una mano pietosa gli copriva gli occhi. “Ve via, Felicin ve via”. Erano Pidrè e sua moglie che, anch’essi in giro per i campi avevano visto lo spettacolo orrendo ed erano corsi al ciliegio. La donna prese Felicin e se lo tenne sotto il braccio come avrebbe fatto una chioccia con le ali per un pulcino e trascinando la capra con l’altra mano si diresse verso il paese piangendo sommessamente. Il povero morto era suo fratello, un po’ pazzo, un po’ strambo, un uomo che tornato dalla Grande Guerra nessuno aveva mai capito o curato e che la cui mente si dibatteva fra momenti di lucidità con momenti di cupa depressione sempre in lotta con i suoi fantasmi che lo svegliavano di notte con incubi terribili….: “la mitraglia, la mitraglia….avanti avanti…”e che quella mattina di luglio aveva deciso di fare finire quegli incubi legandosi una corda al collo e lasciandosi dondolare fra le rosse ciliegie sulla strada di Felicin, 10 anni di pelle e di ossa. Il sole era oramai alto, l’aria era calda, dai campi saliva il profumo delle stoppie e della terra, una pernice disturbata dal trambusto s’involò frullando l’aria cocente scomparendo tra i castagni. GIU.BA.
Tanto per dire
"Chi vive sperando, muore cagando! Sergentre Nicola Lorusso, da un'isoletta dell'Egeo che non conta un cazzo, 1941, e sono anche un autore!" [Riferito ai fratelli Munaron che esprimevano il desiderio di tornare a casa dopo aver visto una stella cadente ] Dal Film Mediterraneo
NOTE A MARGINE.
Non mi entusiasmo eccessivamente circa le dichiarazioni del’eurodeputato pavese Angelo Ciocca, ma devo condividere la sua opinione quando recentemente ha avuto occasione di sottolineare che se il virus avanza in certi paesi europei è anche la mancanza o la scarsa igiene che i cittadini di questi paesi praticano citando Francia e Spagna. Ho frequentato in questi ultimi anni la Spagna del Nord (Galizia. Asturie, Cantabria), per il sud non ho esperienze, e devo dire che a parte alcune situazioni, non sempre, ad esempio, si trova il bidet, la pulizia e l’igiene delle persone e dei luoghi è molto simile alla nostra, noi forse siamo un poco più “ossessionati” dalla pulizia. Nei miei vari Cammini solo un paio o forse tre volte mi sono trovato in situazioni imbarazzanti in fatto di pulizia e negli hotel ho sempre trovato tutto ciò che mi garantiva igiene. Poiché per vari motivi mi sono sempre accompagnato con pellegrini spagnoli, ricordo una volta in cui ho avuto uno scambio di opinioni, anche se ironiche, con una pellegrina galiziana: “el bidé es solo para lavarte el culo” “claro incluso después de las necesidades, a las chicas con las reglas y antes y después del amor, tu no lo usarías ???”. La ragazzotta si zittì con un sorrisetto perplesso. Ma veniamo invece ai francesi. Una sera stavo arrivando a piedi da Taizè, la famosa comunità religiosa, alla stazione di Macon. Avevo camminato tutto il giorno sotto la pioggia e nel fango assieme all’amico Piero. Arrivato a Macon in attesa del treno avevo deciso di cambiarmi camicia e pantaloni e scarpe nei bagni della stazione, ma appena entrai nei servizi pubblici dovetti desistere tanto era il lordume stratificato che c’era. Mi cambiai poi in treno chiudendoci a turno nello scompartimento. Ma non solo in quella occasione, anche altre volte in Francia mi sono trovato nella condizione di “arricciare il naso” in hotel (dove non esistono bidet) o in qualche bistrot o ristorante. Ritengo che la scarsa attitudine all’igiene possa veramente favorire il propagarsi del virus in alcuni paesi europei, non certamente in Austria. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
La responsabilità civile dei venditori di cyclette da camera e di tapis roulant. Avete fatto caso che negli angoli degli orti, sotto i portichetti nei posti più reconditi del cortile, dove oramai crescono le erbacce e dove sino ad ora venivano relegate vecchie automobili, botti rotte, qualche rete da letto, appaiono sempre più di sovente anche le cyclette da camera. L’altra sera nel piazzale ex Crivelli a fianco dei cassonetti giaceva tristemente abbandonato un tapis roulant. Questi strumenti tristi ed arrugginiti lasciano capire che hanno avuto tempi migliori come quando troneggiavano nel salotto di casa. Ma chi non ha la possibilità di disfarsi in questo modo dello strumento, lo mette nella camera degli ospiti trasformandolo in appendiabiti dove vengono appese le camice appena stirate e sul sellino della cyclette le lenzuola piegate. Ma veniamo all’antefatto. A chi non è capitato, agguantandosi quel salvagente di ciccia che fa capolino dalla cintura dei pantaloni, di dire .” Da domani un po’ di movimento altrimenti qui divento un ordigno” e cosi con grande determinazione e fiducia in se stessi ci si presenta dal rivenditore il quale furbescamente illustra i pregi miracolosi di questi strumenti di ginnastica: in fondo che ci vuole: 10 minuti al giorno di cyclette o di tappeto, nella comodità di casa vostra e la pancia non c’è più proprio come diceva una nota pubblicità di un olio negli anni ’60. Il rivenditore, se è bravo, vi rifila l’ultimo modello, quello con il computer di bordo, che calcola il tempo le calorie i kilometri percorsi ecc. ma lo sciagurato non vi dice che poi bisogna anche pedalare/camminare e che se volete avere risultati dovete fare alcune centinaia di chilometri alla settimana. E così nella tranquillità della vostra camera, cominciate ad usare questi aggeggi. Ma dopo alcuni minuti vi accorgete che non solo è faticoso ma anche e soprattutto noioso e allora ascoltate della musica dal telefonino con gli auricolari, oppure la televisione, i più acculturati pedalando leggono il giornale o addirittura un libro. In Italia è statisticamente provato che ben pochi leggono libri o giornali figuratevi se poi oltretutto si deve anche pedalare. E cosi dopo alcuni giorni gli appuntamenti aerobici con la cyclette/ tappeto si diradano sino a dimenticare addirittura di possederne una, Qualcuno ne ha comprata un’altra convinto di non averne mai posseduta una oramai sommersa da giacconi e coperte. Eppure la volontà di tornare in peso forma è un desiderio che interessa in molti, giovani meno giovani e anche adolescenti. E per alcuni di questi adolescenti a volte la pinguedine diventa un dramma; finché si è bambini e i grandi dicono “Vhè che bel paciu” tutto va bene, ma dopo si scopre che il bel paciù a difficoltà di rapportarsi con gli altri e questo non è solo per i soliti modelli stereotipati di personaggi sempre in forma sempre belli, ma anche per problemi di salute, per una cattiva alimentazione. Ma fermiamoci qui altrimenti ci inoltreremmo in orizzonti inquietanti che ci porterebbero lontano. Torniamo a questi attrezzi pseudo sportivi ed alla responsabilità civile di coloro che non ci dicono le cose come stanno che in sintesi potrebbe stare nella frase:” hai voluto la cyclette e allora pedala o corri oh lurluk!!!!”. Allora andate in palestra che forse è meglio e per non lasciarvi prendere dalla pigrizia pagate prima è una formula per incentivare la voglia di allenarvi e io da buon genovese, visto che ho pagato….sono quasi sempre presente, non voglio mica rimetterci anche dei soldi?! A proposito: lo slogan pandemico “andrà tutto bene” per alcuni è diventato “andrà tutto stretto”. Vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. P.S. la foto si riferisce a come te la propone il venditore, poi la verità sarà ben altra.
SOSPENDETE GLI ALCOLICI E’ ARRIVATA LA STAMPA: Era il “grido” che un personaggio lanciava ogni volta che entravo nel mio solito bar per l’aperitivo delle 19,00. C’erano i soliti, tutti amici e/o conoscenti, si beveva un buon bianco, anche se a volte si faceva il cosi detto “giro”. Quello era più pericoloso, al secondo giro si era un poco più ciarlieri, ma al terzo si cominciava a ridere per nulla, almeno io. E c’era appunto questo personaggio, il classico “milanese imbruttito” trasferito in Oltrepo’ a far cosa non si è mai capito. “Mi interesso di cose, vedo gente, ho un affare fra le mani che se va bene mi sistemo ecc. ecc. “. Faceva il verso, e questo al terzo giro di bianco, al classico dandy da tennis club Milano, quello in Via Arimondi, quel dandy sempre di bianco vestito, abbronzato, con la racchetta nella custodia, mai visto giocare, che si pavoneggiava con tutte le signore, pure loro bianco vestite da tennis, saltellando da un tavolino all'altro al bar del club, alternando simpatici aneddoti a confidenze riservate su quello o su questo:” Ragazze, ma lo sapete cosa ha combinato il Giangi l’altra sera, da morire dal ridere, da morire”, le signore ovviamente fingevano interesse, salvo poi ignorarlo. Quasi meglio di Ezio Greggio nei cinepanettoni. Una volta in Corso Genova a Milano, avevo notato in un noto negozio di antiquariato un oggetto che mi interessava e ne avevo parlato agli amici al bar, lui intervenne nella conversazione e disse “Ma io conosco bene la titolare di quel negozio di antichità, se va dica pure che mi conosce”. Detto fatto, una sera all’uscita dal lavoro (in quel periodo andavo al lavoro in macchina) nel tornare a casa mi fermai e entrai nel negozio. Era veramente una signora la titolare del negozio, mi fece vedere l’oggetto e al momento dello stabilire il prezzo, nella speranza che la conoscenza avrebbe influito sulla trattativa, feci notare la conoscenza del tipo in questione. La signora a quel punto si irrigidì, divenne gelida e praticamente sparò una cifra inarrivabile per me ma anche per l’oggetto. Troppo caro, dissi, e feci per andarmene a quel punto la signora, sempre con aria gelida “Se avesse occasione di vedere il Signor xxxx dica pure che stiamo ancora attendendo e lui sa bene cosa”. A sera al ritorno al solito bar lui mi annunciò con la solita frase “Sospendete gli alcolici……” ed io “Temo che ci sia ben altro in sospeso in Corso Genova a Milano” ma lui non fece una piega e ignorando la mia frase continuò con la solita facondia per poi dichiarare: “Pagà e murì ghé semper temp”. E allora sospendiamo gli alcolici. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
PROIBITO DA CHI??? Sono rimasto molto colpito dalla vicenda che ha visto coinvolto il Sottufficiale della Capitaneria di Porto Aurelio Vissalli nel mare antistante Milazzo in Sicilia nel tentativo , in parte poi riuscito per entrambi i ragazzi, di portare in salvo due giovani bagnanti che si erano tuffati nelle acque tempestose malgrado il divieto di balneazione proprio per il mare agitato. Mi è venuto in mente quando molti anni fa collaboravo alla gestione della seggiovia di Pian del Poggio. Il giorno prima il vento di scirocco aveva portato nebbia e un poco di pioggia, ma durante la notte successiva il vento era cambiato e aveva dato spazio alla tramontana, una gelata sotto zero che aveva creato sulle piste di neve uno strato di ghiaccio facendole diventare una pista di pattinaggio. Io stesso recatomi alla stazione a monte non ero riuscito a stare in piedi, anzi ero scivolato per un bel pezzo senza riuscire a fermarmi. Il direttore della scuola di sci e responsabile del soccorso in pista, assieme al titolare dell’impianto avevano deciso di limitare alla stazione intermedia la fruibilità delle piste. Oltremodo in vetta soffiava un forte e gelido vento. Parecchi appassionati che erano arrivati sulle piste avevano deciso di rinunciare, alcuni si erano buttati sulla gastronomia dei ristoranti approfittando dei luoghi caldi e sicuri, solo alcuni si avventuravano sulle piste, ma fermandosi rigorosamente a metà e da li poi scendevano con grande precauzione. A un certo punto della mattinata si presentò un tizio alla stazione di partenza al quale gli addetti alla seggiovia raccomandavano di scendere a metà, che era proibito salire in vetta, ma lui con fare sprezzante rispose: “Proibito da chi???” a cui risposero appunto dal servizio di soccorso “E’ pericoloso” ma lui con un gesto della mano li mandò a “farsi friggere” e inizio a salire. Alla stazione intermedia l’operatore si sbracciò invitandolo a scendere, ma anche qui il braccio indicò all’uomo di andare a fare……Alla stazione a monte, comunque presidiata, l’addetto si mise le mani fra i capelli quando lo vide partire e dopo solo cinquanta metri cadere sulla pista ghiacciata ed iniziare a prendere velocità mentre disperatamente cercava di fermarsi. Perse gli sci e con un salto, come una palla impazzita, si infilò nel bosco a sinistra poco prima della curva a gomito. Nel bosco, come una pallina del flipper, cominciò a sbattere a destra e sinistra contro gli alberi sino a fermarsi definitivamente ai piedi di una pianta. Con grande difficoltà arrivò il soccorso, lo staccarono dalla pianta alla quale si era avviluppato ed a ogni movimento cacciava urla di dolore, miagolava come un gatto in amore, piangeva solo a guardarlo. L’ambulanza si era fermata sulla strada dell’Armà (per chi conosce i luoghi). I soccorritori e il medico della CRI non sapevano come prenderlo, poi finalmente sul taboga venne portato all’ambulanza e poi all’ospedale. Una trentina fra fratture e lussazioni, non avrebbe mai più sciato! Proibito da chi……da chi ritiene che metti a rischio la tua vita e, come in questo caso, la vita degli altri. Dopo si parlerà dei dispositivi di sicurezza del mezzo di soccorso che non c’erano o che non erano stati indossati, dopo però, oggi piangiamo un uomo, un eroe, che non si è tirato indietro anche davanti all’idiozia degli altri. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
IL MACELLAIO: "E il macellaio che mi parlava di sesso per tutto il giorno era fatto della stessa carne, ma calda, e di volta in volta molle e dura; il macellaio aveva i suoi pezzi di prima e di seconda scelta, esigenti, avidi di bruciare la loro vita, di trasformarsi in polpa".no non è di questo macellaio, romanzo erotico di Alina Reyes e diventato poi film interpretato da Alba Parietti dove in una scena veniva, per usare un eufemismo, “strapazzata” in una cella frigorifera, dal macellaio in questione, ma di un altro macellaio, un mio lontanissimo parente. In un periodo antecedente alla mia assunzione in quel di Milano, facevo il rappresentante di prodotti alimentari e liquori, avevo tra le mie aree di competenza anche il basso Piemonte, zona di provenienza di una certa parte della mia famiglia paterna appunto ligure piemontese. Mio padre quando seppe che bazzicavo la zona Serravalle, Arquata, mi informò del fatto che in zona Bettola di Novi viveva un lontano parente che aveva una macelleria proprio sulla provinciale. “se passi da quelle parti entra e fatti riconoscere”. Infatti un giorno che passavo di li, vidi l’insegna ed entrai. Questo personaggio stava proprio servendo una signora, la macelleria era di quelle “di una volta”, bancone elevato dal piano, tutto di marmo bianco, bisognava fare due scalini per raggiungere il posto operativo. Quindi dominante. Tutto attorno due o tre mezzene di bovini appese ai ganci, ambiente fresco quasi freddo, e lui un omone in camice bianco, sporco di tracce di sangue e mannaia nelle mano destra. Finito di servire e accomiatare la signora, si rivolse a me con un sorriso professionale :”prego desidera”, ed io “sono Balestrero di Voghera, figlio di Franco e nipote di Rosetta moglie di Carlo, suoi parenti.” E lui dopo un attimo di perplessità “ma certo e come state” e li a scambiare convenevoli e saluti reciprochi “Salutami la Rosetta e tuo papà”.E tutto fini li. Un mesetto dopo trovandomi a passare ancora di li mi rifermai e la scena si ripeté per una seconda volta :”prego desidera”, ed io “sono Balestrero di Voghera, ti ricordi, figlio di Franco e nipote di Rosetta, moglie di Carlo tuoi parenti.” E lui “ma certo e come state” e li a scambiare di nuovo convenevoli e saluti reciprochi “Salutami la Rosetta e tuo papà, quando passi vieni dentro, dai che mi fa piacere”. E va be’, per questa seconda volta ci stava, non può mica sempre ricordarsi di tutti, clienti compresi. Ma dopo un altro paio di mesi siccome mi ricapitò mi presentati di nuovo e alla reiterata “prego, desidera” a questo punto sbottai “Ma va a ciapà di rat” tutte le volte ti devo spiegare l’albero genealogico di tutta la mia famiglia. Precisazione: da buon mandrogno non mi ha mai dato nulla ne tantomeno offerto neanche un caffè o un bicchiere d’acqua. C’è un proverbio nell’alessandrino “vedi quel camino la è casa mia, ma sat vo’ mangià e bev va all’ustaria” Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
LA SOPA DE AJO – LA ZUPPA D’AGLIO. 11 giugno del 2006, arrivo alla parrocchiale di San Juan de Ortega verso le 17 di un pomeriggio assolato e solitario. Gli ultimi 9/10 km. lo ho percorsi in perfetta solitudine in un sali e scendi attraverso i Monti dell’Oca nel bel mezzo della Castiglia y Leon. Trovo dei pellegrini italiani con i quali sto condividendo alcune tappe, i quali, in attesa del mio arrivo, mi hanno messo in fresco una birretta la quale scende in gola provocando sensazioni di refrigerio benefico. Come gli altri metto i piedi a bagno in un fontanile con vasca. Mi comunicano che il rifugio non merita commenti, è degradato ed infatti mi lavo un poco al fontanile giusto per non recarmi alla messa sporco ed impolverato. La piccola chiesa è un gioiello di stile romanico costruita attorno alla tomba del Santo dalla Regina Isabella di Castiglia la Cattolica e a celebrare la messa sarà il parroco Don Josè Maria un anziano sacerdote carico di carisma e spirito di servizio insomma uno destinato a diventare “Santo Subito”(*). Funzione molto bella e partecipata, arricchita da un coro di pellegrini tedeschi, con benedizione finale ai pellegrini presenti. Alla fine della messa Don Josè Maria, dopo aver raccontato la storia della sua chiesa e del famoso “miracolo della luce” annuncia che presso la mensa della parrocchia verrà distribuita la tradizionale e famosa sopa de ajo. Appena udita la parola ajo ovvero aglio faccio un tentativo di defilarmi ma vengo arpionato da due dei pellegrini varesini e sollevato di peso sotto le ascelle e portato verso la mensa. “se la mangiamo noi, la devi mangiare anche tu!!” cerco di divincolarmi e sfuggire alla prova ma non c’è nulla da fare. Sono sempre stato contrario all’aglio nelle pietanze, mi rinviene, mi puzza l’alito, capisco che sul Cammino di Santiago è impensabile avere incontri ravvicinati con il gentil sesso, ciò non toglie che sarei comunque imbarazzato se dovessi avere un colloquio con chicchesia con un alito pestifero. Faccio buon viso a cattivo gioco e mi appresto a sorbirmi questo amaro calice. Una gentile señora arriva con un pentolone fumante mentre vengono distribuite dei boccali di metallo smaltati bianchi. Con un mestolo comincia la distribuzione, cerco di farmi capire “poco, poco, grazie” ma la signora è indifferente alle mie preghiere e versa. Si tratta di una crema liquida di un colore che ricorda i pistacchi di Bronte, un verdino chiaro, avvicino il naso ma non si sente per nulla , o almeno poco, il profumo dell’aglio. A questo punto assaggio e, sorpresa, è buona, senza retrogusti, portano fette di pane abbrustolito e qualcuno fa la zuppa. Alla fine i pellegrini tedeschi per ringraziare, cantano le lodi e Don Josè e la señora che ha preparato la sopa ricevono i meritati applausi. L’aglio è un antibiotico naturale, antibatterico, consumato fresco è ricco di vitamina c e b che rafforzano il sistema immunitario, va bene per i diabetici, chi ha problemi di flora intestinale, disinfetta gli intestini, riduce il rischio di sclerosi alle arterie e regolarizza il colesterolo. Ecco perché da sempre coloro che ospitavano i pellegrini offrivano questa zuppa di aglio e sarebbe opportuno consumarne almeno due spicchi freschi al giorno. Ha solo un particolare produce un alito fastidioso ai più, ma i pellegrini che bevevano a fonti non sempre di acqua pura, mangiavano quello che trovavano in natura, con mani sporche e stoviglie mal lavate, consumare aglio serviva proprio per aiutare l’organismo a combattere virus e batteri e contaminazioni varie. Tè cappìi Giuan. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. (*) Don Josè Maria, che è mancato nel 2008 è stato nominato Servo di Dio in attesa (pare dico pare) di beatificazione. Si diceva di Don José María che era "la pietra miliare più umana e completa di tutti coloro che hanno frequentato i Cammini negli ultimi anni ", ma che nessuno lo ha superato in umanità e in un franco benvenuto ai pellegrini, era per tutti il Parroco della sopa de ajo.”
Fancazzista anni 70'
“Faccio cose, vedo gente”.
I FONDI DI CAFFE’: Sono sempre stato in prima linea nel combattere lo spreco alimentare e me ne vanto, forse questo vezzo mi viene dal fatto che ho vissuto la mia infanzia in un periodo immediatamente post bellico dove bisognava fare buon uso del cibo e non sprecare nulla. In famiglia vigeva l’uso del giorno del “kata sù” ovvero quel giorno dove tutti gli avanzi della settimana venivano assemblati in polpettoni o simili manicaretti, polpettine, zucchine ripiene. Oggi, sempre nell’ambito del salvaguardare il cibo e non buttare nulla, voglio affrontare il tema dei fondi di caffè. Che fine fanno i fondi di caffè dopo che la Bialetti ha fatto il suo dovere nel prepararci il caffè mattutino,? (delle macchinette automatiche casalinghe ne parleremo in un prossimo futuro). Viene lavata per benino e riposta nella credenza, una volta, ora nel pensile della cucina, si libera il filtro e si butta ciò che conteneva nel rifiuto organico. Ma sapete in quanti modi questo dischetto nero/marrone può essere riciclato? Circa trenta modi. Ora è inutile che ve li elenchi tutti ma alcuni esempi ve li posso fare, quelli più banali e utili: ad esempio deodorante per il frigo, per allontanare le formiche, cancellare i graffi dai mobili, cancellare i cattivi odori dalle mani, fertilizzante per le piante, detergente abrasivo e altri modi di utilizzo. Una volta cerano personaggi che millantavano di prevedere il futuro leggendo i fondi di caffè lasciati nelle tazzine in cui aveva bevuto l’interessato, ora i filtri, le capsule e le cialde non prevedono più che si formino residui nelle tazzine. Qualcuno ci credeva pure e pagava per sentirsi dire queste scempiaggini: “Vedo e prevedo……….” beato chi prendeva sul serio queste cose. Un episodio della mia fanciullezza mi lega proprio ai fondi di caffè. I miei allora gestivano il Bar Roma di fronte alla stazione di Voghera, vi parlo degli anni 50’, mio nonno Carlo, che aveva conosciuto personalmente Don Orione, aveva preso e imposto l’abitudine di raccogliere il fondo dei caffè che venivano serviti al bar in una di quelle scatole di latta per biscotti (tipo Saiwa) cubi di 30 x 30 x30, e una volta riempita avvisava la Parrocchia di Don Orione in fondo alla Via Emilia e un ragazzotto, che noi chiamavamo “il biondo”, passava a ritirare il risultato della raccolta. Il Biondo, che in realtà si chiamava Luigino, prendeva questi fondi e li portava all’istituto di via Emilia, agli Orionini (Piccola Opera della Divina Provvidenza) dove vivevano bambini e ragazzi orfani o disagiati. Una volta lo seguii per vedere cosa ne facessero. Le suore, che allora prestavano la loro opera presso l’istituto, allargavano questi fondi al sole, a volte erano ancora umidicci, e li facevano asciugare. Una volta asciugati e tornati in polvere, venivano fatti bollire e poi filtrati e aggiunti al latte del mattino per il caffèlatte dei ragazzi ospiti dell’istituto. Malgrado il caffè avesse già dato le proprie caratteristiche organolettiche, strizzato dalla macchina a stantuffo del caffè, quello che ne usciva da questo trattamento era, per quei tempi e per quei ragazzi, ancora gradevole, buono da intingere le fette di pane. Oggi lo chiameremmo caffè americano allora era per loro un ben di Dio. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
Sijmadicandhaapaijee
Sijmadicandhaapaijee
Di primo acchito sembrerebbe una parola brasiliana, ma se la leggete bene, scoprirete che è scritta in idioma astigiano o comunque in argot piemontese/pavese che significa “cane da pagliaio”. Se ne avete voglia andate a leggere l’intervista a Paolo Conte su l’ultimo numero di 7 del Corriere. Ve li ricordate i cani da pagliaio? Solitamente erano dei bastardini o meticci come si dice oggi, il risultato di incroci improbabili che si perdono nella notte dei tempi, il frutto di amorazzi consumati in fretta con la paura di essere bersagliati dai sassi dei monelli. Girovagavano per le corti delle nostre cascine a volte un po’spelacchiati e non certamente profumati, soprattutto nei giorni di pioggia, se li avvicinavi quando erano bagnati emanavano afrori non certamente gradevoli, da qui il detto: odore di cane bagnato. I meno fortunati erano legati alla catena la quale terminava con un anello che era infilato in un filo di ferro che andava da un pilastro all’altro della cascina e questo gli permetteva una certa semi libertà; gli sfortunatissimi venivano rinchiusi in un serraglio dove passavano la loro vita a latrare di giorno e di notte disperatamente. Ma parliamo di quelli fortunati. In inverno vivevano fra la stalla e il portico quello con le balle di paglia, scavandosi un buco fra i trucioli e trascorrendo il tempo in un semiletargo dal quale si svegliavano solo se sentivano dei padellini sbattere. Ma ricordiamo quelli che godevano (e ancora godono) della generosità del loro padrone,quelli che viaggiano sulle mitiche panda bianche, nel retro, fra le carabattole, nei cassoni degli APEPIAGGIO e che si muovono all’unisono con il loro capo branco umano, se apre lo sportello scendono, quando lo riapre salgono con un salto, stanno accovacciati sul cancello della cascina e sanno distinguere lo sconosciuto dall’amico. Ogni tanto si danno sontuose grattate con la zampa posteriore nell’inutile tentativo di liberarsi da fastidiosi clandestini a bordo. Si agitano se vedono un altro cagnolino e si dilettano in annusate varie a posteriori, giusto per scambiarsi cortesie. Forse una volta erano anche cani da caccia, poi hanno appeso il naso al chiodo come il fucile del loro padrone. In fondo assomigliano ai loro padroni, assomigliano anche nel carattere, negli atteggiamenti, se lui parla con qualcuno si siedono a fianco come partecipassero alla coneversazione, hanno assorbito l’atmosfera che li circonda e si muovono proprio come “pesci in barile”. Capiscono quando viene l’ora del pasto, quando l’umano si avvicina alla macchina, basta lo sbattere della portiera che subito sono all’erta. Sono quelli che poi si lasciano morire di inedia quando si accorgono che l’umano “capo branco” non c’è più. Una fedeltà che va oltre la vita, altro che candhaapajieè. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
I PROFUMI DELL’ESTATE: Se vi chiedessero quali sono i profumi dell’estate attuali o dei vostri ricordi, quali scegliereste? Il profumo del grano appena tagliato o dell’erba appena falciata, o della terra voltata dal vomere dell’aratro, ma anche del fritto misto che si diffonde verso mezzogiorno dalle cucine degli alberghi/ristoranti nelle località di mare, oppure quello dei pini su in montagna. L’altro giorno a casa mia si sono fatte le cotolette impanate o come qualcuno dice panate, oppure anche la milanese (quella però in realtà è un’altra cosa un po’ più elaborata), in tutta la cucina si è diffuso appunto questo profumo di fritto, la fettina di carne imbibita con l’uovo, passata nel pangrattato e poi nella padella calda. Ho scoperto che il profumo dell’estate che mi appartiene è proprio quello: le fettine impanate. Ma che significa, direte voi, anche d’inverno si fanno le fettine impanate, certo ma per me quel profumo ricorda l’estate e le vacanze in collina in quel piccolo villaggio tra Retorbido e Chiusani dove passavo buona parte dell’estate. Era abitudine che i miei parenti genovesi venissero a trovarci e passassero qualche giorno in nostra compagnia li in campagna. Mia nonna Rosetta, ipovedente ma abilissima in cucina (come facesse è ancora un mistero per me), preparava una montagna vera e propria di cotolette impanate, a volte si era anche in 10/12, poi una biella di insalata mista dell’orto con pomidori peperoni lattuga ecc. ecc. un paio di bottiglioni di quello buono, quindi l’allegra brigata si sedeva a tavola a fare onore alla cucina della “Lalla Rosetta”. Il pomeriggio poi lo si passava all’ombra di qualche pianta di fico a fare passare l’abbiocco post prandiale. Ecco quei profumi di fritto , di sole, di risate, di corse fra i prati di stoppie e fra i filari delle vigne, sono quelli che mi ricordano l’estate. Almeno per me. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. N.B. Lalla in genovese significa zia!! E Barba lo zio.
Dove eravamo il 2 agosto 1980
Anche in questo caso mi è stato chiesto dove mi trovavo il 2 agosto 1980. Ero a Pian del Poggio dove, gestivo la tavernetta Poggio Club. La sera del 2 agosto avevamo come ospite il cabarettista Giorgio Porcaro allora famoso per essere l’alter ego di Diego Abatantuono. Necessita qui raccontare il pregresso. Io e il mio “socio” di sempre Claudio Migliori eravamo andati a Salice al Club House per contattare Diego Abatantuono ospite della serata (i cabarettisti allora andavano per la maggiore) al quale proponemmo una serata al Poggio. Diego, persona squisita, ci informò che aveva tutte le date agostane complete a prescindere dal cachet, che comunque non era inarrivabile, anzi lasciava spazio per una trattativa, il quale ci indicò un amico pure lui cabarettista che gli faceva il verso (il terrocello metà pugliese e metà milanese) e abbastanza famoso nelle varie trasmissioni televisive di moda in quei tempi. Comunque alla fine contattammo Giorgio Porcaro il quale portò il suo spettacolino al Poggio e devo dire che se la cavò benissimo, pienone e la performance durò tutta la notte anche perché Giorgio non si limitò ai tempi prescritti ma andò avanti ad libitum, anche grazie alla complicità del D.J. che era allora Cesare Canobbio altro caro amico purtroppo già mancato. Devo precisare che allora non c’erano telefonini e la televisione lassù era poco guardata. Ma la mattina successiva cominciammo a prendere coscienza che era capitato qualche cosa di grosso. La mamma di Porcaro era riuscita ad avere il numero di telefono del Ristorante e poco conoscitrice della geografia locale chiedeva a quanti km. distavamo da Bologna. Ci volle del bello e del buono per convincerla che eravamo dall’altra parte del mondo e che non correvamo alcun rischio; sta di fatto che Giorgio Porcaro appena dopo pranzo di domenica 3 agosto dovette partire per tornare a Milano e tranquillizzare l’ansiosa mamma. Ecco dove ero il 2 agosto 1980 e come appresi la terribile notizia della strage di Bologna. Per inciso anche Porcaro è già venuto a mancare, lo vidi un’ultima volta a Casteggio al Ponte Romano dove fece uno dei suoi ultimi spettacoli di cabaret. GIU.BA.
U bulachin du lète. Ero affascinato dalla velocità delle mani della signora dell’alimentari nel chiudere il cartoccio con dentro tre etti di pasta corta. Andavo a casa e con un foglio di carta provavo e riprovavo a fare il cartoccio così come la signora dell’alimentari ma non ci sono mai riuscito. Non c’erano ancora i Supermercati ma i negozi: gli alimentari, le salumerie, il macellaio, il droghiere e il vinaio che di solito affiancava una osteria/trattoria. Si poteva comprare la merce sfusa e ogni merce aveva il colore della carta dedicati. Come non ricordare la carta da zucchero, grigio blu come la divisa dei militari dell’aeronautica, il giallo polenta della carta del macellaio. La pasta veniva avvolta, se così si può dire, in carta color nocciola, tipo l’attuale carta da pacco. E –la pasta - faceva bella mostra di se in una cassettiera con il vetro di fronte per vederne il contenuto. Il fornitore la consegnava in sacchi da 5 kg. In quel periodo in attesa di un posto di lavoro fisso, facevo il rappresentante di alimentari e giravo anche e soprattutto la Lomellina. In estate con l’arrivo della mondine, il lavoro quasi non ci si riusciva astar dietro, ma con l’arrivo del tardo autunno e le nebbie, calava anche in quei posti una sorta di limbo, un mondo sospeso. I negozietti di paese vivevano alla giornata, acquistavano i sacchi da cinque kg. di curve di spaghetti che andavano bene nei minestroni e poco altro. In uno di questi negozietti una sera verso le 5 con una nebbia da tagliare con il coltello e con una lampadina penzolante in centro del soffitto da zero candele, entrò una donnina e chiese alla bottegaia mezz’etto di salame cotto e un altro mezzo etto di curve di spaghetti, poi consegnò alla bottegaia un quadernetto per segnare la spesa. Mi venne il magone a pensare che quella era la cena per due. Dal lattaio ci si andava con il pentolino e lei (di solito era una signora) pescava dal grande bidone con un mestolino graduato – un quarto, un mezzo litro – e su tutto regnava questo profumo di latte fresco. A Sestri Ponente si andava in una baracchetta a metà via, dove una signora con tanto di grembiule bianco e le sopramaniche del medesimo colore, intingeva i mescoli nel bidone e svuotava il latte nel pentolino che sembrava un secchiellino con il coperchio e che a Genova si chiama “bulacchin du lète”. Poi l’era dello sfuso finì e giustamente, tutto confezionato, le cassettiere della pasta si svuotarono, il latte nelle bottiglie da mezzo e un litro, lo zucchero nelle sue confezioni ma cominciò però l’era dei rifiuti solidi urbani e come smaltirli, il resto lo lascio raccontare a voi (vedi “il viaggio del cretino”). Sempre per bontà vostra. GIU.BA. P.S. “u bulacu” in genovese significa secchio
CHIEDETEVI SE SIETE FELICI
Socrate dopo essere uscito da un mercato disse:” Sono felice di avere scoperto quante sono le cose di cui non ho bisogno”. Siamo oramai nella seconda decade di questo nuovo millennio e guardando con estremo interesse tutto ciò che la scienza ed il progresso hanno fatto, nel bene ma anche nel male, viene da chiedersi se tutto ciò è servito o serve per renderci un po’ più felici. La speranza di vita è aumentata tanto per gli uomini come per le donne ; all’inizio del millennio trascorso la speranza di vita di un uomo era di circa 36 anni, ora siamo oltre il doppio, lo dimostrano le età che notiamo negli avvisi funebri, a parte ahi noi qualche caso di estrema gravità. L’esasperante ricerca della felicità va pari passo con la continua ricerca dell’eterna giovinezza. Siamo sempre alla ricerca di quella cosa che ci renda felici: è forse il danaro, l’agiatezza, il benessere oppure la trasgressione? Lo scrittore francese Philippe Delerm che ha scritto tra l’altro un piacevolissimo libretto : “La premiere gorgée de bierre” ovvero la prima sorsata di birra sulla felicità minimalista, fa alcuni esempi: la felicità può essere il piacere della prima sorsata di birra, cercare more nei boschi alla fine dell’estate oppure conversare attorno al tavolo della cucina sgranando piselli o ancora godere del profumo delle mele accatastate in una stanza, apri una porta e questo profumo ti avvolge e ti riempie i polmoni. Ecco potrebbe anche da parte nostra fare un elenco di questi ed altri istanti preziosi, istanti che ci rendono felici anche solo per un attimo, per non parlare dei luoghi dell’anima o dei panorami che si aprono all’improvviso davanti a noi. Forse riusciremmo a trovare, il vero metro, un termine di paragone per scoprire se e dove si trova la felicità, anche se effimera e di breve durata. Quindi vuoi vedere che forse per essere felici bisogna veramente tornare alle cose minime, cogliere quelle piccole occasioni, che so: la vista di una rete metallica in una fredda e cristallina mattina di gennaio carica di brina e di neve, un tramonto rosso fuoco sopra la cima degli alberi proprio di fronte al tuo balcone, il profumo del pane o dei biscotti. Ma anche come diceva Baden Powel (qui mi ripeto) potrebbe essere la gioia di dare agli altri la felicità “La felicità è rendere felici gli altri”. Insomma, se ora ci chiedessimo se siamo felici, cosa potremmo rispondere: si o no? O vogliamo continuare a macerarsi in questa frustrante ricerca nella speranza di trovarla nel denaro o nel potere, come cercano di fare alcuni. San Francesco si chiedeva dove stava la vera felicità, però lui l’aveva trovata : era in Dio. Forse anche per noi uomini e donne del 2000 e passa è questa la soluzione? Vi lascio con questo quesito. Vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
L’UOVO SODO: Sono entrato in un’aula scolastica a 4 anni e ne sono uscito a 18 circa. Ma quello che ricordo con maggior chiarezza è quello della prima volta all’asilo dalle Suore Benedettine o le Maledettine come qualcuno diceva in maniera ironica. Avevo un grembiulino a quadretti azzurro e bianco, un fiocco blu attaccato al colletto e il cestino per il pranzo. Andare dalle suore a quei tempi per me e per la mia famiglia era solo un fatto di comodità e di tradizione. Buona parte dei miei parenti erano andati a scuola li, infatti il portone delle suore era a cinquanta metri dal Caffè Cevenini lo storico locale vogherese che è stato la culla della mia famiglia di origine ligure piemontese e trasferitasi a Voghera all’inizio del ‘900. Per molti anni infatti eravamo identificati come i “Cevenini” che era il cognome della mia bisnonna. Ma veniamo a noi. Come dicevo avevo un cestino di paglia intrecciata e dentro la mia mamma ci metteva tutte le mattine un formaggino MIO e un uovo sodo. Poi c’era una mela e il tovagliolo quello che si legava dietro il collo “al bavareu”.Le suore poi fornivano il primo che era sempre riso e spinaci, una minestra semisolida insipida su cui galleggiavano questi filamenti verdi, “ris e strass” e l‘odore di questo minestrone si diffondeva nell’aria già a metà mattina ma non suscitava languorini, anzi li faceva fuggire e malgrado fosse poca nel piatto, veniva avanzata con grande stridore della suora. Ma per fortuna in fondo al cestino c’era l’uovo sodo e il formaggino e questi due elementi, assieme alla fetta di pane, sempre gentilmente fornita dalle suore, colmava il vuoto dello stomaco. Io però alle 4 del pomeriggio tornavo a casa, anzi al Cevenini, dove soprattutto in inverno, andavo a rifugiarmi nel caldo laboratorio di pasticceria dove il capo pasticcere, il mitico signor Calvi, mi dava qualche pezzo di veneziana uscita male, storta o schiacciata o qualche altra leccornia. Poi, siccome mio nonno e suo fratello erano soci della “NOVI” la famosa ditta dolciaria, avevo la possibilità di fare merenda con la leggendaria Crema alla nocciola Novi. Ma importante nella mia dieta di allora era questo uovo sodo. Ma non farà male un uovo sodo tutti i giorni? Forse si, ma anche no, d’altro canto tutta la mia generazione è cresciuta senza tanti patemi d’animo per la dieta. Da infante mi lasciavano in cortile a razzolare assieme alle galline del pollaio di famiglia e come tutti i bimbi portavo alla bocca tutto ciò che trovavo anche quello che usciva oltre all’uovo. Oggi chiamerebbero l’OMS e non solo il 118 se scoprissero ciò che noi si mangiava in cortile. Detto questo ancora oggi quando mi capita di mangiare un uovo sodo ripenso a tutto quello che suscita in me questo semplice alimento. “ Qual’è il miglior boccone?” chiese un passante a Dante “l’ovo sodo” e un anno dopo il medesimo passante “e con cosa?” e Dante “col sale”. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
PRIGIONIERO DI UN TERMOMETRO
Anni fa mi ruppi un braccio cadendo nella brandina di un cane presso la ditta dove facevo il direttore commerciale. Durante quella esperienza scrissi queste note, spero vi piacciano.
L’infermiera, di bianco vestita, decisamente un po’ in carne, pietoso eufemismo giusto per non ferire la sua suscettibilità, con voce cinguettante mi annuncia il termometro e senza por tempo frammezzo me lo infila sotto l’unica ascella libera, la sinistra. La destra è sepolta, per i prossimi quaranta giorni, sotto una spessa coltre di cotone e di bende. Trascorrono i minuti e nel corridoio del vetusto reparto di ortopedia di Piacenza, suonano a raffica i campanelli. L’infermiera cinguetta “Un attimo, arrivo” e la sento andare di qua e di la con la sollecitudine che la sua florida carnalità le consente. Io però resto, nel frattempo, immobile, coricato nel letto, con il termometro sotto l’ascella e nella impossibilità di toglierlo, di alzarmi dal letto, dovrei aiutarmi con l’unico braccio libero, ma sono prigioniero del termometro. Solo a quel punto ho realizzato che per i prossimi quaranta giorni dovrò confrontarmi con questa limitazione di movimento, partendo dalle più elementari funzioni primarie fino a quelle più elaborate. Sono un destrorso puro, nel senso dell’uso della mano destra, sono della generazione della “mano bella” quando i bambini mancini venivano trattati come dei diversi e presi a sberle dalle solerti maestre affinché cambiassero mano, cosi come alcune liceali scoprendo che il compagno di banco è gay pensano utopisticamente: ”Ora gli faccio cambiare idea”; ma ognuno nella sua diversità resta com’è. Sta di fatto che ho dovuto, obtorto collo, fare di necessità virtù, imparare a farmi la barba, provvedere alle abluzioni mattutine, scrivere, anche queste mie note, con la mano sinistra e preferisco tacervi, per ovvia eleganza, tutto il resto che riguarda la sfera intima e personale. Per impegni professionali assunti, ho dovuto riprendere il treno e almeno da questo lato ho fatto scoperte interessanti. Al mattino soprattutto, nei campi che sfilano a fianco del treno, ho visto e rivisto simpatici amici che corrono: lepri; o che decollano: bianchi trampolieri dal battito d’ali ampio e solenne; freddoloso airone cinerino che nasconde il collo nella sciarpa di piume che assieme a qualche variopinto maschio di fagiano assistono al passaggio del treno come se fossero al Giro d’Italia; remiganti anitre selvatiche dalla testa verde e nera cangiante che se ne vanno a zonzo nelle gelide acque dei fossi. Ho riscoperto il piacere della tregua, ho avuto più tempo per guardare, per pensare, per leggere, solo lo scrivere mi è interdetto, riesco a scrivere solo con il computer e allora devo dire che malgrado tutto è la tecnologia che mi ha aiutato almeno a continuare a fare ancora quello che per ora mi piace ancora e che mi diverte: scrivere.
Vi saluto sinistrosamente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
Una cosina pulita: In questi momenti di fine (speriamo) pandemia è naturale che l’animo sia più propenso alla ricerca di cose che ci facciano sorridere, ad argomenti leggeri, al cazzeggio fra amici, lasciando per un attimo almeno tutte quelle notizie che ci esplodono nell’animo portandoci a cupe considerazioni. Lasciamo quindi tutto da parte per un paio di minuti per delle considerazioni leggere. Mi è capitato fra le mani, in una delle mie peregrinazioni fra i banchi di una mostra del libro, un simpatico libello sulla storia di una delle fondamentali ed indispensabili componenti dell’arredo del bagno: il bidet. Narra una leggenda metropolitana che un inglese entrando nel bagno della sua camera d’albergo in Italia abbia esclamato: “Caspita un lavandino per i violini !!” e forse voleva riferirsi all’iconografia del film “il merlo maschio” dove la protagonista, nella locandina, era immaginata come un violoncello. Lo stupore dell’ospite inglese è dovuto al fatto che gli inglesi ma anche i francesi e non solo loro, non usano avere fra le maioliche del bagno il bidet, anzi lo considerano volgare oggetto da postribolo. Un amico stava per rinunciare al Cammino di Santiago perché negli ostelli non sempre ,o quasi mai, è garantita la presenza dell’arredo in oggetto. Ma veniamo invece alla vera storia di questo accessorio. Pare che le prime testimonianze dell’esistenza di questo fondamentale oggetto per la pulizia personale, risalgano al 1700, si racconta che nel 1726 l'episodio nel quale si racconta di quando il marchese D’Argenson andando a far visita a Madame de Prie nella sua casa di Parigi, la trovò seduta su di una bacinella con gambe nella sua stanza da toilette intenta alle abluzioni mattutine. Già il fatto che un gentiluomo entri nella toilette di una signora lascia pensare che i due dovevano essere particolarmente intimi, o che la signora avesse l’abitudine di farsi trovare in “siffatta guisa” dai suoi ospiti, ma andiamo avanti. Pare perciò che le origini siano francesi, anzi si narra che Madame di Pompadour ne possedesse addirittura due di queste bacinelle con le gambe, una di stagno con schienale in legno di rosa e piedi in bronzo dorato, e l’altro in porcellana con schienale e coperchio in marocchino rosso. Allora veniva chiamato il cavallino poiché la posizione d’uso è proprio quella e il nome, anche se francese, deriva dall’espressione italiana di bidetto ovvero piccolo cavallo da sella normanno. Strano che l’uso di questo sanitario venga proprio dai francesi e nel 1700 poiché, proprio in quegli anni, i nobili francesi erano considerati i più sporchi d’Europa e si diceva infatti che nascondessero il proprio odore sotto una valanga di profumi e talchi, infatti qualcuno una volta disse che più che entrare il Re di Francia e la sua Corte lo si sentiva arrivare, nella sala del trono, proprio riferendosi agli effluvi che questi nobili emanavano. Poca pulizia personale insomma, a parte l’uso di questo oggetto che però era prerogativa di poche e nobili frequentatrici di corte, appunto le cortigiane, signore e signorine "di piccole virtù" (cit. Enzo Biagi) che invece ne facevano largo uso. E vi lascio qui. Non penso ci sarà una prossima puntata, ma almeno per questa spero di avervi fatto sorridere. Vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
Tra le pieghe della rete.....IL GREMBIULE DELLA NONNA l primo scopo del grembiule della nonna era quello di proteggere i vestiti sotto, ma in più... è servito come un guantone per rimuovere la padella dal forno. È stato meraviglioso nell’asciugare le lacrime dei bambini e a volte pulire le facce sporche. Dal pollaio, il grembiule è stato usato per trasportare le uova e a volte i pulcini. Quando arrivarono i visitatori, il grembiule serviva a proteggere i bambini timidi. Quando faceva freddo la nonna se lo avvoltolava addosso come un mantello. Quel vecchio grembiule era un soffietto, agitato su un fuoco a legna. È stato lui a portare patate e la legna secco in cucina. In giardino è servito come un cestino per molte verdure, dopo che i piselli sono stati raccolti, è stato il turno dei pomodori e delle zucchine. E alla fine della stagione, si usava per raccogliere le mele cadute. Quando i visitatori arrivarono inaspettatamente, è stato sorprendente vedere quanto velocemente questo vecchio grembiule potesse far sparire la polvere. Quando arrivava il momento di servire i pasti, la nonna andava sulla porta a sventolare il grembiule e gli uomini in campo capivano che dovevano andare a tavola. La nonna lo ha usato anche per mettere la torta di mele fuori dal forno sul davanzale della finestra per farla raffreddare. Ci vorranno molti anni prima che qualche invenzione o oggetto possa sostituire quel vecchio grembiule... In memoria delle nostre nonne. Sempre per bontà vostra.!!
Archeologia alimentare: “Ferro-china Bisleri” Tutto è cominciato da una notizia della scorsa settimana nella quale si comunicava che il marchio “FERRO CHINA BISLERI” era stato comprato da una famosa ditta italiana di superalcolici, tornando, se così si può dire, in Italia(*). Ferro China Bisleri, dal nome del suo inventore(1881), era considerato tonico corroborante con proprietà digestive e ottimo integratore per il sangue. Veniva consumato come liquore oppure come aperitivo. Le madri dell'epoca, inoltre, sbattevano l'uovo e lo mischiavano con la Ferro-china perché aiutasse i loro figli nella crescita. Per cui tutte le mattine arrivavamo a scuola “etilicamente già avanti coi lavori” anche perché mia nonna, che doveva somministrare questo beverone, a volte si dimenticava se lo aveva già messo o meno e nel dubbio lo metteva un’altra volta. La raccomandazione era un cucchiaino al dì, come si usava fare per un tonico, da somministrare anche ai bambini. Si credeva infatti, ma è pur vero, che il ferro diluito in alcool fosse facilmente metabolizzato dall'organismo. In questo periodo l’archeologia alimentare sta tornando di moda. E’ più facile dire “ti ricordi i fruttini Zuegg”, questa voglia di vintage non ha solo come obbiettivo la moda o l’arredamento, ora sta tornando la voglia di cose che hanno segnato la nostra infanzia soprattutto quelle alimentari; dicevo prima i fruttini Zuegg ma anche la Idrolitina, la Cedrata Tassoni , il Mottarello e la Coppa del Nonno, se facevi centro alle giostre, quello del tiro a segno, ti davano un allucinate blocchetto di vafer che noi chiamavamo Mignin ed erano talmente stantii che se li vedeva l’Intendenza alle Belle Arti ti arrestava perché ti stavi mangiando un pezzo di storia antica, la scadenza non esisteva, scadevano al momento in cui te li mangiavi. C’era il Cherry Stock che si poteva trovare solo nelle confezioni natalizie, veniva depositato nella specchiera del soggiorno e, miracolo dei miracoli, evaporava, infatti ogni tanto la mamma spolverando la bottiglia notava che il livello mano a mano scendeva, in verità veniva bevuto furtivamente a canna quando si restava in casa da soli o con gli amici di merenda, bastava bagnarsi le labbra, il fascino del proibito, i più spudorati aggiungevano acqua in maniera che il livello restasse sempre pari. C’erano poi l’Ovomaltina, il Proton e l’olio di fegato di merluzzo, chi non ha mai assaggiato il famigerato olio alzi la mano……., nessuno, quelli della mia età lo abbiamo proprio assaggiato tutti. Ecco questo forse è il ricordo più ributtante. Ma io mi chiedo: ma l’olio di fegato di merluzzo è mai esistito veramente, io non ho mai visto cavare il fegato ai merluzzi e poi spremerlo. Secondo il mio modesto parere quello era il risultato di un sabba di streghe, il fondo di una “caldera” dove avevano bollito topi e serpenti, aveva il gusto più innominabile di questa terra, ed infatti il rito della presa della pozione putrida era accompagnato e seguito da un bailamme di rincorse scappellotti, urla e strepiti, tentativi di divincolarsi, nasi turati e più di un famigliare coinvolto: uno lo tiene, l’altro gli tura il naso e il terzo versa nella bocca l’intruglio. Ma torniamo a ricordi più dolci, il Tamarindo Carlo Erba, ora mi pare venduto solo in piccole bottigliette tipo sciroppo per la tosse, l’orzata ed il latte di cocco. La nostalgia dei sapori e dei profumi del passato ci accompagnano durante tutta la vita, come il profumo del pane che usciva dal forno di quella casa di campagna, in quella valle ora quasi dimenticata, dove al tramonto ci si sedeva sotto un pero e si guardava la pianura lontano fumigante di afa e di zanzare e come soft drink c’era solo l’idrolitina fatta con l’acqua del pozzo e come era buona. Ciao, vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. (*) il marchio era di proprietà di una multinazionale belga
IL CONSIGLIO: Trovato tra le pieghe della memoria mia e del mio computer.
IL CONSIGLIO: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi tra vent’anni guarderai quelle tue vecchie foto. E in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi! Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing-gum per risolvere un’equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non t’erano mai passate per la mente. Di quelle che ti pigliano di sorpresa alle quattro di un pigro martedì pomeriggio. Fa’ una cosa, ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non esser crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perder tempo con l’invidia. A volte sei in testa. A volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d’amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco, a ventidue anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia, quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a quarant’anni. Forse ballerai con lei al settantacinquesimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse. Come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi. Senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza. Ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il migliore legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono. Ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perchè più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Non fare pasticci coi capelli, se no quando avrai quarant’anni sembreranno di un ottantacinquenne. Sii cauto nell’accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga.
Ma accetta il consiglio… per questa volta.
Sempre per bontà vostra.
GIU.BA.
LE OSTERIE DI UNA VOLTA: Le osterie di una volta avevano sempre davanti una pergola di uva americana. Le osterie di una volta erano subito dopo la curva. Le osterie di una volta avevano sempre il cesso in fondo al cortile a sinistra, la turca e i fogli di giornale inchiodati al muro. Le osterie di una volta avevano un bancone di legno scuro e un piatto di uova sode sopra. Le osterie di una volta profumavano di odori ancestrali, di legno di vino e di tabacco. Le osterie di una volta al giovedì trippa. Si entrava in una stanza direttamente dalla strada o dalla piazza con pavimento di legno ed un bancone molto spartano, scuro su cui troneggiava un piatto di uova sode ed un solitario vaso di attempate caramelle. Non c’era macchina del caffè, ma solo un ristagnate ed ancestrale odore di vino e di tabacco. Una stufa a due bocche di quelle basse oppure un “barilotto” quelle stufine cilindriche con una sola serie di cerchi, aveva l’impossibile compito di riscaldare l’aria, ma in pieno inverno gli avventori difficilmente si separavano dal loro mantello o dal pastrano, per due buoni motivi, primo perché faceva comunque freddo e secondo la paura di non ritrovarlo più. Sui cerchi delle stufe bruciavano eternamente pelli di arancia oramai rinsecchite ed abbrustolite che in teoria servivano a profumare l’aria. I tavoli, quadrati, erano circondati da sedie impagliate e su queste, soprattutto alla sera dei dì di festa, sedeva l’esercito “di dudes cadregh”, ovvero veniva affrontato tutto lo scibile umano recuperabile da quelle parti e più il livello etilico aumentava e più le discussioni si facevano impegnate, filosofiche, sociali, politiche, sui massimi sistemi. La cucina, solitamente era gestita da un simpatico donnone, sfornava il meglio della cucina povera di quei tempi e di quei posti. Il vino non era buono ma era genuino e tornando a casa nella fredda sera, bastava una sosta idrica per rilasciare l’eccesso del bevuto. Il giovedì trippa ma al sabato sera agnolotti di stufato e ci voleva generosa bonarda per mandare giù quei sughi corposi, profumati di chiodi di garofano e alloro. A Milano le osterie di una volta si chiamavano “trani” proprio perché il vino veniva da laggiù, era nero denso e duro così come era la vita di allora. Le osterie di una volta oggi di chiamano wine bar, enoteche o agriturismi e la gente che li frequenta a volte ha atteggiamenti saccenti . Ma davanti ad un buon bicchiere di vino oggi come allora lo spirito (non nel senso di alcol) si eleva, si esalta e così come allora davanti ad un calice ci si ritrova tutti amici. Io ci arrivavo in motorino e ordinavo pane e salame. Il pane erano due fettone di micca e il salame era di quello là, quello che si tagliava a mano e di sbieco. Prosit. Vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
818, OVVERO LA GARA DI MOUNTAIN BYKE.
818, al numero corrisponde il mio nome, vi avvicino al tavolo dell’organizzazione e all’addetto ripeto il mio numero: “sono l’ 818”. Mi danno un busta con dentro un bracciale elettronico da allacciare alla caviglia. In una borsa di plastica tipo supermercato trovo generi alimentari e di conforto, snack, barrette energetiche, cioccolato e poi pasta formaggio biscotti. Piove a dirotto fuori del palazzetto dello sport di questo paese sulle rive del Po. Con la scusa dell’accredito del giornale mi trattengo ancora un poco all’interno. Ma poi bisogna decidersi e tornare in macchina. Radio accesa, vetri appannati e fuori diluvio. “Fenomeni in attenuazione a partire dal nord ovest, ampie schiarite sulla pianura padana” sembra che il temporale ascolti la radio ed infatti appena dopo tutto cessa ed un timido sole fa occhiolino fra le nubi. Il prato parcheggio si anima immediatamente e dalle automobili spuntano bici, ruote sacche pompe e tutto ciò che serve. Si applicano i numeri sul manubrio e già qualcuno prova con una sgambatina attorno alle villette di fronte. Tiro fuori la mia bici che a confronto delle altre sembra un vecchio carrettone. C’è un freno rotto, ma per fortuna c’è il camion della Shimano. I due tecnici, brianzoli, guardano con sospetto il mio mezzo e uno mi dice: ”Scusi ma lei intende correre con questa?” “certo, perché” e mi fa capire che è come andare la rally di Sanremo con una Panda mentre tutt’attorno ci sono le Subaru e le Toyota ruggenti. Ed infatti tutt’attorno ci sono bici tecnicamente avanzate, forcelle con ammortizzatori a gas, sellini antiprostata, telai in fibra di carbonio, tute di seta per tagliare il vento. Comunque mi mettono a posto la bici e mi danno anche una regolata alle ruote, tutto gratis. Viva la Shimano. Nel pacco-dono c’è anche una mantellina anti acqua flourescente e il 90% dei partecipanti alla gara la indossa, io non mi fido e metto il mio KWAY blu. Una folla immensa di bici, più di 800, quasi 900,direbbe Troisi in “Non ci resta che piangere”, la folla di corridori è dispiegata lungo una strada dove verrà data la partenza, mi metto per ultimo, c’è troppa ressa e temo in un avvio catastrofico, uno speaker simpatico e rutilante fa le ultime raccomandazioni e poi danno il via, Sto partecipando, prima volta in assoluto (ma anche l’unica) in vita mia, ad una gara di gran fondo in mountain bike il “Rally del Po” per ciò che mi riguarda 35 km. e rotti. Si parte ed io mi tengo alla larga dal gruppo ma soprattutto dei “convinti” che sfrecciano immediatamente ed infatti la partenza è sul filo dei 27 all’ora. Schizzi di malta fino al cielo, la borraccia dell’acqua diventa subito un blocco di fango. Il percorso si snoda nelle golene del Po, su e giù per gli argini e in mezzo ai boschetti in riva al grande fiume, un fagiano mi guarda allibito con i suoi occhiali rossi I primi kilometri ho il fiato grosso ma poi mano a mano che il ritmo cardiaco diviene regolare anche lo sforzo è sotto controllo; ci sono passaggi quasi fiabeschi altri inquietanti, come fra i pioppeti squassati dal vento con le cime degli alberi che rovinano con sinistri scricchiolii sul percorso. Dopo il 30° kilometro le gambe però cominciano ad essere legnose ed il vento che soffia con forza è sempre contro. “Pipì stop” e bevuta al posto di ristoro e si prosegue, La sella mi abbandona mettendo in serio pericolo le mie gonadi, e la zona perianale, (vedi Fantozzi alla famosa gara ciclistica) ma un giovanotto della Protezione Civile con una chiave inglese mi rimette in sella di stato e di fatto. Il traguardo è vicino e comincio a godermi la mia personale vittoria, ci sono anche i fotoreporter a immortalare la mia maschera di fango ma sono arrivato, ho anche alcuni personali fans: l’amico Sandro e i due della Shimano che gridano “W la stampa”. Due ore 48 minuti e 12 secondi, per 35 Kilometri di soddisfazione. Ultimo ma non l’ultimo, strada facendo ho lasciato indietro alcune decine di altri cicloturisti con le loro cyber bici, ho visto uno di questi superconvinti crollato sull’argine mentre le confezioni degli gli integratori i cui involucri vuoti segnavano, haimè, il sentiero come Pollicino. Nel frattempo vengo a sapere che i marziani dell’agonistica hanno fatto i 52 kilometri del loro percorso in un’ora e 54 minuti, quando sono arrivato io avevano già finito di fare la doccia. Ora guardo la mia bici sporca di fango e quasi mi dispiace pulirla, un po’ come quel veterano che dopo aver toccato la mano a Re Umberto non se lavò più. Vi saluto brava gente, ad majora. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
PASADENA. La prima avvisaglia che stava per succedere qualche cosa, è stato un tramestio proveniente dal vicino della palazzina accanto. Poi la certezza che qualche cosa stava capitando in quei primi caldi pomeriggi primaverili. Il mio vicino ed amico stava iniziando a dar la vernice alle persiane. Le donne di casa si affacciano e vedono quello che sta accadendo dal vicino ed è stata una reazione a catena. “Sono due anni oramai che hai dato l’impregnate alle persiane, sarebbe ora da “dag una pasadena” E a questo punto la situazione precipita. Innanzi tutto la parola “pasadena” che nulla ha a che vedere con la nota città californiana, è una parola trabocchetto. Cosa significa una pasadena? O dai una bella verniciata alle strabenedette persiane o non la dai, la ripassatina – è questo il vero significato della parola – non risolve nulla. E allora mio malgrado, abbandonati i molli ozi della obbligata restrizione casalinga, ho dovuto impegnarmi anima e corpo, (a dir la verità è quello che ha sofferto maggiormente) alla riverniciatura delle persiane di casa. Innanzi tutto la materia prima: la vernice. In un vicino noto centro di bricolage, pur con tutte le restrizioni da Covit 19, c’era una offerta, gli sciagurati già prevedendo che in altre migliaia di ometti di casa costretti, obtorto collo, agli arresti domiciliari, viene richiesta la mitica pasadena, hanno perciò messo in vendita a prezzi da vero affare un nuovo prodotto per persiane, in gel, che non gocciola, ma il vero affare consisteva solo se ne compravi una latta da 2 kili e mezzo. Per esperienza so che ne basta una latta da 1 kilo ed infatti tanta ne ho comprata e tanta poi mi è bastata, ma con mia sorpresa ho visto parecchie persone che se ne andavano con questo lattoni di vernice come se dovessero riverniciare le persiane di tutto il condominio. E così, in braghe corte, con guanti, pennello e cappello, mi sono messo di buzzo buono e nel volgere di alcuni pomeriggi, ho portato a termine il lavoro. Ora le persiane sono tornate al loro posto e fanno bella mostra di sé, carteggiate, verniciate, lucidate tanto le mie come quelle del vicino. Per un altro condòmino la reazione a catena delle mogli si è interrotta, o lui furbescamente ha fatto finta di niente. Pertanto se tornando a casa alla sera la vostra gentile consorte e/o compagna ecc. ecc. vi dice che è ora di dargli una “pasadena” non illudetevi, non lasciatevi ingannare poiché non si tratta di una proposta indecente e non si tratta nemmeno della nota località degli Stati Uniti zona Los Angeles, ma piuttosto che questa volta tocca a voi, vi auguro almeno periodo meno critico e più adatto e poi vai di pennello. Vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
QUELLI CHE........!!!
Stai sereno "Giuseppi" ma non lasciare cadere la saponetta quando fai la doccia
"mi hanno regalato un perizoma dicendomi che era una mascherina, me ne sono accorto per via dell'elastico che mi attraversava la fronte"
Malamovida, assistenti civici, distanza sociale ecc. ecc., oggi è San Filippo Neri, quello che diceva ai giovani: "Fate i bravi se potete".
GLI OCCHI: "Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un’anima.(José Saramago)" Il paese è piccolo e la gente…….la si conosce tutta o quasi. Avete notato come ci si riconosce anche dietro la mascherina solamente guardandosi negli occhi. Ci sono quelli che siamo abituati a vedere sempre e in questo caso non facciamo fatica a riconoscerli, ma ci sono anche quelli che vediamo occasionalmente, eppure anche così li riconosciamo egualmente. Questa situazione pandemica ha avuto delle conseguenze gravissime ma in un altro caso ha permesso che ci guardassimo negli occhi. Non basta la mascherina a limitare la nostra memoria visiva, ma cerchiamo anche nei gesti di riconoscere le persone, da come cammina, come si comporta, qualche signora/signorina la riconosco anche a posteriori, volevo dire derrière, scusate il francesismo. Tutto questo ha stimolato i nostri sensi, siamo incentivati a riconoscere le persone, riusciamo oramai a percepire se, quando le saluti, con gli occhi ti sorridono, gli occhi che sorridono si stringono, appaiono le cosi dette rughe di espressione, ma ti fanno capire che hanno apprezzato il tuo saluto, oppure se ti guardano con stupore, come a chiedere “ Ma kel ki lù”."Due persone che si guardano negli occhi non vedono i loro occhi, ma i loro sguardi.(Robert Bresson)". In questa benedetta fase 2 siamo tornati per strada, pur mantenendo le distanze, e abbiamo ricominciato una parvenza di vita sociale, ho anche scoperto che, sempre guardando negli occhi chi ci incrocia, stiamo salutando, anche solo con un cenno, persone che prima ci lasciavano indifferenti, ora più siamo lontani dal nostro cortile, dal nostro condominio e incontriamo appunto lontane conoscenze, quasi siamo felici di salutarle, di vederli e apprezziamo il fatto che stiano bene. “Ci sono due modi per guardare il volto di una persona. Uno, è guardare gli occhi come parte del volto, l’altro, è guardare gli occhi e basta… come se fossero il volto.(Alessandro D’Avenia)” A me gli occhi please, e statemi bene. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
Ci vorrebbe un amico: Mi è piaciuta una vignetta che ho visto su Facebook, c’è un nonno che mostra un libro al nipote e gli dice: “Vedi con questo non bisogna essere connessi perché lui è sempre connesso, si possono girare le pagine semplicemente con un dito, non bisogna ricaricarlo è sempre carico e lo puoi portare con te ovunque tu vada, si chiama libro ed esiste fin dal tempo degli egizi”. E’ inutile negarlo ho sempre avuto passione per i libri, mi piace leggere, tenerli e conservarli, impilarli su tutti i ripiani disponibili di casa e ogni tanto spolverarli. Durante una cena parlai di libri con un amico, la mia quasi mania. Alcuni giorni dopo un comune amico mi incontrò e mi disse:” Questa chiavetta te la manda Axxx, non so cosa contenga ma mi ha detto che sono libri”. Infatti corsi a casa, infilai la chiavetta nel PC e scoprii che si trattava di una intera biblioteca, quasi 6.000 libri (5.993) in una chiavetta. Annunciai il regalo a mia moglie la quale quasi spaventata mi disse “E ora dove li mettiamo”. L’unico difetto, se voglio leggerli è che devo stamparli o leggerli sul computer A volte mi piace paragonare il libro con una bottiglia di vino, sono entrambi il prodotto di un amore, la fatica la capacità e la professionalità di colui che lo ha confezionato, poi ciò che c’è dentro può piacerti o meno ma colui che lo ha prodotto ha fatto del suo meglio per cogliere il tuo gradimento sia esso un racconto, un romanzo o un vino. Qualche tempo fa ho telefonato a mia nipote Camilla, la più grande, dicendogli:” Poiché hai ottenuto degli ottimi risultati a scuola ho deciso di venirti a prendere e portarti a scegliere un regalo”. E così è stato, sono andato a prenderla e lei mi aspettava sul cancello di casa con la sua borsetta argentata a tracolla. Salita in macchina gli ho subito detto le mie intenzioni “Andiamo che voglio regalarti un bel libro, preferisci andare al Centro Commerciale oppure in una grande libreria” enfatizzando il “GRANDE” di libreria. Meglio la grande libreria, ha risposto. Ma come è fatta una grande libreria, ha aggiunto, come una grande biblioteca? Ecco una grande libreria di fatto è una grande biblioteca con la differenza che in biblioteca i libri li prendi, li leggi e poi li devi rendere, mentre in libreria i libri li acquisti e ti restano per sempre. Siamo così arrivati in città e ci siamo recati in una grande libreria. Era quasi intimidita dalla quantità di libri, come dalla folla che si aggirava tra gli scaffali. Una gentile signora ci ha indicato gli scaffali dei libri per ragazzi e poi ci ha lasciati soli scegliere, anzi sola a scegliere perché io mi sono allontanato per sfogliare alcune novità librarie pur osservandola con la coda dell’occhio. Ed infatti dopo alcuni minuti mi ha fatto segno che era arrivata ad una conclusione, due libri, uno dei due, “Anche tutti e due”… questo!! C’è anche Il piccolo Principe, dissi, e lei: quello è a “cartoni animati” io ho l’altro tutto scritto. Non sono cartoni animati sono fumetti, ma va bene così. Alla fine uscimmo con tre libri, uno per me e due per lei e sua sorella. Attraversammo Via Emilia con lei che teneva orgogliosamente in mostra la sua bella borsa di carta con il logo della libreria e dentro i suoi libri. C’è un amico che non vi tradirà mai, sarà con voi anche nei momenti solitari come questi che stiamo passando, presente se pur silenzioso, ma stracolmo di emozioni: un libro. Ora vi saluto brava gente, sempre per bontà vostra. GIU.BA.
LA CIVILTA’ DEL PANE “Cumpagnelu ben cuu pan” si raccomandava mia zia a Genova, quando attaccavamo la pietanza. Non è che mancasse il companatico, ma per riempire gli stomaci di adolescenti era utile utilizzare anche un buon pezzo di pane. Mia suocera, che è di estrazione contadina, accompagna ancora oggi tutto con il pane, persino la mela a fine pasto, ma per lei questa abitudine antica era per motivi di sopravvivenza. Il companatico era poco e il pane serviva per colmare la scarsità di cibo. Oggi il medico le raccomanda di mangiarne poco anche se è difficile farla smettere di accompagnare tutto con il pane, è un gesto ancestrale; ora non più ma non è molto che ha smesso, il cucchiaio della minestra in una mano e un pezzo di pane nell’altra che si portava alla bocca strappandolo con i denti. Anni fa mi chiesero di partecipare ad una serata enogastronomica in un paese della bassa Lodigiana, ora diventato famoso in senso negativo a causa del contagio Covit19, eravamo in due, un amico enologo e giornalista ed io che però non sapevo di cosa avrei dovuto parlare. Il Presidente della Pro Loco ci accolse con grande entusiasmo e ci dettò gli argomenti, ma mentre per l’amico era facile parlare di vino, io stavo aspettando che mi assegnassero il tema. “Lei potrebbe parlarci della civiltà del pane”, io e l’amico ci guardammo tra il sorpreso e il preoccupato, più io, se lo avessi saputo mi sarei preparato, ma tu parla del cibo più antico del mondo, dell’uomo, la sua valenza anche religiosa, politica, Manzoni, Bava Berraris. Pur essendo un buon affabulatore ero, non preoccupato, di più,tremante. Il salone era pieno, tutte le sedie occupate, in fondo alla sala alcuni addetti si davano da fare attorno a dei pentoloni che fumavano. Io fui letteralmente lanciato sul palco, mentre ancora cercavo di buttare giù qualche appunto. Non ho mai avuto paura del pubblico, ma quella volta ero terrorizzato. “ Dunque il pane……un cibo antico, fatto con il grano…..usato anche nella religione, Cristo spezzò il pane e disse: mangiatene tutti…….citazione religiosa ( mi ricordai di essere stato anche chierichetto)…”. Ma in quel momento un grido, per me salvifico, attraversò tutto il salone:” Il riso è pronto!!!!!!” Tutta la platea balzò in piedi e il pubblico si precipitò verso il fondo della sala brandendo piatti di plastica e forchettine in una confusione ululante. Io rimasi allibito, solo sul palco, con davanti il microfono, la platea vuota e l’amico che dalle quinte mi guardava stupefatto. “Sa, si scusò il Presidente, abbiamo preparato il famoso risotto nella formaggia, un nostro piatto tipico” Infatti il risotto pronto veniva versato in un mezza forma di grana padano a cui era stato scavato l’interno e distribuito al pubblico presente. Non sapevo che fare, quando davanti a me, nella prima fila, si presentò un signore, affetto da nanismo, un nano insomma, il quale prese una seconda sedia se la tirò davanti a mo’ di tavolino, appoggiò un piattone di risotto, un bicchiere di vino rosso e guardandomi mi disse:” Prego prosegua pure”….. “ Ma andè a ciapà di rat” e me ne tornai tra le quinte. Come si dice, presi due piccioni con una fava: non avrei saputo che dire e avrei fatto una brutta figura e in seconda battuta mi mostrai seccato con il Presidente della Pro Loco il quale si scusò pure “ La gente a queste serate viene per mangiare e bere” e io aggiunsi e se ne frega della civiltà del pane. Il mio amico invece scese in platea brandendo una bottiglia di vino e urlando riuscì ad attirare l’attenzione, almeno quella poca che gli concedettero, e parlò del vino. Tornammo a casa in una nebbiosa notte padana, fummo pagati con prodotti locali, almeno quella fu l’unica soddisfazione. Bella esperienza. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
NOSTALGIA: Fino alla fine del mondo. Mutatis mutandis, ovvero cambia tutto ciò che deve cambiare. In piazza Maria Pita a A Coruña nella banda musicale che accompagna una processione, una delle suonatrici di gaita, la cornamusa galega cara a Hevia*, è una ragazza di colore. Mi rivolgo a Serafin, l’amico che mi ospita e gli dico: “Il mondo cambia, inesorabilmente cambia”. Quando me ne vado sui sentieri del Cammino di Santiago, ogni tanto mi piace voltarmi indietro, soprattutto se sono su di un colle dominante, per guardare la strada che ho fatto e mi compiaccio per quella percorsa e guardo con occhi se non fiduciosi, ottimisti, il sentiero che continua a salire. Finirà questa salita, prima o poi finirà o intende arrivare in cielo? Quanta strada ho fatto, nella vita, nel Cammino, in fondo anche questo sentiero è la sintesi della vita, si sale e si fatica ma poi si scende e ci si riposa un poco. Trovi gente, strana meno strana, mangi, dormi ti riposi, apprezzi le piccole cose: il letto d’angolo in basso, nessuno sopra di te, il primo a fare la doccia o meglio ancora il solo nella grande camerata del rifugio. L’ospitalera che ti chiede se hai roba da lavare che già che sta lavando la sua ripulisce dalla polvere e dal sudore anche la tua. Te la metterà sulla branda, pulita, asciutta e profumata di bucato, di fresco. Un tinto de verano muy generoso, la prima sorsata di birra dopo 10 kilometri senza aver incontrato anima viva, una vasca di acqua fredda da immergerci i piedi. Attraversare Plaza de l’Obradorio di fronte alla Cattedrale di Santiago alle 5 del mattino davanti ad una cattedrale silente, senza gente sdraiata sugli zaini, senza urla ne canti, non ha prezzo. La piazza è lucida di acqua, i lampioni riflettono sulle lastre di sasso, c’è solo la sentinella davanti alla sede del Governo della Galizia che ti guarda e forse già pregusta il cambio della guardia, gli dici “hola” e lui risponde allo stesso modo, ti giri una ultima volta verso la silouette della cattedrale che si staglia nel blu dell’alba, della madrugada e poi riparti per la tua strada. E poi quella curva, quella curva emozionante, alzi la testa alla fine di una salita e ti accorgi che dopo quella curva ti appare il mare oceano, laggiù, blu, con la schiuma bianca che incornicia gli scogli, ancora lontano, ma così vicino. Qui finiscono tutti i cammini, al Faro di Fisterra, il pilastrino indica il Km.0,00, anche se non è vero nemmeno questo, la strada continua sino a Muxia dove finalmente davanti al Santuario de Nostra Señora de la barca finisce la terra e resta solo il mare. Ora si che è finita per davvero. ** * Hevia è un famoso suonatore di gaita, la cornamusa galega, conosciuto in tutto il mondo anche se lui è asturiano. **Cabo Touriñàn: i romani credevano che Cabo Fisterre fosse il punto più a ovest del continente, la fine del mondo, in realtà il punto più a ovest dell’Europa è Cabo Touriñàn che si trova a metà strada tra Fisterre e Muxia . Sempre per bontà vostra GIU.BA.
FACCIO UNA DOCCIA E ARRIVO Quante volte andando a prendere un amico ci siamo sentiti dire al telefono: “OK, faccio una doccia e arrivo!” Come, faccio una doccia, vi sarete chiesti, è martedì, sono le cinque del pomeriggio e l’ultima volta che ci siamo sentiti era impiegato in banca, che faccia lo scavatorista e non me lo ha mai voluto confessare? Siamo diventati un popolo eccessivamente pulito a prescindere e poi sarà vero? Mi ricordo che in metrò, a volte anche di prima mattina, c’era da mettere la mascherina (oggi la portiamo tutti) tale era il tanfo. Ma allora non è poi così vero che tutti fanno una doccia e arrivano. Da bambino a casa mia non c’era il bagno, c’era solo il “cesso” sul balcone di ringhiera e la mia mamma mi lavava nel “sebero”, nel mastello, mi lavava una volta alla settimana, solitamente il sabato pomeriggio, mi cambiava maglia e mutante dopo avermi spolverato di borotalco. Avevamo anche una casa in campagna, in un piccolo villaggio tra Retorbido e Chiusani (vedi “quelli che hanno fatto l’asiatica”n.d.a.), dove si passavano le vacanze estive e mia nonna riempiva una bigoncia di quelle piccole, praticamente un “navassö”……a questo punto devo fare una digressione perché qualche tempo fa ho scoperto che un mio interlocutore (un ragazzo di Milano*) non sapeva cosa fosse una bigoncia, detta anche navassa e ho impiegato un po’ per fargli capire che una volta le galline erano libere e “vestite” e non nude come le vedeva lui nel banco frigo del supermercato e si chiamano ruspanti perché razzolano nell’aia ma anche sul mucchio di letame. Ma torniamo alla nonna che riempiva metà questo navassö di acqua e lo lasciava al sole nei caldi meriggi di agosto e, quando l’acqua diventava tiepida, mi facevo il bagno in questa mia piccola piscina rustica. Le parti maggiormente interessate durante l’estate erano: le mani, sempre prima di magiare, la faccia al mattino e faccia, ascelle, gambe e ginocchia la sera soprattutto gambe e ginocchia che erano la parte più sporca del corpo e la più ferita. Ora tutti hanno la mania della doccia: “hai fatto la doccia?”, “mi faccio una doccia? Anch’io mi faccio la doccia parecchie volte, d’estate più sovente, mi lavo con cura tutte le mattine anche se preferisco ancora un bel bagno per immersione in una nuvola di schiuma e musica di sottofondo. Ma per alcuni la doccia è diventata quasi una ossessione; ma saranno poi così puliti come vogliono farci credere: belli fuori e puliti dentro? Bho!!! Ho i miei dubbi. Sempre per bontà vostra GIU.BA. * Ho le prove: un gruppo oratoriale di Milano li portai in una nota azienda agricola di Casteggio (Crotesi) e li videro le galline vestite e mi chiesero se gli asini attaccano. “Si i tacan a rid”.
LETTI E PUTTANE: In una grande azienda arrivò la crisi. L’ Amministratore Delegato, l’AD, convocò tutti i capi servizio e i suoi consiglieri per affrontare il problema. Dopo vari conciliaboli annunciò la soluzione del problema: Il Capo Servizio dell’Ufficio Commerciale passerà alla logistica, quello della logistica alle risorse umane quello delle risorse umane alla gestione automezzi quello degli automezzi alla produzione, e avanti cosi per tutti i settori della azienda. Tra i presenti c’era pure un ultimo assunto che cercava disperatamente di farsi ascoltare ma veniva sempre zittito “Per il momento lei stia zitto che è appena arrivato in azienda” ma il giovanotto non demordeva e continuava a chiedere la parola che finalmente le venne data: “ la mia nonna gestiva un casino, un bordello a Genova, le cose andavano bene sinché la flotta, soprattutto quella americana era in porto, ma appena questa salpava gli affari languivano. Ma per risollevare la situazione lei non cambiava il posto ai letti, cambiava proprio le puttane”. Ora potete utilizzare questo aneddoto come volete, cambiate pure i personaggi: amministratori, politici quello che vi viene meglio ma vedrete che la morale resterà sempre quella. Chi ha orecchie per intendere ….in tenda, tutti gli altri in roulotte. T’è capì Giuann?? Breve ma intenso. Sempre per bontà vostra. Giu.Ba.
HAMBRE HAMBRE: Spreco alimentare???? Hambre in spagnolo significa fame e in uno dei miei viaggi sulla Rua de la Plata in Andalusia, era diventata una sorta di parola d’ordine, quando si faceva l’ora di una sosta qualcuno dei miei due compagni di viaggio spagnoli cominciava a gridare “hambre, hambre” e questo accadeva di solito nel primo pomeriggio in prossimità di un posto di ristoro, bar o trattoria che dir si voglia. Quando da ragazzo vivevo a Genova dove frequentavo le superiori, il giovedì la mia parsimoniosissima zia, dichiara la giornata del “kata su”, ovvero prendeva gli avanzi di tutta la settimana, che conservava gelosamente nel “frigideiru”, e preparava un polpettone con un intingolo di pomodoro gustosissimo e così il “frigideiru” tornava libero. In questi giorni di pandemia ho avuto l’occasione di andare al supermercato e parcheggiando praticamente nello spazio retrostante il magazzino dove ho notato con disappunto una catasta di cassette contenete frutta e verdura scartata dagli scaffali. Mi ha fatto specie un mazzo di banane, 6 o 7, praticamente solo un poco annerite, identiche a quelle che, nel mio portafrutta a casa, stanno sul tavolo. Lo ammetto, mi sono avvicinato per esaminarle e assieme ad esse c’erano altri prodotti: arance, finocchi, due meloni, ciuffi di insalata ecc. Ho notato che a una certa ora in quel posto arriva un uomo con la bicicletta, sul portapacchi ha legato due cassette una davanti e una dietro, si mette a selezionare i prodotti e alla fine si porta a casa due belle cassette di frutta e verdura. “Per creare un radicale cambiamento nelle nostre società è necessario rifiutare tutte le ingiustizie che oggi cercano la loro giustificazione nella ‘cultura della scarto’- una malattia ‘pandemica’ del mondo contemporaneo” così parlò Papa Francesco che di questa cultura in Argentina ne ha fatto ampia conoscenza. Per motivi professionali ho sempre combattuto lo spreco soprattutto di cibo. Dirigendo per anni quella che è la Ristorazione Collettiva destinata soprattutto ai giovani studenti, mi sono scontrato più volte con questa realtà dello spreco e dello scarto: o è perfetto o è da scartare. Durante il servizio di distribuzione dei pasti mi mettevo in zona restituzione vassoi e osservavo quello che veniva lasciato, diciamo una sinergia fra il controllo qualità del prodotto offerto e la soddisfazione del cliente. Mi confrontavo poi con il capo cuoco per aggiustare il tiro. E in quella posizione potevo notare ciò che tornava e finiva nel dissipatore. Vassoi completi di primo, secondo e contorno a cui mancava solo un boccone di pasta e un morso di bistecca. Mi concentrai poi sul pane, l’utente aveva nel menù la possibilità di prendere una panino imbustato, se avevano necessità potevano prenderne un altro, soprattutto quelli del collegio che lo usavano per una eventuale merenda. Malgrado le mie raccomandazioni, tutti o quasi prendevano due panini. Io avevo ordinato al magazziniere di verificare i panini che tornavano intonsi e “riciclarli”. Ebbene qualche sciagurato, giusto per gradire, riempiva il secondo panino intonso di stuzzicadenti obbligando il mio collaboratore ad un attento esame prima di rimetterlo al consumo. Purtroppo finché manterremo questa cultura dello spreco e dello scarto continueremo a vedere gente che riempie i carrelli, come abbiamo visto recentemente, e altri che frugano fra gli scarti – ho scritto scarti volutamente e non rifiuti – vorrei sperare che tutto quello che hanno comprato lo abbiano utilizzato e non lasciato scadere nel frigo o ammuffito nelle dispense. Mi hanno assegnato goliardicamente la laurea honoris causa in economia e risparmio perché feci sostituire il cucchiaio del parmigiano con uno più piccolo da frutta, ma ancora oggi ribadisco che rifarei tutto panino e cucchiaino. Lo spreco, soprattutto di cibo, mi fa venire l’orticaria. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
AUTOSTRADE.....: Camicia bianca con righe sottili che ne trafiggono il candore, capelli con sfumatura alta alla West Point, una magrezza al limite delle ossa, telefonino con auricolare all’orecchio e sguardo perso nel vuoto mentre parla accompagnandosi con gesti delle mani e ascolta i misteriosi messaggi che gli giungono attraverso l’etere, passeggia avanti ed indietro pare parlare al vento: ecco uno degli abitanti del villaggio globale che sono le autostrade. Autogrill di un posto qualunque della penisola, TIR come bisonti che attendono solo il grido per ripartire e divorare i kilometri di strada, verso l’ignoto verso il nulla verso il domani. Autostrade, un mondo che si muove, che vive e che muore, di giorno e di notte. Polvere d’acqua che ti travolge che t’investe, che ti annebbia il parabrezza, che ti fa paura che non ammette la minima distrazione il minimo smarrimento. Le luci rosse si trasformano in mille gocce colorate fra un colpo e l’altro delle spazzole dei tergicristalli, bianche gialle arancioni; avanti, avanti un altro camion un altro sorpasso, Spagna o Francia, da dove vieni fratello, dove ti sta portando la strada. Una nuvola d’acqua e mi sei già dietro. Oppure è il sole cocente che infiamma l’asfalto, nebbiolina tremante per la calura e che fa chiudere gli occhi pesanti di caldo e di sonno nel riverbero della luce accecante. Autostrade vie di fuga e di ritorni, spade che trafiggono i monti e attraversano le pianure sconfinate, sfiorano montagne e costeggiano fiumi, città case paesi, altre vite altre spiagge altri sogni e sempre. dietro l’ultima curva. ecco improvvisamente il mare. Un mondo a parte popolato da personaggi variopinti, variegati che pare possano sopravvivere soli li, solo in quella dimensione. Scendono dalle macchine dai camion, come se fossero coscienti di interpretare la parte di una commedia grande come la vita, che ha come fondale il mondo e una sceneggiatura misteriosa, si muovono ma non parlano, il loro copione non prevede che si esprimano, che comunichino. In rari casi comunicano solo con quelli della loro tribù, quelli che vivono all’interno della loro macchina, quelli che guidano autotreni simili. Nelle aree di servizio il popolo delle autostrade si incontra si sfiora, mangia beve si ferma davanti agli scaffali dei dolci dei souvenir, guarda tocca, quali saranno i pensieri i desideri i ricordi mentre osservano un oggetto un libro, per chi sarà il giocattolo, il pelouche, la bottiglia o forse il cappellino di tela blu, per chi saranno i pensieri. Ho visto molte autostrade e tutte mi hanno lasciato un nuovo ricordo. Autostrade ordinate dell’Austria, povere dell’Ungheria, con quei saliscendi nel cuore della puszta, con i campi di grano e i balloni di paglia per kilometri, le verdi valli che accompagnano le autostrade di Slovenia, le autostrade dell’ex Jugoslavia (durante la guerra nei Balcani) con le carovane di gente in fuga e le colonne degli aiuti umanitari con le mille bandiere della solidarietà e quelle facce simpatiche e barbute dei nostri ex alpini alla guida che quando li sorpassi ti fanno i fari di saluto, autostrade svizzere e tedesche, precise pragmatiche, numerate…. : Un kilometro al paese che cerchi, 20 kilometri al paese che non raggiungerai mai, alla vostra destra il fiume Reno e alla sinistra il cantone di S. Gallo, cavalli ed aironi della Provenza, piatta terra d’acqua e di madonne, gitani danzanti nei falò della notte. Davanti a te il viaggio, l’avventura, nuove scoperte, nuova gente. Le aree di sosta sembrano villaggi turistici, panchine gazebi, telefoni servizi, voi siete qui vi indica una carta geografica, una freccia nel cuore d’Europa, un punto infinitesimale sulla faccia della terra. La gente arriva scende, telefona, passeggia, fuma guardando il traffico, riparte. Gli uomini in divisa dei distributori, benzina per una altro pieno, per un’altra corsa…… “Mister petrol or diesel, benzin vagy dízel”, e ti guardano tenendo la pistola della benzina sollevata in attesa di un tuo cenno….. “Dìzel …OK amico sei il primo che mi parla da 600 kilometri a questa parte”. Si riparte, la strada nel blu della notte sotto un altro cielo verso un altro distributore, un altro bar pieno di fumo e di salsicce che abbrustoliscono sulla fiamma di un grill, zingari rumorosi con cento bambini piangenti, punk dai capelli arancione e i giubbotti pieni di borchie, da una vecchia mercedes fanno capolino alcune ragazze e un uomo sospettoso, dallo sguardo inquietante, carne fresca per le periferie delle metropoli d’Europa. Un telefono per sentire una voce dall’altro capo dell'Europa che ti dica “Ciao pa’, ma dove diavolo sei?” Nel buco del culo del mondo, ma una autostrada mi riporterà indietro e viaggerò nel tramonto con il sole che trafigge il parabrezza, verso ovest, verso casa, verso affetti e profumi antichi e l’asfalto nel riverbero degli ultimi raggi del giorno sembrerà diventare d’oro. Giu.Ba.
GLI INDOMABILI - Indiani - Solitamente il film lo guardavamo dopo il catechismo, anzi chi non andava a catechismo non poteva andare al cinema. A San Rocco la saletta era un “bugigattolo” dietro la sacrestia, fungeva anche da teatro dove regnava il buon Beppe Buzzi. Le sale ed i teatri parrocchiali moderni di San Rocco,dei frati e dei Barnabiti erano di la a da venire. Solitamente proiettavano “filmacci” in bianco e nero con la solita trama cauboi contro indiani. Gli indiani erano sempre rappresentati come i cattivi, mentre i cauboi erano i buoni che vincevano sempre. Gli indiani (quelli con le piume) avevano sempre un aspetto truce, brutti, sempre a torso nudo, che ruzzolavano a terra fra la polvere colpiti dalla infallibile mira dei nostri eroi. Poi se la situazione degenerava avvivava il 7° Cavalleggeri che a suon di carica, con le camice blu fresche di bucato (si vedevano ancora le pieghe del ferro da stiro) salvava i nostri eroi mettendo in fuga i cattivi pellerossa. Sono/siamo cresciuto/i con la falsa verità che i nativi americani erano i cattivi e i bianchi i buoni. Poi con l’andare del tempo, qualche lettura e qualche documentazione ho cominciato a capire che le cose non erano andate proprio così. I bianchi, i visi pallidi, stavano espropriando le terre di questi nativi quasi sempre con la forza, anzi con la crudeltà, di fatto una pulizia etnica. Poi qualche libro come la vita di Geronimo, la storia dei Sioux e la documentazione su tutte quelle tribù che popolavano il Nord America, fondamentalmente pacifiche, qualche film coraggioso “Soldato Blu” o “Balla coi lupi” per esempio, oppure la ballata di De Andre sulla battaglia del fiume Sand Creek, hanno cominciato ad aprirmi gli occhi - se così si può dire- sulla vera intera vicenda storica. Proprio la battaglia del Fiume Sand Creek è stato l’esempio di quale crudeltà erano capaci i bianchi: 700 soldati armati sino ai denti contro 600 nativi, ma solo donne vecchi e bambini, dato che i guerrieri erano lontani “sulle piste dei bisonti”. Fu un massacro furono trucidati circa 150 nativi la maggior parte donne e bambini (130) e una trentina di “uomini”, nessuno ha mai contato i feriti. I soldati ebbero pochissimi caduti, la maggior parte colpiti da fuoco amico tanta era la confusione e l’inesperienza dei militari. Gli indiani, dopo questa battaglia, si coalizzarono e scatenarono rappresaglie contro i colonizzatori, rappresaglie di eguale crudeltà, che durarono anche anni. Poi la forza soverchiante dei bianchi, qualche tradimento e patti non rispettati, costrinsero i nativi a rinchiudersi nelle riserve dove iniziarono ad estinguersi o comunque non dare più “fastidio” al governo degli Stati Uniti. Contribuì anche l’alcol e altre situazioni a sfinire queste etnie ma, come si dice, furono capaci di vendere cara la pelle e dare del filo da torcere ai visi pallidi tanto che coniarono il famoso adagio “l’unico indiano buono e l’indiano morto” e li massacrarono. Eppure loro erano quelli che usurpavano le terre dei nativi legittimi fruitori di quelle aree comunque rappresentati sempre come “truci, brutti e cattivi”. E pensare che noi all’arrivo dei “nostri” applaudivamo. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
LA MEGLIO GIOVENTU’ - Una generazione che rischia di scomparire. Non vorrei sembrare ovvio, scontato, facendo sempre riferimento a delle vecchie foto per fare le mie riflessioni, ma questa volta la riflessione è particolarmente seria: a causa di questa epidemia sta scomparendo una generazione, la mia generazione, la generazione di quelli nati dagli anni 40’ agli anni 50’. Ho preso per esempio questa foto che mi ritrae con la mia squadra di conducenti muli durante il mio servizio militare. Guardando questa vecchia foto una domanda mi sorge naturale: in questi tragici frangenti che fine avranno fatto questi ragazzi. Sono tutti ragazzi della mia età, miei coscritti, ma voglio anche parlare di quelli nati prima e dopo nell’ambito di quel decennio. L’Italia era uscita malconcia dalla guerra e quei ragazzi sono quelli che hanno poi contribuito, con il loro lavoro, certamente assieme ai loro genitori, a fare la nuova Italia, sono quelli del boom economico, della Milano da Bere, che hanno lavorato nelle grandi fabbriche del nord, alla Breda alla Redaelli, alla diga di Assuan, sono quelli partiti dal sud dell’Italia per andare a lavorare alla “FIATTE” di Torino e i loro figli sono poi diventati dirigenti delle azienda per le quali avevano lavorato i loro padri. Quelli che prendevano il treno tutte le mattine per andare a lavorare, nel gelo dell’alba o nei mesi roventi dell’estate. Quelli che la 500 l’hanno comprata a rate. Troppo giovani per aver fatto la Resistenza e troppo vecchi per vivere il 68’. Sono gli stessi che, oramai in pensione, stanno montando gli ospedali da campo a Cremona o fanno parte attiva della Protezione Civile, Alpini e non. Ma anche semplicemente facendo i nonni (semplicemente non significa facilmente, a volte non è facile nemmeno quello). Malgrado questo impegno, questa voglia di vivere, parecchi di loro, di noi, stanno “mancando”, o come dicono gli Alpini"sono andati avanti" ho preferito questo sinonimo forse meno crudo ma egualmente significativo. A San Giuliano di Puglia 16 anni fa un terremoto distrusse una scuola dove morirono 27 bambini e una maestra e per quel piccolo paese qualcuno affermò che era scomparsa una generazione. Una generazione, la mia generazione che, malgrado l’allungamento significativo della aspettativa di vita, in questi momenti sta subendo un duro colpo. Mi fermo qui, non voglio diventare ne banale ne retorico. Vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
IL MAESTRO - Visti da vicino: Uto Ughi. - Lo avevo visto il 2 di aprile del 2000 quando a Casteggio tenne un magnifico concerto in San Pietro la nostra chiesa sul Pistornile. Una serata memorabile., emozionante di quelle che resteranno nella memoria. In quelle estati avevamo deciso di trascorrere le nostre vacanze all’Isola del Giglio, un luogo un poco fuori dalle rotte vacanziere, tranquillo e con dei tramonti viola che lasciavano a bocca aperta ma anche dove scoprimmo che il Maestro Uto Ughi aveva casa. Noi (io e mia moglie) alloggiavamo in un albergo a Giglio Campese e per muoverci sull’isola utilizzavamo i mezzi pubblici (è vietato utilizzare la propria macchina per spostamenti interni) e muovendoci alla sera scoprimmo che il Maestro abitava in una splendida palazzina a Giglio Castello. Ma, questo importante, frequentava la nostra stessa spiaggia. La leggenda vuole che per venire in spiaggia, scendesse a piedi dalla sua abitazione sino al mare, sicuramente più di un paio di kilometri. E quando arrivava, facendosi precedere da una telefonata ai bagnini, sotto gli ombrelloni, fra le sdraio e gli asciugamani stesi sulla sabbia, si percepiva un mormorio, soprattutto dalla componente femminile. “Il Maestro scende in spiaggia” un brusio, quasi un brivido, come un venticello leggero, da qualche borsa spuntava uno specchietto, un pettine, un lucidalabbra, gli oli al cocco spandevano il loro afrore lucidando spalle e schiene. I maschietti abbassavano la Gazzetta e cercavano di scoprire a cosa si riferiva tutto quel tramestio “Prepara il kayak” gridava il capo bagnino al suo assistente e subito il ragazzotto si prodigava a preparare quella leggera imbarcazione, la pagaia doppia e preparava la messa in acqua della barchetta. Eccolo finalmente, in braghette corte, un borsello tra spalla e ascella, berrettino con visiera e occhiali da sole. Sorridente attraversa la spiaggia, si ferma a parlottare con il bagnino poi regalando sorrisi a destra e a manca si avvia verso il mare. Lascia il borsello al bagnino, mentre il ragazzo tiene il kayak ,oramai in acqua, per la prora. Il Maestro entra si siede, il ragazzo gli porge la pagaia poi con delicatezza spinge il kayak nell’acqua. Ma mentre il Maestro sta per dare la prima pagaiata, un onda, anzi ondina, dispettosa fa girare la barchetta e la fa ribaltare. Il kayak si capovolge trascinando il Maestro sotto, ma essendo ancora in acque basse lui prontamente si rimette in piedi sbuffando come un tricheco, lasciandosi scappare qualche sommessa imprecazione “Porc§§§a la miser$&%”. Bagnino e assistente si precipitano verso di lui che se ne esce dal mare decisamente contrariato, non tanto per la bevuta ma per la figura, anche se prontamente perdonata dagli astanti. Il kayak veniva prontamente rimesso in acqua e il Maestro nuovamente imbarcato poteva finalmente ripartire verso infiniti orizzonti, immerso nello splendido silenzio della baia pagaiando nel blu del mare e sulle note mentali di qualche ouverture. GIU.BA.
“GIORNATE INDIMENTICABILI” In ricordo di Don Giacomo Buscaglia. Un amico, un maestro. Ho ritrovato una vecchia foto dove, ad un campo di Settembre del Voghera 1°nel 1970, il reparto schierato assiste all’alza bandiera. La foto è molto piccola e il campo visivo è vasto, ma l’ultimo laggiù in fondo alla fila degli scout, con gli stivali di gomma, è riconoscibile Don Giacomo. Don Giacomo Buscaglia ci ha appena lasciati e come si dice nella “vulgata” scout, è tornato alla Casa del Padre. Quando arrivai a San Rocco a Voghera per rilanciare il movimento scout, in quel momento assopito, Mons. Manlio Achilli, Parroco appunto della chiesa Vogherese, assegnò al reparto questo giovane sacerdote, un trentenne allora. Ci fu subito empatia fra noi e, come dichiarerà lui stesso, di accettare con entusiasmo l’incarico perché vedeva nel nostro movimento lo spirito e i valori per una realizzazione completa nella formazione giovanile, sotto l’aspetto non solo religioso, ma anche culturale e ambientale. Sempre ricordando quei tempi Don Giacomo ebbe occasione di sottolineare quelle “giornate indimenticabili e ora che il tempo è trascorso non posso dimenticare, anche con un velo di nostalgia, tutti quei giovani, i campi nei nostri Appeninni, le serate attorno al fuoco”, oppure anche dove gli era capitato di contemplare le stelle da sotto un pino dentro il sacco-pelo, oppure svegliarsi in pieno agosto a Saint Moritz, con dieci centimetri di neve. La sua è sempre stata una partecipazione al nostro movimento in maniera qualificante e coinvolta. La nostra amicizia andò ben oltre l’esperienza scoutistica, fu infatti lui a battezzare Daniele, il mio secondo figlio, e fino ai giorni nostri con un sempre rinnovato pensiero o occasioni di incontro. Mio figlio, quando era piccolo, lo chiamava Gion Bacono, e in fondo per lui ancora oggi lo ricorda così. Io invece lo voglio ricordare con affetto come un amico, come un maestro indimenticabile. A nome di tutti quei ragazzi ora voglio augurati solo “Buona Strada Don”. Giuliano Balestrero Già Capo Gruppo del Voghera 1°
QUELLI CHE ………HANNO FATTO L’ASIATICA: Nel 1957 avevo 13 anni, e facevo la seconda media, in Italia, ma anche nel mondo, scoppiò l’Asiatica che fu una pandemia influenzale di origine aviaria che fra il 57’ ed il 60’ fece circa due milioni di morti di cui (sempre circa) 5.000 anche in Italia. Fu causata dal virus A/Singapore/1/57, isolato per la prima volta in Cina (la storia si ripete) nel 1954. Nello stesso anno fu preparato un vaccino che riuscì a contenere la malattia. Questa forma influenzale si manifestò stagionalmente fino al 1968. Anche in quel caso le autorità chiusero la scuole ma la vita continuò egualmente come sempre, la gente andava a lavorare e, purtroppo, qualcuno, anzi parecchi, se ne morivano in casa, nel silenzio più assoluto. Io fui mandato in esilio (in quarantena ma mica tanto) dove i miei avevano una piccola tenuta agricola gestita allora dai mezzadri. Non ho mai avuto questa forma influenzale perché nel mio caso, quando scoppiò la pandemia non ero a scuola, mi trovavo già a casa perché avevo fatto una indigestione, più che altro intossicazione alimentare, avevo infatti mangiato di nascosto una scatoletta -250 grammi- di antipasto,tonno e verdure varie. Mi ricordo anche la marca, esistente tuttora che non posso dire, anche perché la colpa era mia, infatti ne feci una scorpacciata tale che passai la notte a storcere le maioliche in bagno e a riportare alla luce tutto quello che avevo nello stomaco. Quindi a letto un paio di giorni con questa indigestione. Appena si seppe delle scuole chiuse a causa del virus, i miei mi spedirono in campagna, anzi in collina in quel di Cadezzano, un minuscolo villaggio in Val del Rile in comune di Rivanazzano. Era primavera inoltrata e quindi con gli altri ragazzini del villaggio si organizzava di tutto: dalla costruzione di capanne nel bosco, la ricerca di nidi, corsa con le carriole piacentine con le bambine come passeggero ed altre mille cose. Sporco, con le ginocchia sbucciate, con la candela sempre al naso, d’altro canto i mezzadri, pur tenendomi d’occhio, avevano altro a cui pensare e io me ne approfittavo di questa libertà inusuale, insomma per dirla come mio papà quando venne a riprendermi una ventina di giorni dopo “Ma ki lè sempar festa???” ovviamente non avevo fatto nulla di didattico, ne compiti, ne letture, ne capitoli di libri, ne di nessun genere di scolastico, solo corse nei campi ad inseguire solo le mie fantasie di ragazzino. Un bel ricordo forse imparagonabile con l'attuale situazione, ma vedrete che anche questa volta andrà tutto bene. GIU.BA.
DEDICATO A QUELLI CHE……SONO COME TAFAZZI: Ho dovuto, purtroppo, usufruire, se così si può dire, dei servizi di un ufficio pubblico, la prostata preme. Li ho chiamati servizi igienici per pudore il loro vero nome sarebbe “cessi”. Per distorsione professionale noto subito alcune cose che stridono, che vanno contro le regole e le leggi. A prescindere che i muri dimostravano tutta l’incuria e l’ingiuria del tempo, per non parlare del pavimento, alla tazza mancava la tavoletta, va bhè, si evita di bagnarla, certamente una signora dopo aver visto la condizione in cui versava l’ambiente, probabilmente la tiene sino a casa. Non c’era sapone nel distributore, non c’era carta per asciugarsi le mani, il soffione di aria calda era distrutto, il lavabo aveva i rubinetti e non il meccanismo per utilizzare il gomito o il pedale per aprire l’acqua. Ma la cosa che mi ha dato più fastidio è il fatto che questi pubblici uffici sono demandati a verificare che le leggi siano ottemperate. E loro.....??? Se in un pubblico esercizio commerciale ci fossero queste situazioni igieniche nei bagni, il pubblico esercizio commerciale verrebbe chiuso immediatamente e messo al pubblico ludibrio. Per carità ci sono le eccezioni, ma in gran parte sono sufficientemente curati. E a proposito di esercizi commerciali, da qualche tempo noto su F.B. una signora che si diverte a cercare il pelo nell’uovo ovunque. L’ultima sua esternazione riguarda, in tempi di corona virus, il fatto che ha sorpreso un cliente di un bar a bere la consumazione al banco e non al tavolo come prevede la delibera regionale. A prescindere che non è chiaro se la delibera regionale si riferisce “dalle ore 18 in poi o sempre” vorrei ricordare che in questi periodi il settore commerciale è in grave sofferenza. A parte le delibere, la clientela è diminuita in maniera esponenziale e alcuni esercizi presto saranno costretti a ridurre il personale se non a chiudere. Gentile signora, capisco la sua voglia di censurare tutto ciò che a suo avviso va contro la legge o le regole, ma esiste anche la parola “tolleranza” in un periodo cosi tribolato, tanto in termini sanitari come in quelli economici, un poco di tolleranza non farebbe male. Conosce Tafazzi… quello che si picchia le bottigliate sui gabbasisi, ecco le sue esternazioni mi ricordano Tafazzi e il tafazzismo. Vale anche per Lei il”tanto peggio tanto meglio” e facciamoci del male a vicenda? La prego ogni tanto sia tollerante in fondo noi tolleriamo lei. E se a Casteggio tutto le da fastidio, vada ad abitare in una casetta in un bosco, ci sono solo gli uccellini che fanno rumore. O le darebbero fastidio anche quelli. GIU.BA:
Fare e sapere: Il valore delle parole a volte può determinare il successo o l’insuccesso, ma ancora, può determinare il percorso individuale di ognuno di noi. Cosa significa la parola fare? Dal latino “facere” ed il significato si raccoglie attorno al concetto di produrre un effetto con il lavoro manuale o con l’ingegno. Pare addirittura che abbia radici indoeuropee. E la parola “sapere” anch’essa dal latino “sapère” e come sopra con origini indoeuropee, ovvero avere sapore, essere saggio in parole povere avere sale in zucca.. Uno scioglilingua indica una frase che analizzandola si rivela importante soprattutto per promuovere un prodotto o trasmettere una emozione ovvero: “ Fare, Saper fare, Far sapere”. Chi di voi nella vita professionale, ma non solo quella, si è trovato di fronte ad un amico-collega-avversario che si è fatto strada grazie ad una unica prerogativa farsi credere capace, insomma “Far sapere che sai fare senza fare”. E quanti sono stati messi in disparte, sottovalutati solo per il fatto che hanno trascurato un importante fattore: la capacità di informare gli altri delle proprie potenzialità “Fare senza far sapere che sai fare”. Timidezza, basso profilo, forse ma le opportunità le prendevano gli altri al volo che invece sapevano vendersi bene. Poi ancora coloro che si crogiolano nella loro routine quotidiana attendendo con pigrizia mentale le 17, il sabato, la fine del mese e la pensione insomma coloro che costringono il loro cervello a suicidarsi di noia ma con la consapevolezza che è così che gira il mondo (secondo loro), insomma “Fare senza saper fare e facendolo sapere”. Tre situazioni di vissuto che nel loro complesso sono tutte negative perché le loro risorse personali alla fine vengono utilizzate al 30/50 per cento. Ma quale potrebbe essere il rimedio? Ad esempio usando l’ingegno e la creatività ma che certamente non si possono cavare da cervelli atrofizzati da anni di attività e a mezzo servizio. Bisogna che il mondo che ci circonda sappia quello che sappiamo fare e noi dobbiamo dire ciò che sappiamo fare, nella professione e fuori dalla professione, nel tempo libero e perché no, anche dopo la professione e qui mi rivolgo a quelli che superato il periodo lavorativo si danno da “Fare e lo fanno Sapere”. Il nostro cervello è una fonte inesauribile di risorse basta tenerlo allenato e non lasciarlo atrofizzare nella noia, nella abulia, nella routine quotidiana, ma cercando nuovi stimoli e facendo sapere ciò che sappiamo fare e vedrete che la vita si può assaporare sino all’ultima goccia come un buon bicchiere di vino. Tè capì, vi saluto brava gente Sempre per bontà vostra GIU.BA.
L’ULTIMO LIBRO. Bello!!!......Chiudo il libro, è l’ultimo che ho letto, è finito, le ultime pagine mi hanno emozionato, lo appoggio sul comodino, tolgo gli occhiali e spengo la luce. La stanza piomba nel buio della notte, un buio perfetto, non ho mai avuto questa sensazione di buio perfetto, questa stanza ha questo pregio: il buio è buio, non filtra luce. Resto a guardare nel buio il soffitto. Per strada, grazie al coronavirus, non passa nessuno, niente motorini smarmittati, ci saranno appena arriva la primavera e l’estate ma questa sera no! Il sonno profondo di chi dorme accanto a me è confermato dal respiro regolare, caldo. La notte è silenziosa. E’ venuta anche per me l’ora di riposare. Buona notte. GIU.BA.
CARO LIBRO…QUANTO MI COSTI!!!!!! Ebbene si...sono un lettore compulsivo. Non riesco a dormire se prima non ho letto almeno 20/30 pagine di un libro, che sia un romanzo, che sia un saggio, che sia Alessandro Barbero, Baricco, Manzini, Vitali, che sia storico o un giallo di Simenon. Da ragazzo quando studiavo (studiavo…..si fa per dire) a Genova compravo i libri della BUR, ne ho fatto collezione, erano quei libricini con la copertina grigia che costavano 100 o 200 lire. Ho letto di tutto e ne sono fiero. Il mio sogno è di creare una stanza con tutti i miei libri ben disposti sulla libreria, tutti, compresi quelli che mi ha lasciato mio padre. Si lamentano che in Italia si legge poco. Sapete cosa costa mediamente un libro: 18/19 €uro, per me che mentalmente ragiono ancora in £ire sono 35/40mila lire. C'è solo una casa editrice che fa pagare 9,90€uro un libro e a volte faccio buon viso a cattivo gioco e acquisto questi libri anche se non sempre sono proprio di mio gradimento. Resta il fatto che leggere sta diventando un lusso. Ogni tanto riesco a trovare qualcosa di buono sulle bancarelle dei libri usati, ma ciò non toglie il fatto che i libri oggi COSTANO TROPPO!!!!!!!. Scusate lo sfogo, ma mi è venuto dal cuore. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
DEDICATO A QUELLI CHE……. “ Speriamo sia grave anzi gravissimo, tanto peggio tanto meglio”, una volta era questa la filosofia dei comunisti ,quelli del PCI, oggi tanto da destra come da sinistra, dal centro dal basso o dall’alto tutti sperano che vada male anzi malissimo all’altro, all’altra compagine, all'altro partito, ma non per prendere il suo posto ma solo per metterlo in difficoltà. Non hanno la soluzione, ma solo il desiderio di vedere in difficoltà l’altro. Facciamo chiudere la fabbrica che forse inquina, ma dopo andiamo a reclamare perché licenzia tutti gli operai. Ora è la volta del Corona visur o vairus, come dice un nostro ministro (Dio ci salvi) e qui alcuni sperano che faccia dei danni per poter dire "avete sbagliato tutto", noi avremmo fatto diversamente, diversamente cosa????......, diversamente........... Votiamo contro, ma contro chi??? Contro gli altri! Ma quali altri, gli altri siamo noi, siete voi. Avete la soluzione? No! E allora state zitti finchè non avrete la soluzione tanto poi i vostri competitori vi voteranno contro a loro volta. Sempre per bontà vostra GIU.BA,
TEMPESTA SULLA MANICA, IL CONTINENTE E’ ISOLATO. E così gli inglesi se ne sono andati, ci hanno lasciati soli mentre loro si godono il loro splendido isolamento. In realtà in Europa non ci sono mai venuti, hanno sempre tenuto un atteggiamento distaccato, si sono tenuti la loro moneta, la sterlina, i loro penny o il pound. Il pound??? E cos’è il pound, (leggasi paund) ecco come viene spiegato da un noto sito finanziario: “Che differenza c’è tra pound e sterlina? Non c’è nessuna differenza! A questo punto è d’obbligo chiedersi, perché allora due nomi? Perché pound è il termine inglese per dire sterlina in italiano. E ancor meglio sarebbe bene dire pound sterling, dove one pound è uguale a una sterlina. Se si volesse approfondire la conoscenza della valuta del Regno Unito sarà utile sapere che ogni pound o sterlina è formata da 100 centesimi. Questi ultimi in inglese si chiamano pence o penny o addirittura in forma abbreviata p. Quindi, le banconote saranno da 5, 10, 20, 50 pounds o sterline, invece le monete sono da 1, 2, 5, 10, 20, 50 pence più 1 e 2 pound”. Capito? No! Nemmeno io, so solamente che nelle due occasioni che mi sono trovato a Londra, ma solo all’interno dell’aeroporto di Stansted in attesa di una coincidenza, nella necessità di mangiare un panino, anzi un sandwich, insomma un “sanguis”, alla cassa mi mandarono a cambiare gli €uro in pound, 20 per la precisione. Mi riempirono le tasche di monetine e a quel punto cercai di spenderle tutte prima di salire in aereo, ma ne avanzai comunque qualcuna. Se chiedi a loro qualche cosa, devi farlo solo in inglese, loro non parlano altra lingua, in Italia se vuoi avere la possibilità di un posto di lavoro devi sapere l’inglese fluente, loro no, non sono tenuti a sapere l’italiano fluente ma anche il francese o lo spagnolo. Quindi se hanno voluto abbandonarci al nostro destino, noi ce ne faremo una ragione, non rimpiangeremo certamente “la perfida Albione”. Quindi basta “the book is on the table” o “open the windows”. Mi viene in mente la storiella del nostro compaesano che tornato da Londra non si capacitava della lingua inglese: insomma i cavalli li chiamano ors, le strade le chiamano strit, la corriera la chiamano bas e una ragazza all’angolo di una strada mi ha detto “lavmi”……”ma lavat ti da sula, scarusona”. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
IL MANISCALCO: Allora si facevano i “tre giorni” e quando mi presentai il maresciallo addetto all’arruolamento mi chiese quali erano gli studi fatti, che professione stavo svolgendo e mi disse che mi avrebbe inviato prima alla scuola militare di Spoleto (ad Aosta non c’era posto ?!?!) e poi a Pinerolo per essere assegnato ad un’altra scuola per comandanti si squadra ACS salmeristi. Salmeristi??? E che voleva dire? Allora non c’era Wikipedia e mi affidai al Devoti-Oli: salmerie, trasportatori di salme?!?!. no di salmerie e per essere brevi le famose jeep con il pelo ovvero i muli. Me ne feci una ragione e obtorto collo e facendo “buca da rid” giunsi infine alla scuola di cavalleria di Pinerolo. Ma la mia destinazione era il Battaglione Artiglieria di Montagna “Susa” ma rimasi li. Va bhè, mi dissi, purchè si faccia in fretta e che questo periodo di vita, allora obbligatorio, passi presto. Li imparai,anzi, vidi per la prima volta i muli e i cavalli, certo li vidi da vicino,li toccai, ebbi a che fare con i conducenti muli degli alpini e i palafrenieri (chi governa i cavalli) dell’esercito, la scuola di Veterinaria, l’infermeria quadrupedi e la scuola dei maniscalchi alpini e dell’esercito. Ma se quando arrivavano i Carabinieri a cavallo da Roma, questi si impegnavano molto per imparare l’arte della mascalcia, i militari di leva non avevano il medesimo entusiasmo. Parecchi venivano dalle montagne del cuneese e avevano già una certa confidenza con gli animali, ma a fare i maniscalchi non ci pensavano proprio. Si “imboscavano” ovunque, scomparivano anche per tutto il pomeriggio e a volte li trovavo a dormire nelle scuderie o nei magazzini del foraggio. Allora per parecchi di loro poteva sembrare un lavoro umile e degradante, a volte gli animali, soprattutto se ti avvicinavi alle zampe posteriori rilasciavano materiale “fecale” addosso all’allievo maniscalco intento a ferrare la bestia. Per non parlare dell’odore che impregnava l’aria ma anche gli abiti e le scarpe, io stesso ho dovuto buttare più di un paio di scarponcini corrosi dall’urina degli equini e mia mamma mi faceva cambiare in garage prima di entrare in casa. Questo è un preambolo per introdurre un’altra esperienza. Molti anni dopo mi trovai in una scuderia di un personaggio che aveva per puro diletto alcuni cavalli ed assistetti all’arrivo del Signor Maniscalco. Arrivò con un SUV e con la sua valigia degli attrezzi che apri con sussiego, scaricò una mini fucina con un bruciatore a gas e cominciò il suo lavoro. Si comportava come un chirurgo, però con precisione e professionalità. Il padrone di casa, in un posto defilato, mi confessò che per avere un buon maniscalco oggi come oggi bisogna prenotarsi e raccomandarsi con una specie di passaparola fra proprietari di cavalli. E poi sono impagabili, praticamente un cardiochirurgo. Ecco un altro mestiere che va scomparendo, anzi è scomparso, tanto sono pochi i maniscalchi in circolazione e mi viene spontanea una riflessione: chissà se quegli alpini e quei palafrenieri che facevano di tutto per non imparare sono poi finiti in catena di montaggio alla FIAT di Torino o alle officine ferroviarie di Savigliano? Ho saputo che a Pinerolo hanno riaperto questa scuola di mascalcia e pare sotto la supervisione di un ex maresciallo che ha la funzione di istruttore. Chissà se era lo stesso che una volta mi disse” dà tu un’occhiata a questi militari che torno subito” e io per darmi un tono girando tra le incudini, presi un ferro per osservarlo con occhio critico e a momenti non finivo in infermeria. Il ferro era nero, ma aveva appena smesso di essere incandescente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
CHIUDI IL FINESTRINO CHE ENTRA IL CREPUSCOLO!!! Cari amici, per questo 2020 avrei voluto cominciarlo con il testo di una canzone che rispecchiasse il mio attuale stato d’animo, ero indeciso tra “Dio è morto” una canzone di Francesco Guccini del 1965 censurata dalla RAI e incredibilmente trasmessa da Radio Vaticana; “Io se fossi Dio” di Giorgio Gaber “not politically correct” per quei tempi ma anche oggi, oppure “L’avvelenata” sempre di Guccini ma solo la frase finale: "Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni: voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate e fate. Tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino e poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare, per chi vuole ascoltare, e a culo tutto il resto".(F.Guccini). Ma a questo punto aggiungo solo questi miei pensieri post natalizi: Primo giorno dell’anno, sto percorrendo la tangenziale Voghera Casteggio, quando mi sovviene che devo passare da Torrazza. Per non passare dalla rotonda Colussi, circumnavigo l’IPER, incredibilmente chiuso, per utilizzare il sovrappasso del centro commerciale, quando mi accorgo che davanti a me viaggia nella mia stessa direzione un’altra vettura che però accosta e si ferma. Ne discende un signore, diciamo un mio contemporaneo, il quale supera a piedi la sbarra chiusa e attraversa i parcheggi deserti, mi fermo defilato per vedere che intenzioni ha. Infatti raggiunge l’ingresso del centro commerciale e verifica se le porte sono veramente chiuse, poi fa “busarola” ovvero con le mani a lato della faccia e la fronte appoggiata al vetro verifica se è veramente chiuso. I casi sono due: o fa parte della sicurezza e sta verificando se le guardie sono al loro posto, oppure dovrebbe farsi vedere, si..... ma da uno bravo!! Finalmente le feste sono finite, si spengono le luminarie, i balconi tornano bui, gli alberi di Natale vengono smantellati e chi aveva trasformato la facciata di casa sua nel COCORICO’ di Rimini, spegne finalmente le luci. La musica nei negozi e/o supermercati torna a essere normale e le stucchevoli melodie natalizie che duravano da fine ottobre, vengono zittite. Sono riusciti a farmi odiare Jingle Bells e Tu scendi dalle stelle. E come dice Riccardo Garrone nel film “Vacanze di Natale” del 1983:” E anche questo Natale se lo semo torto dalla palle”. Buon Anno a tutti Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
ACC……HANNO UCCISO STONE: La banda di fuorilegge esce sparando all’impazzata dalla banca appena rapinata, sono cinque, saltano sui cavalli e continuando a sparare attraversano il piccolo villaggio di frontiera diretti verso le colline circostanti. Ma ecco all’improvviso dall’ufficio dello sceriffo esce LUI con le sue Colt 1873 SAA e senza mirare risponde al fuoco dei fuorilegge; quello più indietro di tutti viene colpito e cade da cavallo, mentre un suo compagno pronuncia la fatidica frase “Acc…..hanno ucciso Stone”. Mentre il gruppo scompare all’orizzonte in una nuvola di polvere, il nostro eroe ripone le armi e:” Vi prenderò, statene certi, fosse anche l’ultima cosa che farò”. Seduti su di un mattone nell’angolo del cortile con tra le mani l’ultimo album di Tex Willer, percorrevamo con la fantasia i sentieri del vecchio West e non aspettavamo altro che la domenica pomeriggio per andare all’oratorio per vedere un altro “polverone” o “pulvron” detto in dialetto, dove l’arrivo del VII° cavalleggeri che arrivava a salvare la situazione, era accolto da urla di giubilo di tutta la platea ed il frastuono era superato solo dalla tromba che suonava la carica. Oggi, e non sono solo elucubrazioni di un vecchio, abbiamo una generazione di zombi che passano il loro tempo con gli occhi incollati sullo smartphone. E più sono piccoli e più sono lasciati alla loro solitudine con questo strumento. Indispensabile, ma, forse, già a sei anni (6 anni!?!?) hanno in tasca il telefono e solo alle 23,30 della notte lo spengono – è una indagine ISTAT- e dormono con il telefono a portata di mano, sempre connessi. Le famiglie, i genitori, pur di non avere dei rompicoglioni tra i piedi, picchiano in mano ai pargoli il dispositivo e li portano al ristorante e mentre loro mangiano e chiacchierano, il ragazzino, con gli occhi incollati allo schermo, gioca a giochini che a volte sono di una violenza inaudita, poi non ci si stupisca se nella realtà danno fuoco ad un barbone che dorme su di una panchina e dopo aver confessato chiedono “Adesso posso tornare a casa”. GAME OVER il gioco è finito. “da quando gli ho dato il telefono sono più tranquilla” come se invece di vivere in una città vivesse nella foresta amazzonica. Quando queste esposizioni sono prolungate ed intense possono comportare la morte delle cellule con necrosi dei tessuti, in quanto superano il meccanismo di termoregolazione. Inoltre è ormai appurato che, di fianco alle varie dipendenze che affliggono la nostra società senza escludere i più giovani, una collocazione predominante l’ha conquistata la “dipendenza da telefonino”, con danni serissimi sullo sviluppo sociale e psichico”. “Per ora – continua Giuseppe Di Mauro, presidente dell’SIPPS – non abbiamo prova di tutte le conseguenze collegate all’uso dei cellulari, ma siamo certi che da un uso eccessivo potrebbero aver origine perdita di concentrazione o memoria, oltre ad una minore capacità di apprendimento, a disturbi del sonno e un aumento dell’aggressività.Inoltre ritengo che ai bambini non debba essere data la possibilità di usare il cellulare o, se proprio non possono evitare per qualsiasi motivo di dare ai propri figli questo dispositivo, spero che venga utilizzato per pochissimo tempo e non per ore intere chattando o mandandosi sms: sono migliaia gli adolescenti che, pur stando nello stesso posto, non si parlano e continuano a tenere la testa bassa sullo schermo del proprio telefonino. Se non mettiamo un freno, o se non ci dedichiamo ad una vera e propria educazione al corretto utilizzo del dispositivo (perché di reali vantaggi, se usato correttamente, ne ha ndr), rischieremo un’invasione da cellulare che comporterà ad una vero e proprio isolamento”. Fonte: http://www.scuola.store/minaccia-dei-pediatri-italiani-basta-cellulari-ai-bambini-danni-sono-nefasti/ Ora non pretendo che si torni indietro nel tempo, la tecnologia avanza, si sono fatti progressi incredibili, il progresso ha fatto passi da gigante maggiormente in questi ultimi cento anni che in tutta la storia dell’uomo, certamente viviamo meglio che cento anni fa,ma anche solo 50. Però il ricordo di quando fingevo di cavalcare un fantastico cavallo, schiaffeggiandomi le chiappe per incitarlo, mentre attorno a me altri 20 o 30 ragazzini nel medesimo atteggiamento partivano alla carica inseguendo immaginari indiani in fuga,ruolo che nessuno voleva fare, mi viene da dire: “Ragazzi cosa vi siete persi”. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
Pensieri e parole
Ora che avevo trovato quasi tutte le risposte, mi hanno cambiato le domande
INTERDIT AUX ITALIENS: Dicembre 1964, troppo vicini a Natale per viaggiare verso nord. Il treno, con un sobbalzo, si ferma nella gelida notte svizzera; voci nel corridoio e nel torpore per il brusco risveglio una voce ti riporta alla cruda e fredda realtà:” il y a la gréve”, c’è sciopero: Tutti giù dal treno con bagagli e valige, tutti sulla banchina di questa minuscola stazione svizzera: Vallorbe al confine con la Francia, un nome qualunque nella memoria geografica. Il treno se ne va vuoto nella notte lasciando una piccola folla di costernati viaggiatori oramai intirizziti dalle gelide folate di vento alpino. C’è una sala d’aspetto che brilla nella notte e tutti ci si accalca sulle panche di legno per lo meno al caldo dei termosifoni. 24 ore fermi li. Soli in mezzo all’estero. La mattina arriva luminosa di sole. Fuori dalla sala fa freddo, un freddo secco che brucia la gola. Bocche impastate e ossa rotte, ci vuole un buon caffelatte. Il piccolo chiosco della stazione ha aperto ed il latte caldo che scende nello stomaco ha un effetto vivificante. Rifocillati da quella tazzona e da due croissant freschi e croccanti, il mondo sembra migliore. Il paese si è svegliato intanto, passa qualche macchina, qualche frettoloso passante e neve, neve dappertutto. Facciamo due passi. Io e il mio amico e compagno di viaggio, facciamo amicizia con uno studente italiano della Sorbona anche lui diretto a Parigi. Passeggiamo e chiacchieriamo sino a mezzogiorno, poi vediamo un bistrot con piccola cucina e la fame dei vent’anni si risveglia prepotente come non mai. Che si fa? Si entra ovvio. Interno tutto legno, tipico delle montagne della Svizzera, tavoli di legno massicci e sedie uguali. Qualche cliente intento a leggere il giornale. Ci sediamo ma nessuno viene a servirci. L’amico studente, padrone di un francese fluente, chiama l’oste. Quello arriva con aria scocciata e proclama “Interdit aux italiens, pertanto alzatevi e uscite”. Non posso credere alle miei orecchie. Per la prima volta e fortunatamente sarà anche l’ultima, qualcuno mi intima un diktat tanto assurdo e crudele. Sono allibito e offeso, incapace di una reazione. Non così l’amico studente che a questo punto, nel suo perfetto francese con sfumature di argot parigino, chiede spiegazioni, vuole sapere, zittisce, sale in cattedra e parte con una requisitoria degna di Cicerone. L’oste resta esterrefatto dalla reazione, non riesce a contrastare, balbetta qualche spiegazione, è oramai senza argomenti e alla fine si arrende e acconsente di servirci. Ma che era successo? Sere prima, un gruppo di italiani o presunti tale, avevano messo a ferro e fuoco il locale inscenando una rissa conclusasi con coltellate e intervento della gendarmeria. Purtroppo capita, è capitato, ma nella ordinata Svizzera degli anni ’60 questo significava una occasione per ribadire la loro insofferenza verso lo straniero – a torto o a ragione - e l’unica e immediata risposta era quello di discriminarlo. Una domenica sera a Casteggio, al solito bar per l’aperitivo, mentre bevo scherzando con il titolare entrano due giovani magrebini, lui e lei, ragazzi come tanti, ordinati e dignitosi, mescolati ad altri che a quell’ora passano il tempo in compagnia in attesa dell’ora di cena. Parlottano, tubano anzi cinguettano, c’è profumo di dolci e di caffè nell’aria. Lui si avvicina al banco e ordina due caffè. Il barista li guarda e dice:” E’ la tua ragazza vero?” Lui sorride e arrossisce, anche lei arrossisce “Lo sai, è più bella di te” Lui ride, prende le due tazzine di caffè con panna e cacao e va a sedersi al tavolino vicino ad altri ragazzi come loro intenti a tubare, a parlare, a cinguettare. Sono uno di fronte all’altra, si guardano e gli occhi di lei sorridono. E’ una bella domenica sera in Italia. Av salut brava gent. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
“MI SONO SEDUTO DALLA PARTE DEL TORTO PERCHE' DALL'ALTRA NON C'ERA PIU' POSTO". Ho portato i pantaloni corti sino al giorno in cui in un noto e prestigioso convitto in quel di Bergamo, non mi hanno colorato le gambe di blu. Era il cosiddetto rito della matricola a cui noi, nuovi arrivati, appena licenziati dalle medie, prendevamo coscienza che eravamo alle superiori. Oggi lo chiamerebbero nonnismo o, peggio ancora, bullismo. Eppure allora era normale per noi maschietti, nati nella prima metà del secolo scorso, portare i calzoni corti sino a pubertà avanzata, una espressione, portare i calzoni corti, a volte utilizzata, non senza un pizzico di ironia, per indicare i ragazzini. Anche d’inverno, sempre, e questa mia affermazione è suffragata da parecchie foto in bianco e nero: cappotto, sciarpa e cuffia e da sotto al cappotto facevano capolino un paio di gambette nude e a volte anche con le calze corte. Normale, tutto serviva a temprare il corpo e lo spirito e, per quello che mi ricordo, non ho mai sentito freddo. Negli uggiosi pomeriggi autunnali, quando il vento gelido faceva cadere le ultime foglie, noi si giocava sotto i viali e nei giardini pubblici con le nostre gambette rosse per il freddo e più di una volta la pelle dell’interno coscia richiedeva l’intervento della crema per le mani della mamma tanto era arsa e arrossata. Ho letto, ma me ne rendo conto normalmente guardandomi intorno, che i bambini-ragazzini italiani, sono i più maleducati e più di una volta ho osservato nonne impellicciate che tengono per mano uno o due nipoti, mocciosi, malmostosi e imbronciati che si aggirano per le gallerie dei centri commerciali mai contenti e sempre più capricciosi con la nonna sempre pronta ad accontentare ogni richiesta che vada dal gioco al gelato. E’ forse anche questo il prezzo del benessere che dobbiamo pagare? bambini sempre più arroganti e incontentabili, impegnati in atteggiamenti da bulli o peggio a dar fuoco a questo o quello, purchè sia un “border line” ai margini della società. “Non può essere stato mio figlio, è un simpatico pacioccone” Il simpatico pacioccone di 16 anni che va in giro alle cinque del mattino a fare danni? ne io ne i miei figli e spero anche i miei nipoti a sedici anni non siamo mai stati in giro alle cinque del mattino. Una nonna ha preso a schiaffi la professoressa della nipote rea di averla richiamata verbalmente con vigore, a prescindere che non ci sono più le nonne di una volta quelle che facevano l’uncinetto con gli occhiali sul naso, ma se togliamo anche la possibilità a chi è demandato alla educazione di rimproverare l’allievo, non c’è decreto che tenga. Ho sentito un parente gongolarsi che il pargolo aveva risposto ad un professore “Stai zitto e ricordati che lo stipendio te lo pago io!!!” Complimenti. Chissà se questi mini mariuoli avessero portato i calzoni corti, che tempravano la mente ed il fisico, si sarebbero comportati così o se fossero costretti a fare il militare, che se vogliamo vedere bene serviva a ben poco, ma ti insegnava un minimo di disciplina e di rispetto, forse si sarebbero trovati di fronte ad un sergente maggiore che il primo giorno di scuola militare ci disse:”Voi non siete…..!!!!” come dire: ricordati che sei una merda. Mi piacerebbe affrontare anche questo tema: il servizio militare e tutte le sue sfaccettature, ma prima o poi lo farò. Vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra, GIU.BA.
IL VIAGGIO DEL CRETINO: Prendiamo un personaggio a cui daremo un nome di fantasia ad esempio Giovannino Pirlazza, mettiamo che abiti a Casteggio ma anche a Voghera o Montebello, ma per la nostra storia va bene Casteggio, in fondo a via Manzoni o via Vigorelli o a Mairano. Si alza di buon mattino, fa le sue solite abluzioni, una piccola colazione, petit dejeuner (è una personcina fine), si veste di tutto punto, prende il sacchetto dell’immondizia casalinga e scende nel box. Prende la macchina, non prima di avere collocato il sacchetto nel baule, e percorre via Manzoni o Vigorelli ecc,. supera piazza Dante, piazza Cavour, piazza Martiri, viale Giulietti e via Milano e si immette sulla tangenziale direzione Voghera. Percorre un paio di kilometri, poi avvistata una piazzola di sosta, si ferma apre il baule estrae il sacchetto e lo lancia sul mucchio di altri sacchetti ivi presenti. Poi incrociando le mani sopra la testa come un pugile vincente, si rivolge ad una ipotetica gradinata dove un ipotetico pubblico gli dedica una standing ovation. Risale in macchina e raggiunge Piazza Cavour, parcheggia nelle strisce bianche e a piedi si dirige verso il centro della piazza dove, con aria sorniona, trascorrerà il resto della mattina dondolandosi sui piedi e a sparare cazzate: “U gava da met dentar Dibala” o altre amenità varie sul Governo, sul Sindaco e sul perizoma di Giorgina. Ho esasperato volutamente la situazione, certo è che bisognerebbe fare una analisi psicologica del personaggio e capire per quale recondito motivo bisogna ingombrare di rifiuti le aree di sosta della tangenziale. Attraversando i nostri paesi e città le occasioni di trovare dei cassonetti sono infinite, cassonetti esterni o interrati, verdi gialli, campane del vetro o della carta. Perché buttare i rifiuti in tangenziale??? Da Casalpusterlengo a San Rocco al Porto verso Piacenza, esiste una strada di scorrimento veloce, ma per quanto veloce sia a qualcuno va bene per scaricare i rifiuti di tutte le dimensioni nelle piazzuole, un vizio comune come vedete. Possibile che nella testa di alcune persone oltre che ai nani che giocano a pallone il vivere civile non rientra nelle facoltà mentali. Ho visto scaricare divani e frigoriferi, facendo una fatica immane, in mezzo alla campagna; sul sentiero che dalla Sbercia va verso Costa Pelata c’è una carcassa di automobile, bisognerebbe dare un premio a che l’ha portata li, si……. il premio dell’idiozia. Fa troppo caldo per arrabbiarmi e perciò mi fermo qui. Vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
ALDASVIDUMIA
ALDASVIDUMIA Per motivi semiprofessionali, da qualche anno ho a che fare con cooperative, catering, imprese di pulizie ecc.. Il 90% del personale è straniero, non solo la bassa manovalanza, oramai anche i cuochi e i direttori di sala. All’inizio dell’estate le associazioni albergatori della riviera adriatica lamentavano la mancanza di personale specializzato nel settore HO.RE.CA ovvero hotel, ristoranti e caffetteria(*). Negli alberghi della riviera romagnola a servire a tavola, oltre a giovani albanesi e rumeni, restano solo vecchi camerieri con i piedi piatti che non vedono l’ora di andare in pensione, solitamente legati da antichi sentimenti di amicizia con i vecchi proprietari. Sono stato ultimamente ad Alassio, anche per motivi legati a ricordi familiari e nell’albergo dove risiedevo, la governante era straniera. Conosceva le lingue e con cipiglio severo comandava uomini e donne di servizio. Anni fa, in un torrido mese di agosto, stavo terminando di allestire i collegi maschile e femminile del Sant’Isidoro di Piacenza, prima che arrivassero i primi studenti per la sessione di esami. Venne a trovarmi un collega di Milano per visitare il cantiere, oramai in fase di ultimazione, per vedere i progressi e le nuove situazioni attuate. Gli feci notare come buona parte degli operari fosse straniera: “Vedi quelli che scavano quel fossetto per i cavi elettrici sono marocchini, il giovane ascensorista, tra l’altro balbuziente, rumeno, ma bravissimo nel suo lavoro, quello che ha saldato la ringhiera della scala con la tecnica a filo è croato, un vero artista, come pure quelli che hanno montato le scale con lo scalino lavorato a toro, (credo si dica così), mentre il capo mastro è bosniaco, non si fiutano molto croati e bosniaci, ma sul lavoro ognuno sta al suo posto”.Salimmo al piano della mensa e incrociammo appollaiato in cima a una scala un altro operaio che nel vedermi chiese ad alta voce “ALDASVIDUMIA” ed io di rimando “Per forza” l’amico e collega mi chiese “Russo?” no , questo è piacentino. Infatti si trovava la in alto di fronte a una scatola elettrica che conteneva cavi delle telecamere di servizio che non funzionavano e la soluzione era quella di cercare il guasto e la frase significava “Lo svitiamo?” e non Dasvidania. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
(*) Si tratta di un problema legato a diverse situazioni (reddito di cittadinanza, contratti neri e grigi ecc.)di carattere soprattutto politico che non ritengo di affrontare in questo contesto.
L'attesa, qualcuno di voi ha avuto la compiacenza di leggere il mio ultimo messaggio, quello intitolato "la casa delle 4 F forse 5", ebbene grazie ai buoni uffici del Prof. Massimo De Paoli, già Sindaco di Pavia, colui che lesse questa poesia durante un matrimonio, sono riuscito a risalire alla poesia ed al poeta. Mi permetto di riproporvela, in quella occasione mi ha emozionato, spero succeda anche a voi. GIU.BA.. Eccola: Esci dalla statale a sinistra e scendi giù dal colle. Arrivato in fondo, gira ancora a sinistra. Continua sempre a sinistra. La strada arriva a un bivio. Ancora a sinistra. C’è un torrente, sulla sinistra. Prosegui. Poco prima della fine della strada incroci un’altra strada. Prendi quella e nessun’altra. Altrimenti ti rovinerai la vita per sempre. C’è una casa di tronchi con il tetto di tavole, a sinistra. Non è quella che cerchi. È quella appresso, subito dopo una salita. La casa dove gli alberi sono carichi di frutta. Dove flox, forsizia e calendula crescono rigogliose. È quella la casa dove, in piedi sulla soglia, c’è una donna con il sole nei capelli. Quella che è rimasta in attesa fino a ora. La donna che ti ama. L’unica che può dirti: “Come mai ci hai messo tanto?” Raymond Carver, Attesa.
LA CASA DELLE 4 F FORSE 5 Una cugina di mia nonna un giorno, tantissimi anni fa, ebbe l’ardire di affermare, nel confronto della mia famiglia, che noi vivevamo nella casa delle 4 F ovvero: fam, fum, fread e fastidi, una maniera per dire che noi eravamo dei poveracci. Io ero allora un ragazzetto, 10/11 anni, ma ero consapevole di cosa dicevano gli adulti. Ci rimasi malissimo e quella cugina (che io chiamavo erroneamente zia) la cancellai per sempre dalla mia personale classifica dei parenti a tal punto che non andai nemmeno, anni dopo, al suo funerale limitandomi semplicemente a dire “pace all’anima sua”. Casa: la casa dove abitavamo in via Roma a Voghera, pare sia poi diventata via Gramsci, era un grosso appartamento al piano terra in un fabbricato fine ottocento, con un grande cortile che ospitava una vigna e una tintoria, ed era casa mia, a me piaceva, era calda piena di affetti. E’ vero non avevamo il riscaldamento centralizzato, ma in mezzo alla cucina troneggiava una grande stufa, quella che chiamavano economica, sulla quale c’era sempre qualcosa che cuoceva e i vapori profumavano la casa. Alle bacchette applicate al tubo del fumo, ar canon dra stiva, erano sempre stese calze e mutande ad asciugare, vivevamo in sette in quella casa. Fame: no, non mi ricordo di avere mai patito la fame, ricordo la minestra riso-patate-burro e le cotolette impanate; fumo: si ogni tanto la stufa faceva fumo che inondava cucina e stanze; freddo: nemmeno in questo caso mi ricordo il freddo, portavo la maglia, oggi si direbbe intima, con le maniche lunghe e le mutande di lana e a letto in inverno mi portavo un mattone refrattario caldo avvolto in una pezza di lana. Fastidi, forse si, mi ricordo che mia mamma mi racconta ancora oggi, allora era il primo dopoguerra, che per fare la spesa si aspettava di vedere cosa ci fosse nella cassa del bar che i miei gestivano e mio nonno decretava quanto si potesse spendere quel giorno per la famiglia. Ma era casa mia e, come ho già detto, io ho avuto una infanzia felice compresa quella casa. Un giorno, solo qualche anno fa, è venuta a dormire a casa nostra mia nipote, la quale però prima di addormentarsi mi disse, quasi con il groppo in gola: “ nonno, però domani mi riporti a casa mia”si vede che mia nipote ha la mia stessa percezione della parola casa . Recentemente ad un matrimonio, durante il rito civile, l’officiante volle leggere una poesia che riguardava la casa e terminava proprio con un lui che tornava a casa e apriva la porta e una lei che gli chiedeva “quanto tempo ci hai messo a ritornare” ma non nel senso di redarguire, ma nel senso di aspettare. Casa è quella cosa che a sera quando chiudi la porta e poi ti siedi a tavola, anche per una semplice minestra e lasci il mondo fuori, ti rendi conto che quello é tutto il mondo che ti serve. Mi ricresce per quella cugina malevola, ma per quanto lei credesse che la mia era la casa delle 4 F in realtà era la mia casa, quella a cui volevo bene e nella quale c’erano tutti i miei affetti di bambino gli stessi che nutro ancora oggi in un’altra casa e in un’altra vita. Dimenticavo: la 5^ F era “fadiga”, quella si che era tanta. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
GLI ORFANI DEL BIANCHINO Bianchin sprusàà; Ho ritrovato, e ne sono stato contento, nei meandri della memoria tecnologica del mio computer, un vecchio articolo – in realtà erano due abbinati - titolanti “Cavatigozzi e l’evoluzione del bianchino” e devo dire, come spesso mi succede, che rileggendoli ho provato la medesima emozione di quando li scrissi. Ho fatto poi recentemente una analisi sulla continua e incessante crescita dei centri commerciali e delle conseguenze sociali che questa crescita comporta, concludendo che si sta chiudendo definitivamente l’epoca della socializzazione da bianchino per aprirsene un’altra epoca da galleria di centro commerciale. Sembra ieri che i nostri anziani e i nostri pensionati passavano il pomeriggio, ma non solo, nei vari circoli ACLI, ARCI, della Caccia o della Pesca, Associazioni varie, Alpini, Combattenti e Reduci, Cooperative e Dopolavoro o come da noi al Centro Sportivo e chi più ne ha più ne metta, ed i loro pomeriggi erano accompagnati da calicetti di vino bianco o rosso, la posta delle infinite partite a carte o a bocce. Mi ricordo un particolare curioso che mi capitò anni fa quando i miei genitori gestivano il mitico Bar Italia a Voghera covo di giocatori di carte incalliti, mio fratello mi indicò un personaggio che solitamente non giocava, o almeno lo faceva poco, ma che in compenso aveva una memoria di ferro nel vero senso della parola, si ricordava di partite a briscola avvenute anche un anno prima, chi erano i giocatori, dove sedevano, cosa avevano in mano, chi aveva vinto e con che punteggio, cose da Guinness dei primati. Ma torniamo alla nostra questione. Quei circoli, quei locali, molto naif, dove si poteva mangiare anche piatti della cosiddetta cucina povera come trippa, frittura, ragò o cassoeula, hanno lasciato il posto a wine bar, enoteche, degustazioni, finte osterie dove solo per il fatto che i tavoli sono di legno e le tovaglie a quadretti bianchi e rossi, vorrebbero essere scambiate per locali storici post bellici. C’è un posto, nella immediata periferia di Codogno, ai margini di un campo da rugby, dove, dentro una baracca raffazzonata, i superstiti di quella generazione, già di buon mattino, avevano davanti bottiglioni di vino e cartocci di acciughe salate e dove io ero entrato sicuro di trovare un vecchio collega, amante di questi luoghi e di queste situazioni. Dove vanno ora i nostri anziani o pensionati nei nebbiosi e freddi pomeriggi invernali o nelle lunghe giornate estive, ora che le bocciofile sono diminuite e i circoli sono quasi tutti scomparsi, dove vanno a fare una partita a scopa o scambiare quattro parole con i vecchi amici o ex colleghi? In paese sono rimasti forse due a tre di questi luoghi, qualche posto nei piccoli centri della prima collina ma per il resto nulla. Li vediamo vagare nella galleria del centro commerciale, sedersi sulla panchine davanti alle casse nella speranza di vedere un vecchio amico o anche solo un conoscente, tenendo d’occhio la distanza con i bagni (la prostata sollecita), orfani di quei calicetti, di quei pomeriggi a chiacchierare con l’amico di sempre, aspettando l’ora della chiusura, della cena, del tramonto o del momento di andare a riposare. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
IL MARE D’INVERNO Ma poi viene l’estate Il mare d’inverno è come un film in bianco e nero visto alla tv, uno scenario triste, le giornate uggiose di mare sono lente e lunghe, macaia dice Paolo Conte ma lo spiega meglio Fabrizio De André "Genova apriva le sue labbra scure / al soffio caldo della macaia" ovvero quando il vento caldo e umido dello scirocco alza si la temperatura, ma anche il tasso di umidità e solo il mare di Liguria d’inverno può darvi queste emozioni e queste sensazioni. Avete mai avuto occasione di passeggiare lungo una spiaggia d’inverno? Quelle spiagge non sabbiose ma con il ghiaietto fine fine, sassi e sassolini dove il mare si insinua, l’onda fa la schiumetta facendo tintinnare l’acqua che defluendo tintinna come mille campanellini. Infiniti sassolini neri e bianchi che si appiccicano alle mani portandoti il mare tra le dita. Ma la cosa che colpisce di più i nostri sensi è il profumo, un profumo di salino, di pesce, il sapore del sale sulle labbra (Gino Paoli), polvere d’acqua e il vento che appiccica il mare sul viso. Nuvolaglia all’orizzonte, vento dispettoso di maestrale o caldo d’Africa che ti fa sognare spiagge lontane. Avrei voglia di tornare sulle spiagge liguri d’inverno, dove ho passato parecchi anni da ragazzo per sentire ancora il rumore del mare tra i sassi della spiaggia ed il profumo intenso del marino. “Sinquanta franchi de fügassa sensa siolle” era il rito del mattino prima di entrare a scuola, ma la cipolla no, quella alle 10 del mattino restava affezionata,”la rampiga”. La focaccia alla genovese, in dialetto “a fügassa”, è una specialità tipica della cucina ligure e la tradizione della sua antica preparazione è cosi radicata nei genovesi che ha fatto diventare questo prodotto un presidio slow food. E' famosa in tutto il mondo anche se è praticamente impossibile ricreare la sua fragranza e la sua bontà al di fuori del capoluogo ligure. Consapevoli che per gustare la vera focaccia bisogna recarsi sul luogo d'origine, alta mediamente due centimetri come da tradizione, croccante e allo stesso tempo morbida e friabile, lucida d'olio e per nulla gommosa, deve ungere la carta e deve profumare, le panetterie liguri alla mattina sono pregne di questi odori/profumi, profumi che si intrufolano nei caruggi che scendono verso il mare. Della sardenaira ve ne ho già parlato nello scorso racconto su Sanremo, mentre la focaccia, da non confondere con quella di Recco che è un’altra cosa, è il massimo della genovesità. Lunga lievitazione, olio extravergine autoctono, sale grosso e i famosi buchi che i panettiere deve fare con le dita prima di metterla nel forno. Teglie nere sul banco bianco di farina, ancora calda, vera poesia per gli occhi e per naso e palato. Un buon vino bianco fresco, in questo caso preferisco il Pigato,parente stretto del Vermentino, colore paglierino, sapido in bocca, proprio come la focaccia, al naso profumi di macchia mediterranea, erbe officinali, rosmarino e origano. Per la focaccia è meglio abbinare quello giovane, se invecchiato trova ospitalità con piatti di pesce più impegnativi. Vicoli stretti, lenzuola stese appena mosse dalla brezza, in alto tra le case spunta una fetta di cielo azzurro e in basso lo sciabordio lontano del mare: dimenticate la macaia ora viene l’estate!! Cercate di essere felici e ricordate che la vita è troppo breve per bere vini mediocri. GiuBa.
LA BICI AZZURA Non trovo più una vecchia foto che mi ritraeva in sella di una biciclettina celeste mentre mi aggrappavo ad un ramo di un vaso di oleandro. Era una bici Gloria su misura, una bici da uomo ma in piccolo. Avrò avuto una decina d’anni. Avevo un cardigan multicolore, allora lo chiamavano l’americana, un golf insomma e le scarpe di camoscio grigie che mi aveva fatto mio zio Sandro che aveva una piccola fabbrica di scarpe a Voghera. Le scarpe erano il regalo per la mia prima comunione, erano un po’ abbondanti, mi sarebbero durate parecchio. Avevo una bella faccia felice: la bici azzurra, le scarpe di camoscio e il cardigan. Mi è arrivato via WhatsApp un filmatino dove mia nipote Cecilia, la più piccola delle due, si esibisce in una gara di pattinaggio artistico su rotelle e vince il primo premio, anche lei, salita sul podio, ha una bella faccia felice. A volte ripenso se ho avuto anch’io una infanzia felice, se lo hanno avuta i miei figli, se la avranno i miei nipoti e i nipoti dei miei nipoti. Io l’ho avuta, penso anche i miei figli e dalla faccia di Cecilia con la coppa in mano anche i mie nipoti. Resto legato a vecchi archetipi quelli della filosofia dello scautismo, un vecchio amico casteggiano mi ripete che sono l’ultimo boy scout. Non è vero, ce ne sono molti altri e certamente migliori di me, ma mi piace sentirmelo dire. Provate a chiedervi e a chiedere se avete avuto una infanzia e fanciullezza felice, se la hanno avuta anche i vostri figli/nipoti. E’ importante e se si, significa che non avrete vissuto invano. Ecco cosa scriveva B.P. nell’ultima lettera agli scout: Ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. Preoccupatevi di lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo avete trovato. Lord Baden Powel of Gilwel. Ecco tutto questo è scaturito da una foto non trovata, ma che era chiara ed impressa nella mia mente tant’è che mi ricordo ogni minimo particolare, scarpe comprese. Non voglio tediarvi ancora, ma una altra frase di B.P. scritta sul suo diario mi è rimasta nella mente, è piena di significati e nemmeno tanto reconditi: Da una finestra del piano superiore giunge il gaio chiacchiericcio dei ragazzi che vanno a letto. Domani verrà il loro giorno. E possa essere così felice come lo è stato il mio, e che Dio li benedica! Quanto a me, sarà presto l'ora di andare a riposare. Perciò BUONA NOTTE! Sempre per bontà vostra GIU.BA.
AL MENO L'ITAGLIANO SALLO!!!: Alla terza volta che uno dei maggiori autori di musica leggera italiani, quello con il ciuffo bianco per intenderci, durante una intervista televisiva disse “ A me mi piace” mi risvegliai dal torpore post prandiale della domenica pomeriggio novembrina ed iniziai ad urlare correndo per casa. Oppure, sempre in un talk show televisivo qualcuno disse “Abbiamo atterrato”…. abbiamo????? Così come non è possibile che una persona che ha frequentato le più prestigiose università mondiali, suppongo con scarsi risultati, come tale Lapo Elkan, quando parla riesce a far rivoltare nella tomba contemporaneamente tutti i padri della lingua italiana da Dante e Carducci in poi, senza dimenticare che suo padre è un raffinato giornalista e scrittore, si vede che si sono frequentati poco. In un manifesto in un centro commerciale l’annuncio di un prossimo evento sembrava un discorso di Di Pietro, il quale, a dir la verità, ultimamente è anche migliorato, ma abbiamo conosciuto momenti di alta scuola sgrammaticale da parte dell’ ex Ministro. Il mio amico Paolo Pulina un giorno mi fece un complimento che, per ciò che mi riguarda, ho considerato molto lusinghiero “ Sei uno dei pochi che sa mettere i congiuntivi al posto giusto” mi auguro non si sia sbagliato blandendomi in tale maniera; in compenso Don Ernesto Vercesi, mio indimenticato maestro di giornalismo (Il Popolo di Tortona), mi redarguiva chiamandomi semplicemente analfabeta. Eppure a volte tremo mentre scrivo, all’idea di sbagliare non solo i congiuntivi ma la sintassi e perché no anche la grammatica quella più elementare. A questo scopo cerco di tenere sotto mano dei libri scolastici di grammatica italiana, quello dei sinonimi e contrari – ne ho uno addirittura con la prefazione dell’indimenticabile Prof. Alessandro Cutolo (per alcuni uno sconosciuto) – e un Vocabolario Zingarelli e se, nelle mie peregrinazioni librarie, trovo un libro di grammatica, anche la più elementare come dicevo prima, che stuzzica la mia curiosità, lo compro. Ho avuto, durante la mia carriera scolastica, la fortuna di trovare insegnanti di italiano di buon, alto e altissimo livello, come posso dimenticarmi della Professoressa Saragoni a Voghera con lo studio dei classici a memoria: Omero, Virgilio, Dante (i suoi avevano un famoso mobilificio), oppure la Professoressa Campanella di Genova grande cultrice di etimologia – studio dell’origine delle parole - e un altro Professore, di cui haimé ho dimenticato il nome, giornalista al Secolo XIX° sempre di Genova, ed è proprio grazie a questi personaggi se oggi posso affrontare un foglio bianco nella speranza di fare il meno errori possibili. Continuo a temere sempre comunque e per fortuna, il giudizio dei lettori. Il titolo di questo pezzo, ovviamente ironico, l’ho copiato da Facebook che è una grande palestra di sgrammatica italiana, provare per credere. Statemi bene brava gente. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
QUELLI CHE..........un conto è farsi eleggere, ma poi bisogna amministrare/governare. Cetto la Qualunque docet.
QUELLI CHE............
I pedoni che attraversano gli incroci in diagonale
😥
Quelli che ......erano solo chiacchiere e distintivo, poi gli hanno tolto il distintivo e sono rimaste solo le chiacchiere😋
La libertà, Sancio, è uno dei doni più preziosi che ha dato agli uomini il cielo, non può essere identificata con i tesori della terra e del mare: per la libertà e per l'onore, si può e si deve rischiare la propria vita. " Miguel de Cervantes Saavedra. Questa iscrizione si trova sulla facciata dell'Università di Salamanca nel IV° centenario della pubblicazione del Don Chisciotte de la Mancha, sembra scritta oggi o al massimo ieri. Buon anno!!!! Sempre per bontà vostra GIU.BA.
VESTIVAMO ALLA MARINARA Non erano solo gli Agnelli, quelli con la A maiuscola, che vestivano alla marinara, anch’io e se non ricordo male, anche mio zio, il fratello di mio padre, che vestivamo alla marinara. Per necessità familiari, quando ero bambino ho vissuto molto a Genova precisamente a Sestri Ponente. Abitavo a casa di una mia zia, la sorella di mia nonna, che in quegli anni accudiva anche un fratello di mio papà(un terzo) che viveva con lei. Un’ anno mi presi la scarlattina e per quaranta giorni fui prigioniero in casa. Alla fine di questa noiosissima quarantena, finalmente potei tornare in strada a giocare con gli altri bambini (vedi ”un uomo solo al comando”). Ma la zia per compensarmi di quel forzato esilio decise di premiarmi fornendomi di un vestito nuovo, molto elegante, un vestito da marinaretto. Blu, era blu con tutte le passamanerie bianche, pantaloncini corti, casacca con grande colletto e al posto delle stellette due stelle marine bianche. Quella era la divisa che molti bambini usavano anche per ricevere la Prima Comunione o la Cresima. Era normale, il vestito buono, primavera/estate, si metteva alla festa, per andare a messa. Tornato a Voghera una domenica mattina i miei decisero che dovevo/potevo andare a messa a San Rocco da solo, dovevo solo attraversare i giardini di fronte alla Caserma, dove loro gestivano lo spaccio per i militari, quindi pochi pericoli, ce ne erano pochi di pericoli allora, veramente pochi. Quindi una volta indossato il mio vestitino da marinaretto, mi sono recato alla messa dei bambini alle 9,30. Settore di sinistra, prime file, tutti insieme e un giovane curato a sorvegliarci. Nella mia mente sorsero spontanee delle domande, quanto dura la messa, in piedi, seduti, in ginocchio, ma il giovane curato che ci “curava” tolse ogni dubbio, dava lui gli ordini. Io però ero intimorito e non vedevo l’ora di tornarmene a casa ed infatti ogni qual volta il celebrante si volgeva all’assemblea e pronunciava “Oremus” io cercavo di guadagnare l’uscita ma venivo prontamente placcato dal giovane curato che mi brancava per il collettone della giubba marinaresca e mi rimetteva a sedere. Quel giovane curato era Don Ernesto Vercesi che sarebbe poi diventato assistente degli scaut, parroco a Santa Giuletta e infine Capo Redattore del Popolo dell’Oltrepo’ giornale per il quale collaborai per quasi 15 anni e mi dette la possibilità di iscrivermi all’Ordine, una persona importante nella mia adolescenza e maturità. Eravamo partiti da una vestito da marinaretto e vi ho raccontato una parte della mia infanzia. Sempre per bontà vostra Giuliano Balestrero
I LUOGHI DELL’ANIMA: Dice Paolo Conte, poeta e gran cerimoniere delle emozioni del cuore, “come le vecchie drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera” (Boogie) così quando passo davanti ad una drogheria, cerco di aspirare i profumi che escono da essa e farne scorta. Sono sempre profumi intensi anche se oramai sono attenuati, tutto è imballato, costretto in astucci e scatolette, bottiglie e bustine, ma ricordo a Voghera sotto i portici dell’Duomo, c’erano due drogherie (una esiste e sopravvive ancora) passando davanti alle quali si sentivano effluvi di profumi di cannella, noce moscata, zafferano e chiodi di garofano, funghi secchi e aringhe affumicate, mille argentei raggi del cerchio del barile, oggi come allora quando passo davanti mi immergo, vado in apnea, inspiro e trattengo dentro di me quei profumi il più possibile come facevo da ragazzo. Sono i luoghi dell’anima,quei piccoli spazi dove a volte hai la sensazione o la pretesa che la coscienza riposi. Mi ricordo la pianta di pere all’inizio del villaggio, il tramonto rosso e la pianura lontana, oppure la piazza di Navarrete in Rioja in Spagna, in una mattina oramai assolata e caldissima, e questo angolo della piccola città dove era bello farsi passare il tempo addosso sotto il fresco delle piante, con una fontanella che zampillava e una voce che in italiano chiedeva “Cosa posso portarle….”. Ma i luoghi dell’anima sono anche qui da noi,come le notti magiche con la neve che scende in piazza in un silenzio surreale, niente macchine, niente rumore, solo la neve che scende copiosa sulle spalle di Giuditta e Oloferne immobili e stupiti con la spada immota per sempre e le luci gialle dei lampioni, dove anche i peccatori si fermano e aspettano. E’ un posto nella valle, in cima ad una montagna, sul Lesima a guardare la valle del Borecca, i boschi e le montagne. Ecco i posti dell’anima, trovati i quali si ha la necessità di fermarsi e respirare, ora va di moda dire “staccare la spina” o “resettare la memoria”, tirare il fiato, respirare profondamente e chiudere gli occhi mentre si sente solo il rumore del vento fra gli arbusti e il rumore e di un trattore lontano come il palpitare di un cuore. Vi saluto brava gente Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
Viottolo dei Pellegrini. Casteggio ha da sempre avuto una tradizione nella ospitalità ai pellegrini in transito, trovandosi tanto sulla Via Francigena quella che segue il tragitto a sud del Po, come sulla via che scendendo dai paesi dell’Europa Centrale Mitteleuropei, via Postumia, si dirigevano verso la Liguria per poi seguire il Cammino della Costa che li avrebbe portati in terra Spagnola e quindi in Galizia per arrivare a Santiago de Compostela. Nei vari testi da me consultati si faceva riferimento ad un Viottolo dei Pellegrini che dalla zona del cosiddetto Pozzo Bianco raggiungeva la Chiesa di San Sebastiano ove si trovava un rifugio o ospitale destinato proprio ai pellegrini in transito. Ai giorni nostri l’unico rifugio della zona si troverebbe a Redavalle, uno Xenodoquio, appunto un rifugio per i pellegrini che ancora nei nostri giorni sono in viaggio per raggiungere Roma e a volte anche Gerusalemme. A proposito di questa tradizione di ospitalità ecco cosa scrive Carlo Giulietti nella sua pubblicazione:” Casteggio Notizie storiche”. Carlo Giulietti dottore in legge appassionato cultore del territorio e meno noto del nipote Giuseppe Maria Giulietti esploratore trucidato in Dankalia (Etiopia). ………..omissis……………… Nei locali annessi alla Chiesa vi era un ricovero dei pellegrini che ora serve da alloggio al Cappellano. Si è perciò, che il viottolo tra la casa Venco, e la chiesa si diede il nome di viottolo dei pellegrini. I pellegrini un tempo godevano maggior stima di quelli che tuttora viaggiano sotto tale nome. A Voghera nel 986 morì San Bovo, guerriero provenzale di ritorno da Roma come pellegrino. Quivi pure venne nel 1469 riconusciuto il corpo di San Rocco, morto nel 1327. ………………………………………..omissis……………………………………………. Molti dei pellegrini andavano a Gerusalemme, altri andavano al Santuario di S.Giacomo di Campostella nella Galizia spagnuola. Da noi dicesi tuttora e frequentemente “va in Galizia” per dire “va lontano” ricordo del tempo dei pellegrini. Secondo i documenti della confraternita, di pellegrini ve ne erano di tre classi: cioè religiosi, laici confratelli, o aggregati a qualche confraternita, e pellegrini semplici. L’obbligo della ospitazione dei pellegrini venne nei primi tempi del Cristianesimo dato ai Vescovi, che fecero applicare ai pii luoghi la denominazione di ospedali e nei Catechismi fecero riconoscere l’obbligo anche negli altri di alloggiare pellegrini e i fuggiaschi dalle persecuzioni. L’alloggiare pellegrini è infatti una delle opere di misericordia raccomandate. ………………omissis ……………..Le stazioni romane per quelle vie (che andavano a Roma n.d.r.) diventarono allora “Xenodochia” ovvero ospizi pei pellegrini. Carlo Magno nel 802 ordina che nessuno possa negare ai pellegrini l’ospitalità. Lotario II° ordina ai messi regi di restaurare gli ospizi tanto sui monti che altrove…………In questa foto, di Alessandra Consonni, si intravede questo viottolo fra la casa e la Chiesa di San Sebastiano al Pistornile. Cosa significa Pistornile?? Questa è un'altra storia. Sempre per bontà vostra GIU.BA.
L'ULTIMO DEI MOHICANI Se vi hanno insegnato a salutare quando entravate in un ambiente, togliendovi cappello e occhiali da sole, se non vi siete mai seduti a tavola con il cappello in testa, se vi hanno insegnato a dare del lei agli adulti come forma di rispetto, se vi hanno detto che negli autobus il posto si lasciava alle donne incinte e a quelli più grandi di voi, se vi hanno insegnato che i beni comuni vanno rispettati più dei propri, se vi hanno insegnato che l'onesta' è un valore e non un difetto, se vi hanno insegnato che il rispetto mostrato è rispetto guadagnato. se siete cresciuti con il cibo fatto in casa, se avete giocato per strada per ore, se non avevate i vestitini firmati, ma mettevate quelli dei fratelli/cugini maggiori, se la vostra casa non era a prova di bambino, e vi punivano se vi comportavate male, se non siete stati da uno psicologo e uno scappellotto ogni tanto l'avete preso; se avete avuto una TV in bianco e nero e per cambiare canale dovevate alzarvi, se la domenica i negozi erano chiusi e si andava prima a catechismo e poi al cinema dell’oratorio, se avete bevuto l' acqua del rubinetto. se non conoscevate l'inglese a sei anni e non avevate il telefonino a 9 ma sapevate bene cos'era l'educazione..., se siete sopravvissuti a tutto questo vuol dire che siete di una generazione paragonabile ai panda, in via di estinzione…….!!! Io sono un sopravvissuto di un mondo di valori e regole ormai scomparsi.....ecco mi sento come uno degli ultimi dei mohicani. Sempre per bontà vostra.Giuliano Balestrero.
POCA PAPPA: Una mia nonna pare dicesse che per vivere a lungo bisognava seguire la regola delle p, ovvero: poca pappa, poca pipa (nel senso di tabacco) e poca “peppa” vi lascio capire cosa intendesse. Potrebbe starmi bene, la poca pappa, è meglio trattenersi e non strafare a tavola, a un amico che era aumentato di peso in maniera esponenziale, diventando di fatto obeso, avevo chiesto se si trattasse di disfunzione ghiandolare e lui mi ha risposto “ma quale ghiandolare, disfunzione mandibolare”. Ora non dico di diventare asceti digiunatori, masticatori di pallido finocchio lesso e solitarie carote, ogni tanto una fetta di salame o una manciata di graton appena sfornati ce la si può permettere, ma fare merenda con gli amici tutti i pomeriggi con pancetta e bonarda temo sia controproducente. Quindi questo consiglio della nonna potrebbe anche essere d’aiuto per una lunga vita. Dopo viene la pipa, ovvero il tabacco, embhé è inutile che ribadisca che il troppo fumo fa male, io con tutta sincerità fumo una o due sigarette, solo alla sera e dopo cena, mi sembra di chiudere la giornata con un gesto rilassante anche se in realtà più che fumare faccio del fumo. Una volta ad una visita medica mi chiesero se fumavo e quanto e da quando, e io risposi sinceramente: si, dal 1964, due massimo tre sigarette ma solo se gioca la nazionale o la mia squadra del cuore, il medico che leggeva il questionario mi guardò da sopra gli occhiali e con un pennarello nero tirò una riga sulle mie risposte. Proseguendo poi nell’elenco delle tre “p”, ma non quelle di Voghera – pazzi peperoni e puttane - anche se qualcosa avrei da dire anche qui, siamo arrivati alla “peppa”, se ci tolgono o restringono pappa e pipa, ci si lasci almeno la peppa, capisco che io potrei considerarmi fuori gioco ma insomma di qualcosa dovremo pur morire, non si può vivere da malati per morire sani. Nei paesi sudamericani di lingua spagnola la peppa la chiamano concha e fin qui niente di male ma mi lasciano perplesso quelli che chiamano le figlie Conchita, come la nota ex direttrice di un quotidiano italiano, noi però non conoscendone il significato recondito non ci abbiamo fatto caso, certo è che sarebbe imbarazzante chiamare la signora con un “buongiorno fighetta”. Oscar Wilde, che probabilmente condivideva le opinioni di mia nonna, amava ripetere:” la posizione è ridicola, la fatica è improba e il piacere alla fine dura pochi attimi, tenetevela dunque la vostra orrida fessura”, è anche utile ricordare che Oscar Wilde era omosessuale. E Lord Chesterfield aggiungeva: “e la spesa è eccessiva”. Sempre per bontà vostra GIUBA
QUELLI CHE...... Oggi dedico il mio "quelli che" a questo signore che si chiama Jack Ma ed è l'inventore, se così si può chiamare, di Alibaba il più grande sito di vendite on line della Cina, simile ad Amazon per intenderci, è l'uomo più ricco della Cina, ma recentemente ha stupito il mondo con una sua dichiarazione che dovrebbe farci riflettere :" Il tempo vale più del denaro, preferisco morire su di una spiaggia che in ufficio". Mi ricordo un altro episodio che mi capitò molti anni fa, dovevo consegnare al Rettore emerito Ezio Franceschini una pratica che esigeva una sua firma e mi permisi di dire "E' urgente professore" e lui serafico mi rispose " Si ricordi che urgente è salvarsi l'anima". Abbiamo un po' di tempo per salvare l'anima, o pesiamo solo a salvare il denaro. Lui, Jack Ma se lo può permettere, e noi???? Io non vorrei essere il più ricco del cimitero. Non abbiamo il tempo di essere noi stessi. Abbiamo solo il tempo di essere felici. (Albert Camus) Sempre per bontà vostra GIU.BA.
LA LEZIONE DEL PROF. MIGLIO Mi piaceva seguire le lezioni del Prof. Gianfranco Miglio, quando potevo andavo in aula e mi sedevo defilato, in fondo affinché non mi vedesse. Mi piaceva anche seguire le sue conversazioni nel ridotto del bar dei professori quando riuniva una ristretta schiera di allievi e assistenti e faceva una disanima della situazione politica italiana, soprattutto il giorno dopo le elezioni politiche. Grazie a lui ho scoperto libri come “La disobbedienza civile” di Henry David Thoreau o il famoso suo scritto “L’asino di Buridano”. Il professore aveva un vezzo: beveva solo Amaro Braulio caldo d’inverno e con un cubetto di ghiaccio d’estate. Se lo faceva servire in un bicchiere stretto e alto e mentre parlava girava il liquido con un lungo cucchiaio. Lunghi pomeriggi nei brumosi inverni milanesi, nebbia e freddo umido, buio alle 4 del pomeriggio con le luci dei negozi che facevano un alone arancione nella nebbia, lui si presentava con il cappotto con il collo di astrakan e colbacco identico al colletto. Un altro vezzo del professore erano le cialde di cioccolato fondente con ripieno di menta fondant, After Height, ne comprava interi astucci di quelle bustine verdi. All’approssimarsi della stagione calda mi chiedeva se potevamo procurargliene alcune scatole da mettere in freezer e poterle assaggiare anche in piena estate. Non sto a raccontare ciò che accadde quando fu eletto senatore nelle file della Lega Lombarda (allora), diventando l’ideologo di quel partito, ma entrò in rotta di collisione con Umberto Bossi. Certamente aveva suscitato in me simpatie, pur tiepide, verso quella compagine politica. Fu poi estromesso dalla Lega, allontanato e la storia ci dirà quali furono i veri motivi. Da parte mia cominciai a defilarmi da quel panorama politico restando ai margini e ascoltando. Poi una mattina seguendo un talk show al quale partecipavano politici di tutti gli schieramenti presso una televisione commerciale, sentii un Carneade qualunque, ovviamente un sodale del partito di cui sopra, che faceva dell’ironia sul professore, alludendo a eventuali malattie mentali legate alla vecchiaia, a quel punto capii che era giunto il momento di prendere le distanze da questi personaggi. Era come se io, che in fisica avevo dal 5 al 6, avessi fatto della ironia su Einstein e sul principio della relatività e delle onde gravitazionali. Personaggi che non hanno titolo ne accademico ne professionale che di volta in volta diventano economisti, politologi, teologi, psichiatri, virologi contemporaneamente, tutt’insieme, sanno tutto, conoscono tutto lo scibile umano. Non vado avanti, non vorrei trovarmi a Ventotene, mi resta comunque il ricordo di quelle ore, a volte rubate al rientro a casa, per seguire le lezioni del Prof. Miglio. Sempre per bontà vostra G.B.
LA PANDA BIANCA Quando aprono lo sportello posteriore e mostrano il loro mondo segreto, diventano quasi gelosi nel rivelare a tutti ciò che contiene il baule della loro macchina. E’ una esplosione di oggetti, di odori, di storie, nella loro Panda bianca c’è di tutto: una roncola “al püdaroe”, una corda , due stivali, uno scarpone spaiato, una cassetta piena di bottiglie di plastica vuote, il cappello di paglia giallo della “RAGGIODISOLE”, un must(*) nell’abbigliamento contadino. Qualche volta c’è un cane nero che ti guarda con la stessa sufficienza con cui ti guarda la moglie, che di solito non scende dalla macchina, ma sta seduta al suo posto aggrappata alla maniglia del passeggero e a quella della borsetta che tiene sulle ginocchia, inamovibile, mentre viene caricato il mangime per i conigli. Ma se sulla Panda c’è una moglie allora la vettura è anche tenuta quasi bene, ma quelle mi interessano meno, mi incuriosiscono invece le Panda solitarie, quelle vissute, con lo sportello posteriore che per essere tenuto aperto necessita di un bastone o un manico di scopa e non è raro che toccandolo lo sportello vi cada sulla testa. Solo due posti, quelli anteriori, i sedili posteriori, ribaltati, sono affogati sotto ad ogni ben di Dio. A volte il sacco dello stallatico si è rotto e con l’umidità si è sciolto liberando nell’aria l’odore acre del letame e non c’è arbre magic al mango che tenga. Hanno qualche macchia di ruggine e la vernice della carrozzeria ha conosciuto tempi migliori, perenni baffi di fango sulle fiancate, le partenze o gli arrivi sono sempre accompagnati da uno straziante urlo del cambio che, non volendo essere sottomesso dalla frizione, raggiunge esasperati acuti di giri motore. Le vedi arrancare in mezzo alle vigne o per i sentieri dei boschi del nostro Oltrepo’ nella stagione dei funghi, sono le compagne di avventura di cacciatori e cercatori. Assieme alle oramai rarissime e mitiche R4, terminano poi la carriera dietro il portico adibite a estemporaneo pollaio o cuccia per il cane, quello nero che non ha mai abbandonato il suo posto nel baule. Sono le compagne di viaggio dei nostri vecchi agricoltori, quelli con le mani callose e intorcinate dai reumatismi per i troppi giorni passati a legare tralci o a potare a mani nude, nella nebbia del mattino, nelle ventose giornate di aprile e con i piedi nell’ultima neve di primavera, quelli con la schiena spezzata dai troppi sacchi e sporte di uva sollevate. Fanno tenerezza entrambi autista e macchina amalgamati assieme, diventati oramai un sol corpo, se fosse possibile penso si farebbero seppellire li dentro per poter correre in eterno nelle verdi praterie del cielo eternamente in lotta fra frizione, cambio e acceleratore e il solito cagnone nero che ti guarda con sussiego come dire “cos’hai da guardare!!??”. (*)Cosa significa must!! nel linguaggio. mondano, tutto ciò che si deve assolutamente fare, indossare, vedere, comprare per essere alla moda.
Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
UN UOMO SOLO AL COMANDO……… Alle cinque di un pomeriggio di giugno Alberto Parodi detto U Bertin figlio di Giovan Battista Parodi detto U Bacicin ma anche Giobatta, scendeva in strada in Via Caterina Rossi a Sestri Ponente. In una mano aveva un grosso pezzo di gesso recuperato in un cantiere edile e nell’altra alcuni tappi a corona di bibita. Appoggiava il mucchietto di tappi a corona sul marciapiede e con il pezzo di gesso iniziava a ripercorrere la lunga riga bianca fatta precedentemente, forse addirittura da mesi, per rinfrescare i bordi di quella che sarebbe diventata da li a poco una pista da corsa per “ciapétti” o come si chiamavano qui da noi “birini” appunto tappi da birra. La lunga teoria di palazzoni popolari che formano Via Caterina Rossi, filantropa genovese che aveva costruito quella lunga teoria di case (esistono ancora),dietro le persiane, quelle con la ribaltina ed il ferretto per tenerle socchiuse, occhi curiosi scrutavano il lavoro di U Bertin, mano a mano che il lavoro di ripristino terminava, dalle scale dei palazzi scendevano a frotte alcuni ragazzini, alcuni con attrezzatura propria, altri condividevano i “ciapètti” che la comunità distribuiva. La strada è lunga circa duecento metri, la pista, che la occupava per buona parte della sua lunghezza, più curve e tornanti, era sicuramente lunga almeno cento metri, ci potevano giocare venticinque corridori. I “birini”, alcuni dei quali mostravano all’interno della corona le foto di noti corridori ciclisti ritagliate dai giornali, venivano posizionati sulla larga linea di partenza e ad un segnale del capo popolo, U Bertin, via si partiva. Si cominciano a scagliare i birini, pollice ed indice scattano, i birini pure, chi esce dalle righe deve fermarsi per un turno, la masnada di fanciulli urlanti riempie la strada e l’aria è piena delle loro grida, U Bertin è ovviamente in testa,d’altro canto lui è il migliore, all’interno del suo birino c’è la foto di Coppi, calibra i colpi fa le curve senza uscire dal tracciato ed in breve è solo al comando mentre alle sue spalle la lotta si fa dura. Mani e ginocchia hanno oramai il colore dell’asfalto, qualche spintone, ma tutto è contenuto nella normale vivacità dei ragazzini. Il tempo passa e il sole tramonta, dalle finestre le mamme cominciano a chiamare per la cena e dopo poco la strada torna ad essere deserta. Oggi in Via Caterina Rossi le macchine sono parcheggiate su entrambi i lati e la carreggiata è sempre più stretta, non ci sono più i ragazzini a giocare ma solo automobili che passano. A mia nipote hanno regalato una bambola con i pattini a motore elettrico radiocomandati, ma lei preferisce disegnare mare e sirene “E’ la storia di Ulisse, nonno, tu la conosci?” mentre la bambola con i pattini è tristemente abbandonata in un angolo. U Bertin in dirittura d’arrivo gridava “Un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco celeste il suo nome è Fausto Coppi…..primooooo!!”Quanto costa la felicità? Un coperchietto di metallo, un tappo a corona con la foto di Coppi. Sempre per bontà vostra.GIU.BA.
Che cosa posso dirvi? Andate e fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate! Francesco Guccini "L'avvelenata"
PERCHE’ SANREMO E’ SANREMO. Il 6 di gennaio di tutti gli anni, questo fino alla fine dello scorso decennio di questo secolo, appena passate le feste e non ancora digerito l’ultima fetta di panettone, la mia mamma faceva le valigie e si partiva per Sanremo, dove avevamo in uso una bellissima casa sulle prime colline di San Martino, una frazione appunto di Sanremo. Io la lasciavo li, tra l’altro circondata da vicini cordialissimi: un maestro di musica, concertista violinista, che aveva girato il mondo con grandi orchestre sinfoniche e la moglie, una signora simpaticissima, stravagante al limite della bizzarria, ma che facevano buona compagnia alla mamma, e rientravo a casa il giorno successivo. Fin qui tutto normale, la cosa che invece mi lasciava molto perplesso era il giorno in cui dovevo andarla a prendere per riportarla nella nebbiosa padania. Secondo voi in che giorno cadeva la data del “ritiro” della mia mamma? Ebbene si….l’ultimo giorno del Festival di Sanremo, che in quegli anni cadeva all’incirca attorno alla seconda o addirittura terza settimana di febbraio. A volte al telefono avevamo avuto anche delle discussioni su questa data; ma perché non la settimana prima o quella dopo. No!!! per motivi che a tutt’oggi mi sfuggono, quella era la data del rientro e quella doveva essere, punto. Facendo buon viso a cattivo gioco, il sabato mattina di buon ora partivo per la riviera dei fiori accompagnato dai risolini ironici di mia moglie e di mia sorella: ti ci vorrebbe un furgone, un autoarticolato ecc.ecc. ben sapendo che cosa mi stava aspettando in fatto di merce varia, preparata in una miriade di borse pacchi, secchielli, vasi eccetera, che dovevano essere caricati in macchina, riempiendo ogni dove. Una volta tornai da Sanremo con una piantina di ulivo sistemata tra i piedi materni, davanti al sedile anteriore del passeggero, viaggiando da Sanremo a Voghera in quella maniera. Ovviamente appena arrivato a Sanremo mi rendevo conto del caos magno che regnava in città, macchine in ogni dove, parcheggi esauriti con fuori la lingua, gente impazzita che andava e veniva come gli storni d’autunno appena si spargeva la voce che questo o quel personaggio era nei paraggi, pullman regia di reti televisive, di radio pubbliche e commerciali, una marmellata di voci, di suoni e di odori. E in tutto questo caos, io inseguivo mia mamma che correva da questo al quel negozio per le ultime compere. Al sabato c’è anche il mercato, è una cosa straordinaria, bello grande, multicolore, pieno di turisti soprattutto francesi che arrivano per fare gli acquisti e devo dire che è veramente un bellissimo mercato da visitare almeno una volta, e tutto questo mentre io ero in giro rincorrendo la mamma che mi caricava di tutto: carciofi, acciughe e sardine, piantine di basilico, arance, fiori e quant’altro. C’e una cosa però di cui ho un ottimo ricordo: un metro quadro di sardenà, ovvero una focaccia tipica di Sanremo che con i suoi profumi inondava il famoso “budello” ovvero quella strada stretta piena di negozietti e caruggi, tipico delle città della riviera ligure (famoso è quello di Alassio). Ma cos’è la sardenà o sardenaira? La buonissima Sardenaira, è una golosissima specialità che si prepara solo li. E’ una focaccia dai bordi alti e pasta soffice condita con un sugo delizioso a base di pomodoro, aglio, olive taggiasche ed acciughe. Questo lievitato (non chiamatela pizza altrimenti i sanremesi si arrabbiano subito) è conosciuto solo nel ponente ligure, in particolare a Sanremo e nei comuni limitrofi. E’ un piatto legato alla storia e alla tradizione del suo territorio. Il nome Sardenaira (o Sardenara), io la scrivo come si dice in dialetto sanremese, deriva dal fatto che, inizialmente, veniva condita con sarde, un pesce povero ma gustoso. Solo nel dopoguerra, con l’arrivo del benessere, le sarde sono state sostituite con le acciughe sotto sale. A Sanremo si fa spessa anche 5 centimetri. A me piace un po’ più sottile ma resta comunque soffice e più alta della tradizionale pizza al taglio (circa 2 centimetri). Il metro quadrato di sardenà, confezionata in un grande vassoio di cartone, veniva stipato anch’esso in macchina e finalmente si partiva alla volta della pianura padana con tutto quel ben di Dio sopra. Raccomandazione: se vi capita di andare a Sanremo, possibilmente non durante il Festival, andate nel budello a cercare questi negozietti dove fanno questa particolare focaccia, fatevene dare una bella porzione, poi andate verso il mare, in qualche barettino dove potete sedervi e mangiate la vostra sardenà, cosi avrete il mare in bocca, davanti agli occhi e il suo profumo nelle narici. Un buon vino da accompagnare??? Io lo preferisco giovane e beverino, un riesling dell’OLtrepo’ o addirittura una pinot nero spumante classico,fresco, estivo, da bere sotto una pergola sulla prima collina vista mare con i refoli di vento che muovano appena appena le foglie, in perfetto silenzio però. Prosit. Sempre per bontà vostra. Giuliano Balestrero
QUELLI CHE...............
Pra ades grasie dop as metuma a post.........e non li vedi mai più
Ma allora è telepatia, stavo proprio per telefonarti..........e a telefonata conclusa
" ma và a ciapà di rat ti e la telepatia"
Se il lunedì mattina non hai voglia di cominciare a lavorare vuol dire che sei una persona normale!!!
A var pusè un andà che cent anduma!!!!!!
Forsa fieu ca vegna sira e ghe ancura tutt da fà..........
"Si... quando torno dalle vacanze vedo di pagarle qualche fattura, quelle più vecchie"
Si dichiarano animalisti, ambientalisti, pacifisti, contro la caccia, contro le armi ecc.ecc.
e poi girano con la giacca della mimetica militare...... mimetica........camouffage dicono, di moda.
Si dichiarano vegani poi alla bisogna: "una fetta di salame, se buono ogni tanto........"
ma andé a ciapà di rat.
E il coccodrillo????????
Elegia al pisseur Li vedi lungo l’autostrada, sotto i cavalcavia, mentre espletano con la fontanella che, attraversata dai raggi del sole, forma uno zampillo dorato; e loro sono li impassibili e doviziosi come bronzi di Riace a bagnare i guard-rail incuranti di chi passa, lasciando libero il rene di espellere, con lo sguardo fisso verso i campi e i boschi che costeggiano la carreggiata, a rimirare la natura e io me li immagino con uno sguardo fisso ma beato, sereno, un sorriso di soddisfazione sulle labbra e le palpebre semi chiuse. Se una mattina non ne incontrassi almeno quattro o cinque lungo il percorso sarei preoccupato, che fosse scoppiata la guerra? Oppure l’apertura della caccia? Nel cinema la scena cult è sicuramente quella del “Piccolo Diavolo” dove Benigni è alle prese con una minzione un po’ bizzarra, semplicemente geniale nell’ innaffiata. Nel mio peregrinare per le varie province di questa nostra Padania afosa e nebbiosa, intesa solo come entità geografica e non politica, quella la lasciamo al Magno Umberto, e poiché per motivi miei etici e di pudore non mi libero mai in campagna a meno che non ne sia fortemente costretto, mi sono fatto una mappa di dove posso farla. Solitamente la mia scelta cade sui i centri commerciali o gli autogril, dove questi luoghi di decenza sono solitamente e dignitosamente puliti; dove quasi sempre nell’atrio c’è una gentile e sorridente signora seduta davanti ad un piattino con qualche moneta che mi ricorda il donnone che stava ai cessi pubblici della stazione di Voghera. Tutti siamo potenziali pisseur, quelli che bevono birra e frequentano le varie feste simil tedesche e poi si liberano beatamente lungo i fossi che circondano questi spazi festaioli, o quelli che, soggiornando in luoghi salubri e termali come Fiuggi o Lurisia, lo diventano d’ufficio e dove, mi è stato riferito, il pensiero incalzante e ricorrente di questi frequentatori è calcolare la distanza che li separa da un vespasiano, della serie: facciamo due passi ma non allontaniamoci troppo. Sempre a proposito di pisseur una volta o assistito ad una scena da una lato comica se non fosse per quello che in realtà nascondeva: un signore anziano nella necessità impellente di liberare la vescica si era messo in disparte contro il muro di un palazzo quando, dal portone, è uscito un giovanotto che ha cominciato ad inveire ed insultare l’anziano pisseur, con parole anche molto pesanti, ad un tratto una signora, che poi si è rivelata la moglie dell’anziano, ha cominciato a prendere a borsettate l’insultatore, riversando su di lui le medesime pesanti parole: “Ma si vergogni lei a mancare di rispetto ad un anziano incontinente, cialtrone, maleducato, mio marito soffre di…… (non mi ricordo le esatte parole n.d.r.) le auguro capitasse anche a lei quando sarà vecchio ecc. ecc.” Che dire…, una volta c’erano i monumenti dedicati all’Imperatore Vespasiano (pecunia non olet), che fiorivano nelle nostre città, poi per motivi di decenza (sigh! oggi c’è ben altro di indecente) furono tolti come se improvvisamente ai pisseur avessero imposto la chiusura dei rubinetti: “basta!! non fate più pipì oppure fatela a casa vostra”. Restano in qualche raro posto servizi igienici a gettone, che però non funzionano mai e se ti scappa devi aspettare di essere in autostrada, all’autogrill dove, se non altro, c’è una sorridente signora che sembra augurarti “La faccia tutta mi raccomando”.Sempre per bontà vostra. GIU.BA.
COME LA LUNA A MAGGIO: PENSIERI E PAROLE
"Non condivido le tue idee, ma darei la vita per permetterti di esprimerle" oppure:"Disapprovo ciò che dici ma difenderò sino alla morte il tuo diritto di dirlo".
Frase attribuita a Voltaire alias Francois Marie Aruet, filosofo francese vissuto nel '700, ma che forse fu detta (o scritta) da tale Evelin Beatrice Hall, scrittrice inglese più nota con lo pseudomino di Stephen G. Tallentyre.
Ma la domanda che faccio è ben altra:" Tu faresti altrettanto per me?"
Meditate gente meditate (R.Arbore)
Sempre per bontà vostra
GIUBA
Voltaire
Era già l’ora che volge il disio ai navicanti e ‘ntenerisce il core lo dì c’ han detto ai dolci amici addio;e che lo novo peregrin d’amore punge, se ode squilla di lontano che paia il giorno pianger che si more; Purgatorio, VIII, 1-6
Ufficiale della Legion d'Onore all'Ing.Paolo Baratta.
Legion d'onore a Paolo Baratta. In questi giorni a Palazzo Farnese a Roma, sede dell'Ambasciata di Francia, l'ambasciatore Masset ha consegnato all'Ing.Paolo Baratta, presidente della Biennale di Venezia e di conseguenza della Mostra del Cinema, l'onorificenza massima della Repubblica transalpina ovvero la Legion d'Onore. Mi corre l'obbligo ricordare che all'Ing. Paolo Baratta, nel 2015, è stato consegnato il Talento d'Oro della Città di Casteggio nel corso della serata "A cena con l'opera" che si svolse presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Paolo Baratta ha un legame privilegiato con Casteggio dove vive il fratello e dove entrambi hanno una azienda agricola in quel di Via Battini. Il sottoscritto quella sera fu la voce narrante della manifestazione. Ricordo una frase del discorso di ringraziamento dell'ing. Baratta, infatti disse:" Siamo tutti figli della stessa vigna". Ora non so se l'Ing. Baratta ha la cittadinanza/residenza a Casteggio, ma se non l'avesse sarebbe cosa buona e giusta offrirgli la cittadinanza onoraria. Una carriera segnata da un impegno civile costante, ha saputo ridare alla Biennale di Venezia un posto centrale nella vita culturale del nostro paese ma anche a livello internazionale, diventando un laboratorio di esperienze e capacità culturali di altissimo livello.
G.B.
Capito perchè si chiama Estremadura!?!? Ne ombra ne acqua.
Condividi questa pagina























![MILLE LIRE Dopo aver scritto “Gli indomabili” su questo blog, ho cominciato ad interessarmi alla epopea dei nativi americani, i pellerossa, gli indiani insomma. Nella mia personale biblioteca fortunatamente esistono alcuni libri che trattano questo argomento, alcuni letti, altri non ancora letti. L’altra sera alla ricerca di un buon volume da leggere mi sono imbattuto nel libro di Dee Brown “Seppellite il mio cuore a Wounded Knee” che non avevo mai letto e che probabilmente, anzi certamente, lo aveva acquistato mia figlia da leggere in treno quando faceva la pendolare su Milano. Mentre lo sfogliavo dalle pagine sono scivolati fuori due reperti: un biglietto del metrò datato 12 febbraio 1997 e un biglietto da mille lire. Immediatamente quando capita di leggere una data su di un documento alla mente viene subito da pensare :” dove ero in quel giorno?” Io ero a Piacenza dove facevo di tutto per garantire il vitto e l’alloggio (e varie altre cose) agli studenti della Cattolica di quella sede. Ma la banconota mi ha fatto tornare anche in mente quando, indegnamente capo scout, organizzavo i campi per quei simpatici pargoletti, più che altro ragazzotti, in estate o a settembre poco prima dell'inizio dell'anno scolastico. I genitori che mi affidavano questa ciurma di scalmanati, mi avevano affibbiato il soprannome di “Mille lire lungo” perché riuscivo a far quadrare i conti con mille lire al giorno. Io di mestiere, quello vero, ho sempre fatto l’economo, parola desueta oggi indicante chi in un ufficio, in un ente, in una comunità, ha l'incarico di amministrare determinate spese, di provvedere al necessario, oggi si potrebbe identificare come “responsabile degli affari generali” appunto di un ente/comunità. Un Dirigente un giorno mi fece un complimento che io apprezzai anche se era detto in tono tra il serio ed il faceto chiamandomi “Prefetto all’annona” [Il praefectus annonae (prefetto al vettovagliamento) era un funzionario equestre dell'antica Roma preposto alla supervisione dei rifornimenti di grano, istituito intorno al 7 a.C. da Augusto il quale aveva assunto il ruolo di curator annonae dopo la crisi annonaria del 22 a.C. 21 a.C.].Riuscivo con quella cifra a dar da mangiare e da bere tre volte al giorno a tutta la truppa compreso il viaggio in bus da Voghera alla vicina Alta Valle Staffora. Certo non era caviale e champagne, ma un primo abbondante, un secondo con contorno e frutta fresca, non mancavano i biscotti a colazione, latte e caffè e anche della marmellata. Mi rifornivo da grossisti conosciuti e in qualche caso anche generosi, ma anche i piccoli negozi della valle erano generosi nei confronti dei ragazzi, anche se qualcuno non propriamente padrone della lingua ci chiamava “teddy boy” anziché boy scout. Si faceva buon viso correggendo il personaggio per poi fare anche qualche risata. Mille lire scivolate dalle pagine di un libro, un caso fortuito, riportate alla luce come un reperto storico, archeologico, ma che hanno dato la stura a mille ricordi assolutamente piacevoli. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. Nota a margine: Meno piacevole il ricordo del 29 dicembre 1890 giorno in cui avvenne l’eccidio di Wounded Knee, luogo dove il 7° Cavalleggeri sterminò una comunità di indiani Miniconjou appartenenti alla tribù dei Lakota Sioux. Dei pellerossa presenti ne morirono quasi 300 di 350 tra cui donne vecchi e bambini. Morirono anche 25 giacche blu, probabilmente colpite da fuoco amico. Sopravvissero in 51, 4 uomini e 47 fra donne e bambini. In occasione della campagna militare del 1890 in cui avvenne il massacro, vennero insigniti venti soldati, che vi avevano partecipato, della medaglia d'onore, la massima onorificenza conferita dall'esercito degli Stati Uniti. Nel 2001 il Congresso Nazionale degli Indiani d'America emanò due risoluzioni che condannavano la consegna di queste medaglie, soprannominate da alcuni attivisti le MILLE LIRE Dopo aver scritto “Gli indomabili” su questo blog, ho cominciato ad interessarmi alla epopea dei nativi americani, i pellerossa, gli indiani insomma. Nella mia personale biblioteca fortunatamente esistono alcuni libri che trattano questo argomento, alcuni letti, altri non ancora letti. L’altra sera alla ricerca di un buon volume da leggere mi sono imbattuto nel libro di Dee Brown “Seppellite il mio cuore a Wounded Knee” che non avevo mai letto e che probabilmente, anzi certamente, lo aveva acquistato mia figlia da leggere in treno quando faceva la pendolare su Milano. Mentre lo sfogliavo dalle pagine sono scivolati fuori due reperti: un biglietto del metrò datato 12 febbraio 1997 e un biglietto da mille lire. Immediatamente quando capita di leggere una data su di un documento alla mente viene subito da pensare :” dove ero in quel giorno?” Io ero a Piacenza dove facevo di tutto per garantire il vitto e l’alloggio (e varie altre cose) agli studenti della Cattolica di quella sede. Ma la banconota mi ha fatto tornare anche in mente quando, indegnamente capo scout, organizzavo i campi per quei simpatici pargoletti, più che altro ragazzotti, in estate o a settembre poco prima dell'inizio dell'anno scolastico. I genitori che mi affidavano questa ciurma di scalmanati, mi avevano affibbiato il soprannome di “Mille lire lungo” perché riuscivo a far quadrare i conti con mille lire al giorno. Io di mestiere, quello vero, ho sempre fatto l’economo, parola desueta oggi indicante chi in un ufficio, in un ente, in una comunità, ha l'incarico di amministrare determinate spese, di provvedere al necessario, oggi si potrebbe identificare come “responsabile degli affari generali” appunto di un ente/comunità. Un Dirigente un giorno mi fece un complimento che io apprezzai anche se era detto in tono tra il serio ed il faceto chiamandomi “Prefetto all’annona” [Il praefectus annonae (prefetto al vettovagliamento) era un funzionario equestre dell'antica Roma preposto alla supervisione dei rifornimenti di grano, istituito intorno al 7 a.C. da Augusto il quale aveva assunto il ruolo di curator annonae dopo la crisi annonaria del 22 a.C. 21 a.C.].Riuscivo con quella cifra a dar da mangiare e da bere tre volte al giorno a tutta la truppa compreso il viaggio in bus da Voghera alla vicina Alta Valle Staffora. Certo non era caviale e champagne, ma un primo abbondante, un secondo con contorno e frutta fresca, non mancavano i biscotti a colazione, latte e caffè e anche della marmellata. Mi rifornivo da grossisti conosciuti e in qualche caso anche generosi, ma anche i piccoli negozi della valle erano generosi nei confronti dei ragazzi, anche se qualcuno non propriamente padrone della lingua ci chiamava “teddy boy” anziché boy scout. Si faceva buon viso correggendo il personaggio per poi fare anche qualche risata. Mille lire scivolate dalle pagine di un libro, un caso fortuito, riportate alla luce come un reperto storico, archeologico, ma che hanno dato la stura a mille ricordi assolutamente piacevoli. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. Nota a margine: Meno piacevole il ricordo del 29 dicembre 1890 giorno in cui avvenne l’eccidio di Wounded Knee, luogo dove il 7° Cavalleggeri sterminò una comunità di indiani Miniconjou appartenenti alla tribù dei Lakota Sioux. Dei pellerossa presenti ne morirono quasi 300 di 350 tra cui donne vecchi e bambini. Morirono anche 25 giacche blu, probabilmente colpite da fuoco amico. Sopravvissero in 51, 4 uomini e 47 fra donne e bambini. In occasione della campagna militare del 1890 in cui avvenne il massacro, vennero insigniti venti soldati, che vi avevano partecipato, della medaglia d'onore, la massima onorificenza conferita dall'esercito degli Stati Uniti. Nel 2001 il Congresso Nazionale degli Indiani d'America emanò due risoluzioni che condannavano la consegna di queste medaglie, soprannominate da alcuni attivisti le](/____impro/1/onewebmedia/i282600889677630826.jpg?etag=%221b68c-5db44839af051%22&sourceContentType=&ignoreAspectRatio&resize=302%2B167&extract=0%2B0%2B302%2B166)